Sei su Archivio / LIBRI_HTML / Utopia della memoria
CAPITOLO 1
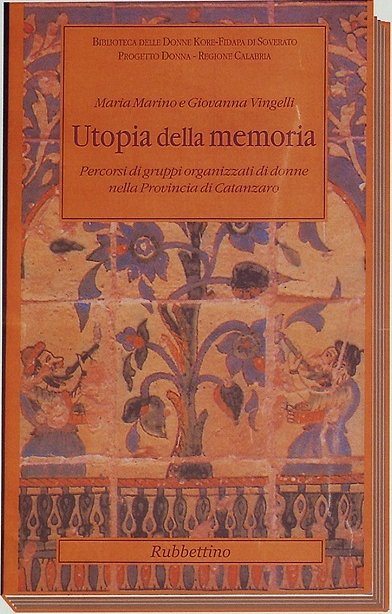
Biblioteca delle donne
Kore-Fidapa
di Soverato
Progetto
Donna - Regione Calabria
PERCORSI
DI
GRUPPI ORGANIZZATI DI DONNE NELLA PROVINCIA DI CATANZARO
Maria
Marino
Giovanna
Vingelli
Introduzione
di Amelia Paparazzo
Postfazione
di Renate Siebert
«...io
voglio comprendere. E quando altri comprendono nello stesso modo in
cui io ho compreso – allora provo una soddisfazione comparabile
a quella che si prova quando ci si sente a casa propria».
Hannah
Arendt, Munchen 1976.
Con le parole di Arendt
vogliamo esprimere motivazione e senso del luogo che dieci anni fa
abbiamo costruito e indicato col nome di Biblioteca delle Donne di
Soverato.
Così
anche la ricerca che presentiamo in questo testo trova la sua
giustificazione primaria nella pre-sunzione di voler
comprendere/comunicare in una sorta di progressivo avvitamento a
spirale via via più ampia. La difficoltà è
trovare il modo di comunicare con le giovani, l’urgenza è
comprendere insieme, la speranza è costruire luoghi sempre più
capienti in cui potersi sentire finalmente a casa.
La ricerca, condotta sui
gruppi organizzati di donne nella provincia di Catanzaro a partire
dagli anni ’60 e fino alle soglie del 2000, non ha la pretesa
di esaurire i contributi prodotti dalle associazioni nel territorio
nè di spiegare i motivi che hanno spinto tante a costruire
luoghi di aggregazione tutti al femminile. Piuttosto vuole dare conto
di una realtà che, più o meno consapevolmente e al di
là della diversità dei percorsi, ha ritenuto che lo
strumento per cambiare l’esistente fosse da ricercare nel luogo
separato capace di accomunare esperienze, necessità,
linguaggi.
La
ricerca è stata finanziata dal Progetto Donna della Regione
Calabria ed è dedicata alle giovani, alle quali vogliamo
offrire la trasmissione di una passione che ha segnato e cambiato la
vita alle loro nonne e madri, e alle loro docenti che erano giovani
quaranta o trenta anni fa, mai rassegnate a dover vivere nei confini
per loro tracciati.
E’ per posizionare
frontalmente il loro sguardo e per rendere il testo più
fruibile nella trasmissione, che abbiamo scelto di affidare la
ricerca e la stesura della pubblicazione a due giovani, indicate
dalle docenti dell’Università della Calabria cui ci
siamo rivolte. Il materiale documentale è stato recuperato per
la gran parte, a cura della Biblioteca, nelle case delle amiche
intervistate; a volte reperito da Maria Marino a Roma nell’Archivio
Nazionale dell’Unione Donne Italiane o nella Biblioteca
Nazionale, oppure negli archivi dei quotidiani locali o in quelli dei
partiti. In assenza di documenti in nostro possesso abbiamo
ricostruito eventi sulle interviste fatte alle protagoniste degli
avvenimenti, come nel caso di Federcasalinghe o del Centro Italiano
Femminile-CIF di Catanzaro, chiuso nel ’92 e il cui archivio è
andato distrutto a causa di un incendio. Le interviste sono state
condotte da Giovanna Vingelli e solo in qualche caso da Marino,
quando si è data la necessità di ricostruire una
storia di cui si disponeva solo di traccia orale. I primi tre
capitoli, curati da Marino, ricostruiscono gli avvenimenti; il
quarto, curato da Vingelli, è una ricerca di senso in cui le
vicende collettive si intrecciano alle emozioni delle singole
segnando arresti e riprese, comunque in un percorso senza fine. Così
almeno ci sembra o comunque è ciò che ci auguriamo
possa sembrare.
Ringraziamo:
Simona
Dalla Chiesa per avere avviato un percorso inedito di pari
opportunità nella Regione Calabria, il Progetto Donna;
Rosa
Tavella per averlo coordinato valorizzando il contributo delle
associazioni e consentendo la realizzazione delle due Biblioteche
delle Donne esistenti in Calabria;
Luciana
Curcio per avere accompagnato dall’inizio ad oggi il Progetto
Donna con la competenza che, ai compiti del ruolo burocratico,
aggiunge accoglienza, attenzione e coinvolgimento;
Adriana Papaleo ed Annamaria
Riccio per avere generosamente sostenuto la Biblioteca delle Donne di
Soverato sin dalla sua nascita, mettendo a disposizione esperienza e
relazioni;
Maddalena
Basile, insieme al coordinamento del Progetto Donna da lei
presieduto, per avere concesso il finanziamento necessario alla
presente ricerca;
Annalisa
Marino per i suggerimenti riguardo modalità e finalità
del lavoro progettuale e per il coinvolgimento nella ricerca
documentale presso l’ archivio nazionale dell’UDI;
Donatella
Barazzetti, Amelia Paparazzo, Renate Siebert, le docenti
dell’Università degli Studi della Calabria che hanno
reso possibile il lavoro di ricerca offrendo competenze e sensibilità
nel superare i mille ostacoli e difficoltà dell’impresa;
Giovanna
Vingelli e Maria Marino per avere curato la ricerca con l’iniziale
curiosità delle giovani e la progressiva comprensione delle
vicende che dalla presa di coscienza condussero alla passione
politica;
Le
amiche coinvolte sin dall’inizio nella ricerca e tutte quelle,
numerosissime, che sono state contattate nel momento in cui
emergevano nomi e documenti ad arricchire una storia che non doveva
essere dimenticata.
Le
fondatrici della Biblioteca delle donne di Soverato
Introduzione
Nella
storia della Calabria – nell’Ottocento come nel Novecento
– le donne hanno ricoperto un ruolo tutt’altro che
marginale e secondario. In particolar modo quelle appartenenti ai
ceti subalterni e alle classi lavoratrici in genere. E’ così,
ad esempio, nel periodo della grande emigrazione verso i paesi
d’oltre oceano o negli anni che dallo sbarco degli alleati in
Sicilia e Calabria arrivano alle occupazioni delle terre o ancora
nelle lotte portate avanti dalle raccoglitrici di olive negli anni
Cinquanta e Sessanta (di cui si parla più avanti in questo
testo) e così via.
Tuttavia,
il ruolo sociale rilevante svolto dalle donne non le sottrae ad una
condizione di subalternità, anzi di doppia subalternità.
La donna è subalterna, una prima volta, in quanto appartiene a
determinati ceti sociali e, una seconda volta, perché
costretta a subire una cultura intrisa di valori esclusivamente
maschili.
Per
dare il senso di quali potessero essere il ruolo e la condizione
delle donne in Calabria conviene soffermarsi su uno dei periodi
storici cui si è fatto riferimento. Negli anni del grande
esodo verso le Americhe, le donne impossibilitate, per povertà
o per altri problemi familiari, a seguire mariti, padri o fratelli,
sulla via dell’emigrazione, svolgono una funzione sociale
estremamente rilevante proprio in quanto costrette a sostituirsi ai
“loro uomini”. A vari livelli ciò avviene:
all’interno della famiglia, le donne educano i figli,
provvedono ai problemi delle persone anziane rimaste in casa,
amministrano le rimesse inviate dal familiare lontano, ecc.; nel
sociale, sostituiscono gli uomini nelle prestazioni lavorative così
come nell’adempimento quasi inevitabile di quei reati (piccoli
furti campestri, soprattutto) che consentono alla donna di rendere
meno drammatica l’esistenza sua e delle parti più deboli
della famiglia rimasta in patria (vecchi, bambini). Basti un solo
esempio, a tal proposito. Negli archivi di stato della regione sono
conservati gli atti di centinaia e centinaia di processi intentati
dalle varie preture a donne accusate di non aver ottemperato alle
leggi sulle privative. Il reato commesso consisteva nell’essersi
esse recate sulle rive del mare con secchi e contenitori vari e
nell’aver raccolto acqua marina, che veniva messa
successivamente ad essiccare: questo era l’unico modo per
ricavare il sale, alimento fondamentale nella dieta del gruppo
familiare perchè utile per la prevenzione delle epidemie
coleriche.
Quest’indispensabile
funzione lavorativa e sociale non verrà, però,
apprezzata e riconosciuta come tale. Il lavoro femminile, nei campi,
nell’edilizia o nelle manifatture tessili, continuerà a
non essere equiparato a quello degli uomini. Esso seguiterà ad
essere considerato non qualificato e, perciò, riceverà
una “mercede” inferiore: sarà cioè
sottopagato.
L’impiego
scarsamente remunerato della manodopera femminile (a cui si
aggiungeva quella minorile) diverrà talmente ampio e
generalizzato che nel 1918 gli estensori della Relazione annuale
della Camera di commercio di Cosenza, rispondendo ad una pressante
nota inviata dal Ministero dell’interno, saranno costretti a
riconoscere che nel cosentino e nel catanzarese non esisteva forza
lavoro disponibile per essere impiegata nei vari settori produttivi,
in quanto donne, bambini ed anche vecchi, da anni già vi
lavoravano, poiché avevano sostituito in quelle mansioni gli
uomini adulti emigrati.
Ma
le donne della provincia di Catanzaro, e più in generale
quelle di tutta la Calabria, spinte dalle loro condizioni di
precarietà e povertà, diverranno anche protagoniste e
avranno una forte incidenza all’interno di fenomeni di protesta
sociale e di organizzazione di momenti di dissenso. Non vi sono,
negli anni qui analizzati, manifestazioni o situazioni di scontro
politico pacifico o violento – incendi di case comunali,
assalti di municipi o di catasti, occupazioni di terre, ecc. –
che non registrino la partecipazione delle donne.
La
propensione alla mobilitazione e alla partecipazione ad episodi di
scontro sociale riprenderà alla fine del dominio fascista
nella regione. Con maggiore slancio e durezza, saranno le donne ad
inaugurare un ciclo di lotte che dalle campagne si estenderà
ai centri urbani. Le dissennate linee politiche del fascismo per il
Mezzogiorno, in primo luogo il blocco dell’emigrazione e la
“battaglia del grano”, aumentando i livelli della forza
lavoro sottoutilizzata e disoccupata, avevano provocato una
diminuzione del già basso reddito procapite. Tutto ciò
determinava un abbassamento del tenore di vita delle popolazioni,
innescando volontà rivendicative e bisogni di riscatto.
In
questo contesto ancora una volta le donne si porranno
all’avanguardia. La prima manifestazione di protesta
verificatasi nella città di Catanzaro avrà come
protagoniste proprio le donne. Agli inizi del dicembre del 1943 (da
pochissimi mesi nella regione si era verificato lo sbarco alleato)
esse decisero di mobilitarsi, scendendo in piazza più volte
per chiedere “sussidi, indennità, pane”. Già
nelle campagne, però, soprattutto nel crotonese e in alcune
zone del reggino e della provincia di Cosenza, erano iniziati fin dal
’42 fenomeni spontanei di occupazione delle terre che avevano
visto la partecipazione di donne, ragazzi e bambini. Da allora e fino
agli anni della riforma agraria (1950), tutta la famiglia contadina
povera (braccianti, piccoli fittavoli, ecc.) darà vita al più
vasto movimento di massa verificatosi in quegli anni nell’intero
Paese.
Solo
una riflessione su una fase storica su cui tanto si è scritto
e su cui non è il caso di soffermarsi in questa circostanza.
Sei sono le persone uccise durante gli anni delle agitazioni per la
terra in Calabria, fra queste tre donne: Giuditta Levato nel ’46
a Calabricata, Isabella Carvelli nel ’47 a Petilia Policastro,
Angelina Mauro nel ’49 a Melissa. Ciò a testimoniare il
significato della mobilitazione femminile.
Questa
capacità di organizzarsi, di proporsi come elemento
fondamentale per l’affermazione sia di principi di eguaglianza
più generali (si vedano a tal riguardo i documenti prodotti
dall’Unione donne italiane), che specificamente rivendicativi
(le lotte per incrementi salariali, per migliori condizioni di lavoro
e parità di trattamento), si riproporrà anche in
periodi successivi.
Si
pensi al ’68 che, ad esempio, nel catanzarese vedrà una
partecipazione paritaria di donne e di uomini in un contesto sociale
e culturale in via di profonda trasformazione e in cui la
scolarizzazione aveva ormai investito strati sociali diversificati,
allargandosi come mai prima alla presenza dell’elemento
femminile. Inoltre, comportamenti, costumi, stili di vita, simili,
cominceranno, progressivamente, ad unificare donne e uomini di
estrazione socio-economica diversa. Il Sessantotto nelle città
calabresi sarà il frutto di questa crescita individuale e
collettiva.
Ed
è proprio durante i mesi della rivolta studentesca, prima, e
dell’incontro politico fra gli studenti e gli operai, poi, che
le donne, così come stava avvenendo in tutta Italia,
inizieranno a proporsi tematiche più autonome dal movimento e
maggiormente legate alla propria condizione femminile. Saranno
proprio le studentesse universitarie e le giovani laureate ad
inaugurare in Italia questa svolta. Il modello di orientamento sarà
offerto dalle esperienze vissute e concettualmente elaborate da
gruppi di donne negli Stati Uniti a metà degli anni Sessanta.
In
un saggio del 1969, Carla Ravaioli scrive: <<Aperte tutte le
carriere. Raggiungibile qualsiasi grado del sistema
economico-politico. Ogni funzione, anche della massima
responsabilità, aggiudicabile. Insindacabili garanti gli
ordinamenti istituzionali e giuridici, questo è oggi possibile
alla donna in tutti i paesi più avanzati. In Italia come
altrove, o quasi. Gli strumenti fondamentali dell’emancipazione
femminile sono dunque ormai una realtà: ma fino a che punto e
in che modo utilizzati?>> ( La
donna contro se stessa,
Bari 1969, p.5 ).
Allora
come oggi, questo punto interrogativo finale si riempie di contenuti
sempre diversi ed esprime problematiche tutt’altro che risolte.
Bisogna
in ogni caso rilevare – come fa lo storico Paul Ginsborg –
che <<nella seconda metà del XX secolo, in molte parti
del mondo, seppur non tutte, la ferrea morsa del predominio maschile
si è allentata. Di fronte alla mobilitazione del movimento
femminista, con il diffondersi dell’istruzione femminile, con
il mutamento delle condizioni del mercato del lavoro internazionale,
gli uomini sono arretrati di posizione. Hanno visto limitare i loro
poteri legali. Sono passati, come suggerisce una storia della
famiglia europea, dal patriarcato al partenariato>>. Questa
osservazione contenuta nel volume Il
tempo di cambiare. Politica e potere della vita quotidiana
(Torino 2004, p.18), viene ridimensionata dallo storico inglese nel
prosieguo delle sue argomentazioni: <<Il potere maschile assume
ora
tinte diverse, più accomodanti e più egalitarie, ma
molto della sua essenza resta>>. Tale permanenza è
rinvenibile non solo nei rapporti uomo-donna nel terzo mondo, ma
anche nel democratico mondo occidentale.
Se
analizziamo alcuni indici statistici sui “progressi”
raggiunti dalle donne nei paesi industrializzati e li compariamo con
altri sulle “privazioni” che esse ancora subiscono,
meglio si chiariscono i termini del protrarsi di disparità di
genere.
Le
donne rappresentano più del 40% della forza lavoro e occupano
circa un quarto delle posizioni amministrative e manageriali (i dati
appena citati e quelli che seguiranno sono elaborati e pubblicati in
Undp, Rapporto
sullo sviluppo umano, Torino
1996, n,7, che fornisce, assieme al Rapporto dell’anno
precedente, alcune delle più accurate rilevazioni statistiche
disponibili). Esse percepiscono, però, solo due terzi del
salario maschile e occupano il 12% dei seggi parlamentari (nei paesi
sottosviluppati questo dato scende al 10%). C’è da
segnalare, poi, che nei paesi ricchi annualmente vengono registrati
130.000 stupri a donne fra i quindici e i cinquantanove anni. Negli
anni Ottanta del Novecento la metà, o più della metà,
di tutti gli studenti – a vari livelli di scolarizzazione –
erano donne negli Stati Uniti, in Canada e in sei paesi
ex-socialisti, con in testa la Germania dell’est e la Bulgaria.
In solo quattro paesi europei le donne scolarizzate nella stessa data
erano meno del 40% : Grecia, Svizzera, Turchia e Regno Unito.
Sempre
gli estensori del Rapporto
sullo sviluppo umano del
’96 affermano che <<lo spazio politico è sempre
stato monopolizzato dagli uomini. Sebbene le donne rappresentino,
infatti, la metà dell’elettorato, esse detengono –
come si è già accennato – solo il 12% dei seggi
parlamentari e il 6% dei ministeri nazionali. Le donne sono
relativamente meglio rappresentate a livello locale. In 46 paesi la
rappresentanza femminile nei governi locali supera la presenza nei
parlamenti nazionali. Nel 1944 l’India ha riservato un terzo
dei seggi della Panchayat (consiglio locale) alle donne, con il
risultato che 800mila di esse entrano nella conduzione politica
locale da cui emergono i leaders politici nazionali>>.
Se
dai paesi industrializzati si passa a quelli in via di sviluppo,
l’aggravarsi delle condizioni generali dell’intera area
si ripercuote in maniera drammatica sulle donne. Anche per alcune di
queste realtà territoriali è bene segnalare qualche
dato. Nei paesi del terzo mondo, la mortalità materna è
12 volte più alta che nei paesi industrializzati raccolti
nell’OCSE; nell’Asia dell’Est più di un
milione di donne sono analfabete; nell’Asia del Sud, circa
l’80% delle donne soffre, in gravidanza, di anemia (il più
alto tasso al mondo); nell’Africa Sub-sahariana ad ogni quattro
uomini contagiati dall’HIV corrispondono sei donne affette
dallo stesso male. Inoltre, nella stessa area territoriale solo l’8%
dei seggi parlamentari è da esse ricoperto.
A
conclusione di queste note, e utilizzando ancora una volta quanto
sostiene Paul Ginsborg nel testo già citato, si può
affermare che << a tutt’oggi la povertà globale ha
volto femminile: su 1.3 miliardi di poveri, il 70% sono donne. Un
confronto tra il rapporto femmine/maschi nel Nord e in gran parte del
Sud del globo ha evidenziato un deficit di 100 milioni di donne del
Sud: questo dato complesso è rivelatore di un processo tragico
e occulto di cui le nascite selettive a favore dei maschi e la
malnutrizione delle bambine forniscono i principali elementi
esplicativi>>.
A
causa della constatazione di queste e di altre condizioni di
diversità di genere e della consapevolezza delle
disuguaglianze e delle vessazioni di ogni tipo subite dalle donne a
livello mondiale, il movimento femminista modifica alcuni degli
obbiettivi fondamentali della sua azione. Non più
l’uguaglianza con gli uomini e il trattamento paritario vengono
perseguiti. Il centro della elaborazione del movimento diviene la
differenza sessuale dagli uomini. È ormai chiaro che le
condizioni di inferiorità delle donne, in particolar modo di
quelle appartenenti ai paesi poveri, sono connesse al loro essere
differenti, sessualmente, dagli uomini.
<<…
nei secoli
la donna
ha visto l’uomo proclamare il regno dello spirito e della
ragione, sapendo di essere lei la garante del suo ritorno alla
natura e all’immanenza – e lo ha lasciato parlare; per
secoli è stata testimone delle sue regressioni, lasciandogli
l’illusione che lei non avesse bisogni, e che, anzi, fosse
contenta di ciò che l’uomo non dava; per secoli ha
garantito la vita che l’uomo intanto uccideva […];
testimone scomoda e sgradita la donna porta in sé una forza
non ancora intaccata: è la forza di un giudizio legato alle
cose, alle esperienze concrete di vita, che non si lascia smentire
dalle parole o dalle astrazioni. A questa intelligenza – che
conserva ancora fusi e inestricabilmente intrecciati il giudizio
sulle cose concrete, l’emozione che provocano, la sensualità
di un corpo che è in esse immerso e delle quali fa parte, la
tenerezza nei confronti della vita e l’antica saggezza nei
confronti della morte – a questa intelligenza è stato
dato il nome deteriore di “intuizione femminile”, per
riportarla nel regno della natura. Ma è questa intelligenza
che al momento attuale potrebbe dire parole nuove e fare nuovi gesti,
perché […] essa resta legata alle cose, alle
esperienze, alla natura, al corpo, attraverso i quali continua ad
esprimersi e con i quali l’uomo ha oramai perduto ogni
rapporto>>. Penso che le osservazioni contenute in queste
parole di Gabriella Gribaudi – nella voce Donna
dell’Enciclopedia
Einaudi – meglio di ogni altra cosa possano far comprendere la
complessità e la grande diversificazione delle elaborazioni
femministe sulle strategie e sugli obiettivi del movimento delle
donne nel mondo contemporaneo.
Questa succinta mia
presentazione di rilevazioni statistiche e annotazioni relative alla
condizione femminile in Calabria e nel mondo, ha inteso delineare, in
estrema sintesi, il quadro storico all’interno del quale si
muovono le analisi di Maria Marino e Giovanna Vingelli, le quali
raccontano, seguendo percorsi di indagine diversi, come nel ventennio
‘70-’90 del secolo passato il movimento femminista, in
alcune realtà del catanzarese, cresce e si diffonde. Per la
conduzione della ricerca le due autrici si sono avvalse sia del
materiale documentario rinvenuto presso le protagoniste del movimento
o presso sedi di gruppi e di organizzazioni femminili, sia delle
testimonianze dirette, che hanno consentito una ricostruzione delle
vicende e delle diverse posizioni emergenti all’interno dei
vari gruppi. Ne viene fuori uno schizzo significativo e complesso
delle difficoltà e dei problemi delle donne all’interno
di una realtà particolare, ma tutt’altro che chiusa,
quale è quella della provincia di Catanzaro.
Amelia
Paparazzo
CAPITOLO
1
LE
PRIME FORME ORGANIZZATIVE
di
Maria Marino
“Così,
nel 1949-1950 le donne si mossero alla testa dei cortei dei
braccianti che andavano a occupare le terre dei baroni. Esse
partecipavano a queste lotte perché vedevano realizzabile la
conquista di un progresso sociale che, col possesso della terra,
avrebbe portato più case, più scuole, più
indumenti, più cibo. Giuditta Levato e Angelina Mauro, le
eroine che caddero allora sotto il piombo della polizia, sono
diventate il simbolo della lavoratrice meridionale della nostra
epoca“.
L.
Viviani, Il
lavoro femminile nella società meridionale,
«Cronache meridionali», n.6, giugno 1950
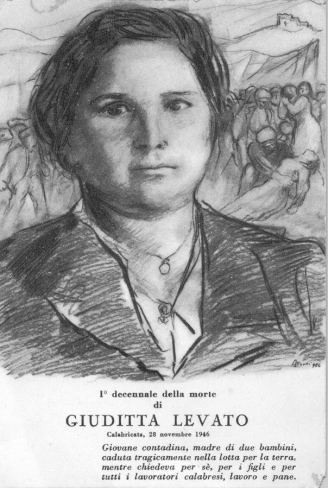
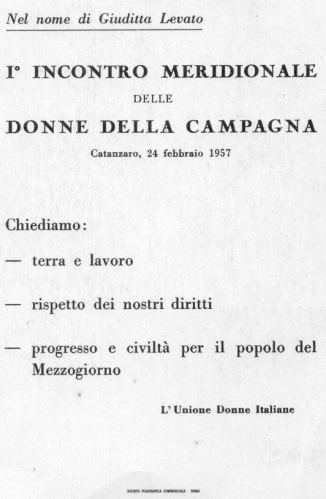
Premessa
E’
Anna Rossi Doria a sottolineare come i nuovi spazi istituzionali a
cui le donne cominciano a poter aver accesso assumono un grande
valore simbolico : «Votare
ed essere elette non significava solo entrare in una scena fino ad
allora esclusivamente maschile, ma anche rompere divieti interiori e
riuscire a sentirsi cittadine senza per questo dimenticare di essere
donne: dimostrarsi pari agli uomini, dunque, ma anche diverse da
loro. Per questo la nuova identità individuale legata alla
conquista dei diritti politici si saldava fortemente ad un’identità
femminile collettiva»
A
dare appoggio al fermento che in questi anni cresce nel mondo del
lavoro femminile sono in effetti anche una serie di interventi in
campo legislativo che, seppur nell’assenza di quella che oggi
chiameremmo una “consapevolezza di genere”, hanno origine
da questa prima forma di associazionismo femminile.
Le
lotte delle donne lavoratrici negli anni Cinquanta infatti,
anticipano l’acquisizione del concetto di diritto e permettono
di fare uno straordinario passo in avanti all’intera società
civile.
Per
la prima volta, nel 1950, è riconosciuto il diritto di tutela
della lavoratrice in quanto madre. Viene approvata dal Parlamento
italiano la Legge n. 860 del 19 Luglio 1950 sulla "tutela fisica
ed economica della lavoratrice madre": 3 mesi di riposo prima
del parto ed 8 settimane dopo il parto retribuiti con l'80% del
salario, divieto di licenziamento fino al compimento del 1° anno
di età del bambino.
È
questa la prima tappa di un lungo percorso: nel 1961 le donne
ottengono che venga riconosciuto il loro diritto ad essere retribuite
come gli uomini; si compie, così, un primo passo che poi
aprirà il varco agli aumenti salariali e all’inquadramento
unico tra impiegati e operai.
Nel
1962 viene stabilito il divieto di licenziamento a causa di
matrimonio, una conquista che getta le basi per il diritto di tutti i
lavoratori a non essere licenziati senza giusta causa. Nello stesso
anno si stabilisce anche l’accesso a tutte le carriere.
L’UDI in Calabria è
tra le prime organizzazioni che comprende l’importanza delle
problematiche del lavoro femminile e per questo, già a metà
degli anni ’50, decide di farle diventare centrali all’interno
della sua attività; a questo scopo l’ Udi organizza “il
primo incontro meridionale delle donne della campagna”
avvenuto a Catanzaro nel febbraio 1957, partecipa alla Commissione di
inchiesta promossa dal Comitato di Associazioni femminili per la
parità di retribuzione, promuove azioni parlamentari e formula
alcune proposte al Ministero del Lavoro.
L’ UDI di Badolato
Il primo circolo UDI viene
costituito a Catanzaro nel 1945. Vi partecipano iscritte provenienti
da varie esperienze partitiche (partito repubblicano, partito
d’azione, partito democratico del lavoro, partito socialista,
partito comunista) ma anche donne totalmente estranee al mondo della
politica. Della prima parte dell’attività di questo
circolo, rappresentata principalmente dall’appoggio alla lotta
delle raccoglitrici di olive, tratteremo diffusamente nel paragrafo
successivo.
Nel
1952 nasce il circolo di Badolato costituito nel suo comitato
direttivo da Carmela Amato, Vittoria Bressi, Silvia Gallelli, Rosa
Larocca, Maria Procopio, Domenica Samà, Paparo Anna, Paparo
Giuseppina ed Elisa Valenti. In una seconda fase dell’attività
si unirà a loro Rina Trovato, una tra le figure che più
ricorrono nelle battaglie civili badolatesi e che è così
descritta da un’altra esponente del movimento: «Badolato
era allora un paese con un alto numero di compagni e compagne
iscritte al Partito Comunista, era insomma un paese rosso e Rina era
la compagna di spicco. I suoi interventi, sempre a braccio e
appassionati, erano spesso riportati anche sull’Unità
quando interveniva nelle manifestazioni nazionali. Sempre fedele alle
sue origini contadine, ci raccontava di Giuditta Levato e delle
battaglie delle donne per l’occupazione della terra. Da
Badolato partiva sempre almeno un autobus pieno di donne per
partecipare alle manifestazioni a Soverato o altrove. In particolare
ricordo la manifestazione a Reggio Calabria del 7 dicembre ’78;
per la prima volta in quella città un corteo di sole donne,
erano scese giù dall’Emilia e Romagna in tante per
sostenere le donne calabresi che ancora faticavano ad ottenere
consultori – ne erano stati istituiti già 384 al
centro-nord e soltanto 13 al sud tra cui quello di Soverato- e
applicazione delle legge sull’aborto. Ero andata al corteo con
Rina e le amiche di Badolato. Ho sempre ammirato la sua capacità
di mettere in parole semplici la sua esperienza con l’efficacia
propria di chi non occulta ma sa esaltare le origini; oggi potrei
attribuire questa qualità, da molte di noi emancipate persa,
al fatto che lei sia rimasta in qualche modo radicata nel linguaggio
materno malgrado le scuole di partito frequentate.»
Questa storia la ripercorriamo
attraverso la sua viva voce.
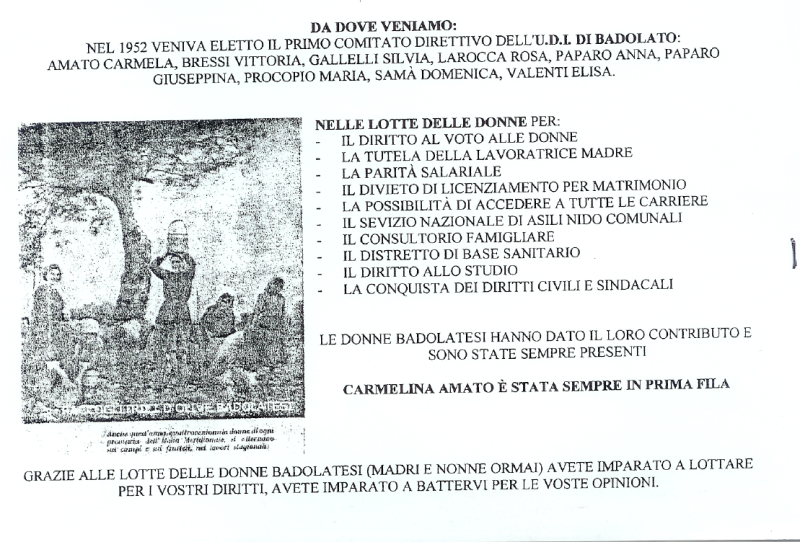
Badolato,
1948
« Inizio col dire che io
ho fatto solo la seconda elementare. Nel 1948 nel mio paese c'era un
Partito Comunista fortissimo. Allora si preparavano manifestazioni,
scioperi per il lavoro, l'emancipazione...Noi a quell'epoca avevamo i
giovani che erano tornati dalla guerra, e poi i compagni che c'erano
prima. Avevamo avuto a Badolato la sorella di Longo, che era
confinata politica, e quindi si era creato un certo movimento.
Infatti nella sezione sembrava...si può dire che era tutto il
paese che si attorniava a questi principi nuovi che venivano fuori.
Io ero una ragazza, perché sono del '37, avevo 15-16 anni. Mi
piaceva il rinnovamento, e partecipavo a tutte queste cose.»
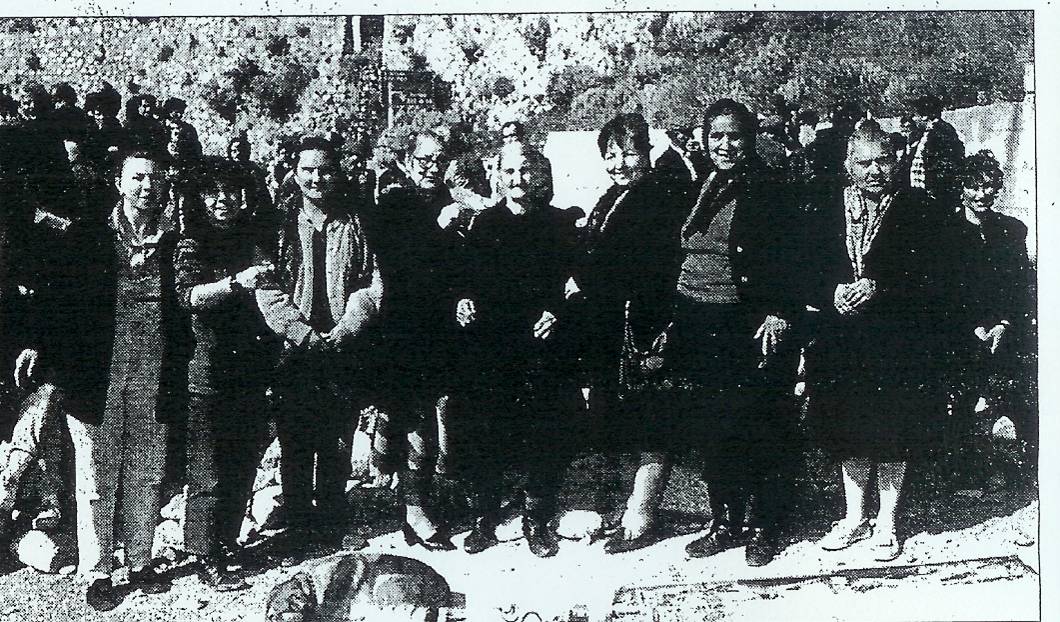
Rina
Trovato partecipa al blocco della strada Badolato Marina-Badolato
Scalo
Terra
e Lavoro
La stessa Rina Trovato ci
restituisce il clima di quel momento di agitazione :«La
battaglia più grossa noi l'abbiamo fatta nel 1951, quando c'è
stata l'alluvione e hanno cominciato a fare una strada che collega
Badolato con le Serre, e allora gli operai tagliavano gli alberi nei
terreni dei più ricchi, e la polizia veniva a bloccare questo.
Noi da ragazzi...le donne più grandi occupavano le strade, noi
più piccole andavamo in cerca di qualcosa da mangiare per gli
operai nel paese. Ti sentivi partecipe alla lotta. Poi il momento
cruciale per me personalmente è stato...perchè allora
c'era la Legge Gullo, che portava il miglioramento nella mezzadria.
Le raccoglitrici di olive si sentivano più protette, anche i
contadini – che prima non prendevano niente dai terreni –
cominciavano ad avere il loro frutto, la loro partecipazione, la loro
parte degli ulivi; la misura che prima veniva piena del frumento che
loro raccoglievano e dovevano pagare al padrone...hanno fatto un
legno che dava la misura giusta, e quindi ogni dieci misure gliene
veniva una fuori. Vedevano queste cose qua. Poi si è fatta una
battaglia per il caro pane; poi dovevano pagare una certa percentuale
dei chilometraggi che portavano le donne sulle olive che portavano ai
proprietari per il frantoio. Io ero una ragazza che volevo tentare in
questa lotta. La Camera del Lavoro aveva fatto un incontro con
l'allora Ufficio di Collocamento, un incontro fra i proprietari e per
iscritto fecero una legge che questi dovevano dare questi soldi alle
donne. Tutti hanno accettato, perché erano di fronte alla
legge, c'era il maresciallo dei carabinieri, l'hanno fatto al Comune.
Però, sotto sotto, si diceva che questi, dopo aver fatto
l'accordo, non lo mantenevano. Io, con tutto che mio padre era un
autista, non era un contadino, sono andata a raccogliere le olive con
le donne, per tenere i fili di questa battaglia. La Camera del Lavoro
diceva: non possiamo fare nulla, tutte si rifiutano di denunciare;
cosa facciamo, le prendiamo col bastone?»

Carmelina
Amato e
Rina
Trovato
Le
politiche sociali
E sempre Rina Trovato,
accompagnandoci verso gli anni ’70, parte da sé e ci
racconta: «Mi sono sposata in Comune, perché vedevo
questa differenziazione che facevano. Io non l'ho mai sopportata,
vedere tutti i palazzi...Fare tredici chiese in un comune come il
nostro, che erano 4000 abitanti. Tredici chiese e nessuna scuola,
nessun altra cosa. Io mi ricordo che facevamo le battaglie per
l'asilo, per la scuola materna. Siamo andate alla Regione e mi
dicevano: “Guardate, sono venuti i vostri compagni di Modena,
di Reggio Emilia e di Bologna per espandere e migliorare i loro
asili. Noi non abbiamo soldi, a noi non ci mandano soldi per fare gli
asili qua”; “E voi che voce avete quando andate a Roma,
se non vi imponete per quello che dobbiamo fare? Se voi vi date da
fare...”. Allora sono cambiate delle cose, perché la
scuola a tempo pieno a Badolato è stata fatta la seconda
dopo...prima si è fatta a San Giovanni in Fiore. Io,
personalmente, quando mio marito era sindaco, mi sono bisticciata con
lui, perché sono andata a prendere i documenti a Cosenza e a
San Giovanni; li ho portati qua e li ho costretti con la forza a far
approvare, nel Consiglio comunale, l'apertura della scuola a tempo
pieno. Dicevano: “Con i tempi forse non ci riusciamo”,
ma se mai cominciamo! E allora era la seconda in Calabria, dopo
Badolato l'hanno fatto dappertutto. Perché? Perché
erano le donne che si interessavano a fare queste cose, e grazie ad
Annamaria – perché lei, essendo professoressa, recepiva
di più, preparava documenti e noi andavamo...Loro davano
l'intellettualità e noi eravamo la forza. E' stato molto
importante questo, perché le intellettuali dei paesi si
sentivano più grandi e non contribuivano alle nostre lotte.
Non hanno mai contribuito, pochissime sono state quelle che hanno
appoggiato le lotte che abbiamo fatto, perché ci trovavamo di
fronte...Poi, dopo fatte, tutti accettavano. Prima non erano tanto
propensi a fare queste cose.»
«Quante persone, anche
di Badolato, non sanno quello che abbiamo fatto noi. E anche ragazze,
dell'Università della Calabria, sono venute a prendersi foto,
materiali...Io conservo intere documentazioni. Loro vengono e dicono:
“Ma come, non sapevamo che c'era tanto materiale!” E pure
noi come contadine...Guarda, quando io ero ragazzina mi ero
meravigliata che c'erano certi contadini che andavano a raccogliere
le firme quando hanno ucciso i coniugi Rosenberg; da Badolato sono
partite centinaia di cartoline per non farli uccidere. E chi le
mandava? Questi contadini che frequentavano la sezione, che erano
attaccati...Donne contadine...vedi la ricerca dove ti porta?»
1.2
La lotta affianco alle raccoglitrici di olive

Questo percorso per
l’affermazione dei diritti delle donne trova la sua prima
rappresentazione nella concreta lotta delle raccoglitrici d’olive
Nel 1961 l’UDI prepara e
convoca per il 12 novembre a Reggio Calabria un incontro con le
raccoglitrici di olive della Calabria e del Mezzogiorno d’Italia.
La deputate dell’UDI
decidono durante il convegno di presentare un progetto di legge per
la parità di trattamento nelle indennità di malattia e
di infortunio e nelle pensioni di invalidità e vecchiaia.
Chiedono inoltre un piano di asili, o di momentanei edifici
prefabbricati, per dare educazione e ospitalità a circa un
milione di bambini che tengono a definire “italiani”. Le
300 mila raccoglitrici di olive del meridione rappresentate al
convegno organizzano negli stessi giorni uno sciopero che coinvolge
Calabria, Puglia e Basilicata. Lo sciopero delle raccoglitrici
d’olive della provincia di Catanzaro si protrae per cinque
giorni, dal 21 al 26 novembre, ed ha percentuali di partecipazione
che vanno dal 70 al 100 per cento.
Comizi si svolgono a Nocera
Tirinese e a Sambiase mentre altri scioperi avvengono nel Crotonese a
Strangoli, Mesoraca, Cirò, Crucoli Torretta, Torretta Melissa,
dove la lotta ha una dimensione totalitaria. Scioperano oltre
settanta mila raccoglitrici calabresi.
E’ la prima volta che
un’azione di questo tipo registra un simile successo in una
situazione particolare come quella delle raccoglitrici di olive del
Sud.
Le ragioni delle agitazioni
per la terra hanno origini lontane. Nonostante la cultura dell’ulivo
fosse particolarmente redditizia, il costo del lavoro incideva solo
nella misura del 15 per cento sul valore del prodotto.
Nonostante la diversità
delle varie forme di retribuzione adottate nei 450 comuni calabresi,
ogni anno, da novembre a marzo, le campagne della regione si
popolavano di uomini ma specialmente di donne giovani e anziane per
la raccolta delle olive.
Queste le loro condizioni di
lavoro: dall’alba al tramonto in posizione curva, a piedi
scalzi per non scivolare e con la continua sorveglianza dei
“caporali” e dei “fattori”. Prive di alcuna
garanzia salariale, il padrone sceglieva e adottava a suo piacimento
i metodi di raccolta e di retribuzione. Veniva usata, quando erano
poche le olive da raccogliere, la raccolta a “compartecipazione
per squadre” e si sceglieva invece la paga “a giornata”
quando era prevista la possibilità di raccogliere molti
“tomoli”.
Una donna non riusciva a
guadagnare in media più di un litro d’olio al giorno,
corrispettivo salariale di una giornata di lavoro, svolta con l’aiuto
di due o tre unità familiari generalmente di età
inferiore ai 12 anni. La raccoglitrice doveva poi trasportare un
carico tra i 40 e i 70 chili- circa il peso di un “tomolo”-
dal campo al frantoio. Se possono apparire dure le condizioni di
lavoro e irrisorie quelle di retribuzione, quelle sociali erano ancor
più allarmanti. Talvolta decine di chilometri a piedi per
arrivare sul posto di lavoro e se la scelta era il pernottamento, una
balla di paglia bisognava dividerla con non meno di cinque persone.
Oltre la metà delle raccoglitrici erano sposate ed avevano
figli piccoli. Un problema con carattere di ambiguità perché
se da un lato emergeva la necessità di un piano di asili nido,
non meno urgente era un piano di tutela del minore che lavorava.
Dal 1957 al 1960 le battaglie
sindacali avevano portato ad ottenere l’emanazione di decreti
del Ministero del Lavoro sul collocamento regionale speciale e
sull’assistenza protettiva, con la concessione di un pacco
contenete capi di vestiario per tutte le raccoglitrici calabresi e
con la creazione di una nuova forma mutualistica per le addette alla
raccolta delle olive. Affrontato in qualche modo il problema della
previdenza e il problema del collocamento della manodopera (con un
sistema analogo a quello della monda), rimaneva irrisolto il problema
contrattuale.
Contro le cento lire orarie,
previste nel 1961, vengono richieste dalla CIGL retribuzioni
giornaliere di 1000 lire per le donne e di 1150 lire per gli uomini,
oltre la definizione delle qualifiche per sesso e per età e
delle mansioni, la riduzione dell’orario di lavoro da 7 a 6 ore
in dicembre e gennaio, la regolazione della compartecipazione e del
sistema della gabella, nonché una migliore definizione della
parte normativa del contratto.
Le aspirazioni di queste
lavoratrici però vanno anche oltre le rivendicazioni salariali
e assistenziali. Comincia ad emergere l’esigenza di nuovi
rapporti sociali nelle campagne: una rete di servizi che permetta di
assolvere al duplice compito professionale e domestico, una rete di
istituzioni rispondenti alle esigenze delle nuove generazioni, il
superamento dei vecchi pregiudizi di soggezione familiare.
Nel
documento approvato all’incontro del 12 novembre a
Reggio Calabria, al quale hanno partecipato più di mille
raccoglitrici calabresi, l’Unione Donne Italiane ha precisato
le rivendicazioni sulle quali chiamava le donne a lottare negli anni
che sarebbero venuti:
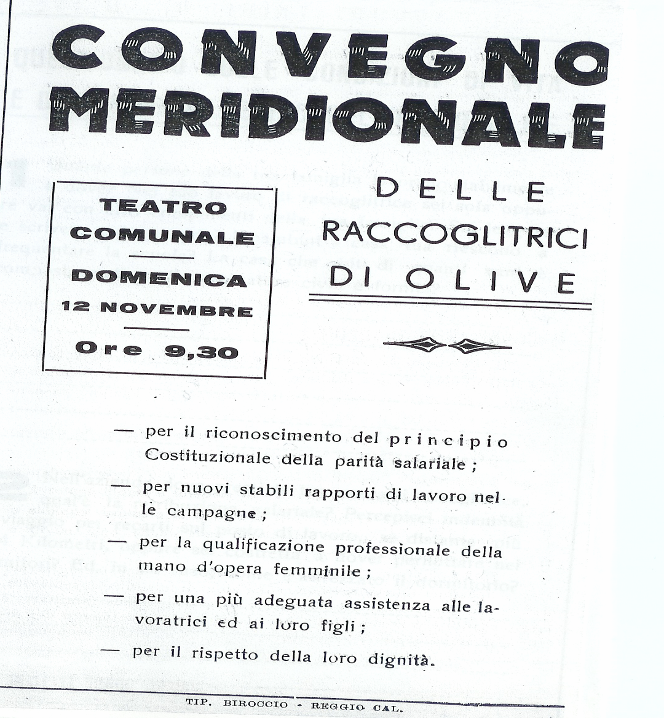
UDI
Archivio Centrale DoCam 61.1\10
- parità salariale,
assistenziale e previdenziale; perché, nonostante l’accordo
sulla parità salariale delle braccianti (sottoscritto a Roma
dalle organizzazioni padronali e da tutti i sindacati di categoria)
fosse stato un passo avanti nella lotta per l’emancipazione,
gran parte dei contratti provinciali sancivano ancora uno scarto del
30 per cento in meno per le donne.
- piano di asili per un
milione di bambini; in linea con la proposta di legge, portata
avanti dall’UDI a livello nazionale, che fissava le linee di
una riforma generale dell’assistenza all’infanzia e
mirava soprattutto al trasferimento dei servizi assistenziali
dall’OMNI (…….) agli enti locali.
Oltre la promessa di portare
in Parlamento la richiesta di asili per un milione di bambini, le
deputate UDI sollecitano che «il Ministero della Pubblica
Istruzione invii immediatamente aule prefabbricate da adibirsi ad
asili, che i Comuni rivendichino un piano di cantieri di lavoro per
disoccupati destinato alla costruzione degli asili, che la Cassa per
il Mezzogiorno stanzi immediatamente i fondi disponibili per la
costruzione di una vasta rete di asili (in un recente dibattito
televisivo è stato ammesso che i 500.000 milioni a
disposizione per la Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di
asili non sono stati utilizzati)»
- la scuola e
l’istruzione professionale; si invitava a sostenere la
battaglia nazionale per la riforma della scuola italiana e per
garantire alla popolazione infantile la scuola gratuita fino a 14
anni. Vengono inoltre chieste scuole popolari, espressamente per le
braccianti stagionali, che avrebbero dovuto tener conto delle
particolari esigenze del loro lavoro.
- assistenza immediata a tutte
le raccoglitrici di olive, ci si impegnava a presentare
subito una mozione in Parlamento per rivendicare al Ministero del
Lavoro uno stanziamento di almeno 300 milioni per assicurare
assistenza immediata a tutte le raccoglitrici di olive per
proteggerle dai rigori del clima invernale e dai pericoli delle
malattie professionali.
- Per rapporti di
lavoro di stabili e moderni; «Dare coscienza alle braccianti
del Mezzogiorno della inaccettabilità delle loro condizioni di
lavoro e organizzare e dirigere una loro azione per conquistare
rapporti di lavoro più civili e moderni significa di per se
stesso creare le condizioni per una trasformazione economica e
sociale del Mezzogiorno. Rivendicando il pieno riconoscimento del
proprio lavoro le braccianti meridionali si collocano come forza
egemone e non più subalterna fra le forze che più
attivamente rivendicano un Mezzogiorno moderno economicamente e
socialmente».
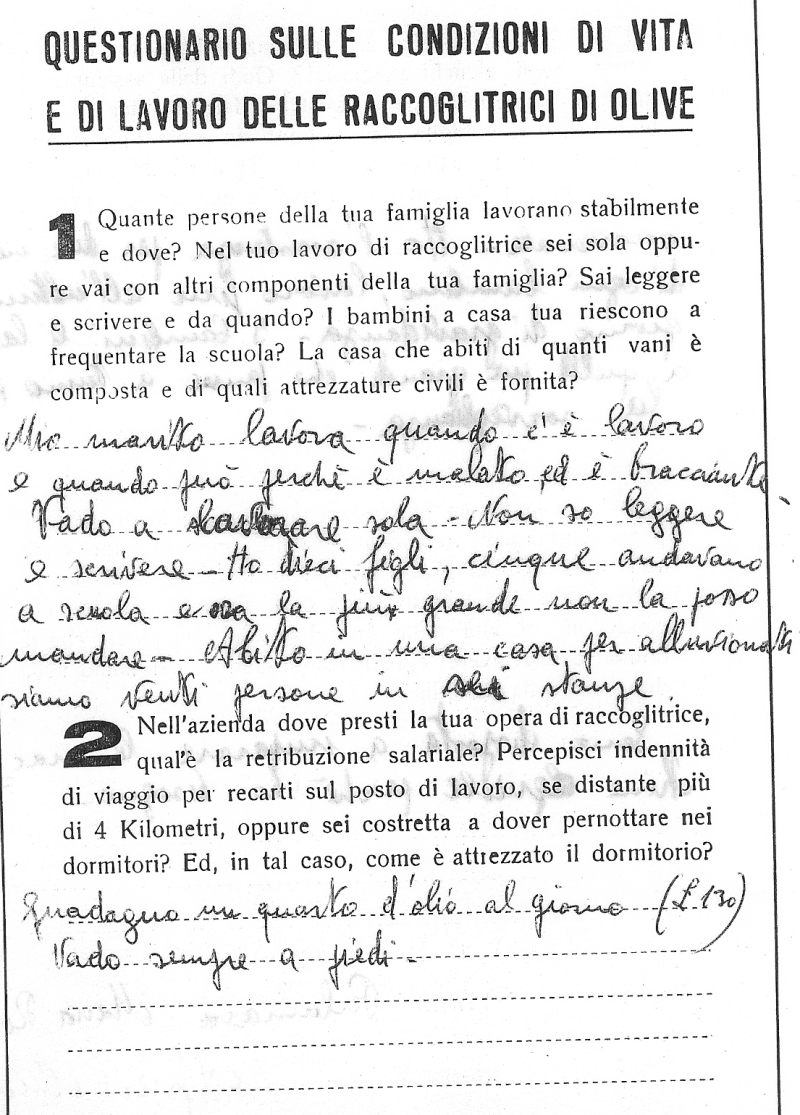
-
Mio marito lavora quando c’è lavoro e quando può
perché è malato ed è bracciante. Vado a
lavorare sola. Non so leggere e scrivere. Ho dieci figli, cinque
andavano a scuola e ora la più grande non la posso mandare.
Abito in una casa per alluvionati siamo venti persone in sei stanze
-
Guadagno un quarto d’olio al giorno (L. 130).
Vado
sempre a piedi.
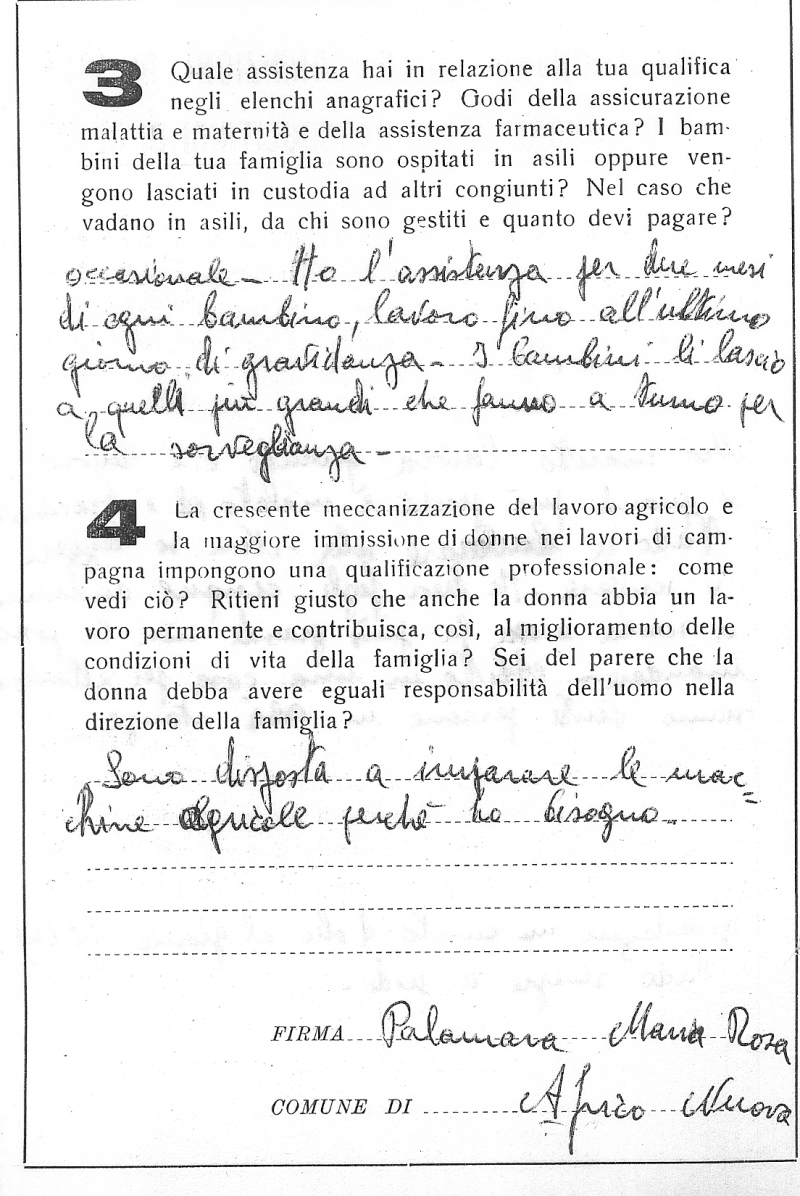 -
-
-
occasionale.
Ho l’assistenza per due mesi di ogni bambino, lavoro fino
all’ultimo giorno di gravidanza. I bambini lascio a quelle più
grandi che fanno a turno per la sorveglianza
-
sono disposta a imparare le macchine agricole perché ho
bisogno
Palamara
Maria Rosa
Africo
Nuovo
Nonostante
i passi in avanti fatti anche grazie all’Udi –
soprattutto nell’ambito della sensibilizzazione esterna
all’organizzazione – dalle testimonianze che raccogliamo
dalla stampa dell’epoca le condizioni delle lavoratrici non
sembrano migliorare di molto. L’assistenza INAM per le donne di
campagna continuava a rimanere molto bassa, Antonia Romano Nocera,
ostetrica e moglie di bracciante, in un’intervista a “Noi
Donne” nel 1961 racconta così: «12-15 mila lire
per ogni parto e un pacco ostetrico di infimo valore, composto da tre
pacchetti di cotone, 4 di garza, 4 di spilli, da un pezzo di sapone
neutro, da un pacco di talco e da un quarto di alcol puro,
insufficiente per sterilizzare le stesse bacinelle.»
Sempre allo stesso servizio appartiene la testimonianza di Rosaria
Derna, raccoglitrice di olive di diciassette anni di Polistena: «Ho
lasciato la scuola in
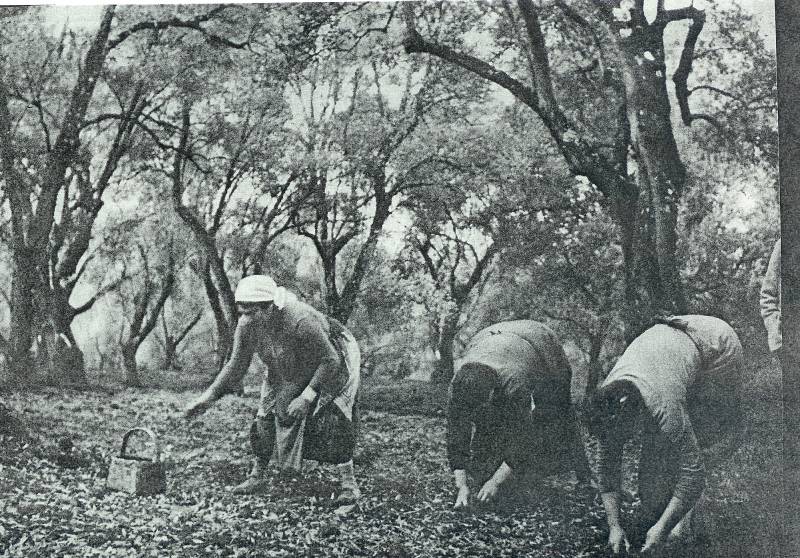
terza elementare per badare
alle faccende domestiche. Poi la necessità di lavorare per
vivere mi ha portato nei campi sin dall’età di dodici
anni. E per svolgere un lavoro tra i più duri che si possano
immaginare. Non ho più letto da quando ho lasciato le scuole.
Il mio viaggio più lungo è stato ad Acquaro di Cosoleto
dove sono andata a raccogliere le olive. Il treno lo vedo sfilare
sotto gli uliveti, ma non ci sono mai salita, neppure per andare a
Gioia Tauro a vedere il mare.»
1.3
La Fidapa di Catanzaro
La
Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) nasce
in Italia nel 1929
con delle precise convinzioni fondative: «Vivere la Vita
associativa all’insegna di una coscienza democratica, per
rendere la Federazione una vera palestra di democrazia, in cui i
rapporti amicali e gli obiettivi comuni ne costituiscono l’essenza».
Non a caso queste parole che risalgono ai nostri giorni, racchiudono
bene a distanza di anni il senso originario di questa organizzazione.
La
Fidapa nella sua costruzione più che darsi uno statuto
regolamentare sembra comporre un vero e proprio decalogo
comportamentale.
Risulta
“vitale”, infatti, per l’associazione attivare
delle modalità a sostegno di un autentico rapporto
associativo, in cui la proposta è quella di sostenere le
iniziative delle donne, elevare il loro livello culturale e
risvegliare il senso della responsabilità verso il proprio
paese e verso la società; inoltre bisogna adoperarsi per
rimuovere le discriminazioni che ancora sussistono a sfavore delle
donne, sia nell'ambito della famiglia che del lavoro attraverso gli
strumenti della solidarietà, della collaborazione, dell’aiuto
reciproco.
Naturalmente,
sulle stesse basi, nel 1961, a Catanzaro si costituisce la FIDAPA per
opera della marchesa Cafiero, donna proveniente dalla FIDAPA di
Napoli.
L’associazione
può essere istituita solo da una appartenente già
all’organizzazione - per dirlo in gergo associazionistico - da
una fidapina che deve trovare sul posto almeno altre 11 donne
disposte ad associarsi e costituire la sezione.
Come prima Segretaria del
Comitato di Presidenza viene eletta una donna di spicco della
Democrazia Cristiana, ma il Vescovo dell'epoca, considerando
inopportuna tale esposizione da parte di una donna della DC,
intervenne costringendola a dare le dimissioni.
In quella elezione era stato
fatto uno strappo alla regola; infatti lo Statuto (pubblicato per la
prima volta nel 1975) vietava alle associate di avere una
collocazione politica; così non era consentito che la
Presidente ricoprisse cariche politiche, né che una casalinga,
pur potendosi iscrivere, rivestisse cariche elettive. Tutto ciò
fino al 1990.
La FIDAPA di Catanzaro, anche
nel momento in cui l’associazione nazionale decise di rivedere
questo punto dello Statuto rimase ferma sulla posizione originaria.
Nella
lettura di queste questioni statutarie, risulta illuminante la
testimonianza di Maddalena Barbieri che così racconta :«
Fino al convegno di Capri le presidenti non potevano avere cariche
politiche. Una delle caratteristiche della Fidapa è questa,
essere – allora si diceva apolitica, non è esatto –
apartitica. Non apolitica perché tutte le fidapine hanno la
loro ideologia, la loro attività, però nell'ambito
della Fidapa non ci sono discriminazioni, differenze. E infatti la
Fidapa, nelle varie elezioni, non ha mai preso posizione per l'uno o
per l'altro. Le fidapine votano senza avere ...Quando sono stata
eletta presidente, nel 1993 (fino al '95), una sera una socia aveva
ritenuto (c'era una festa) di invitare un candidato, il quale si
presentò (io lo conoscevo). Io ho detto a viva voce che il
signore era venuto non per ragioni di ordine politico ma per
amicizia. Dicevo che a Capri c'è stato l'annullamento di
questa limitazione (riguardo le socie con cariche politiche), e
quindi, successivamente a questo convegno (non ricordo in che anno,
ma da pochi anni) c'è stata la possibilità di
inserimento per una donna politica; ovvero anche una donna inserita
nell'attività politica poteva assumere la carica di presidente
o altre cariche significative. Tutto perché lo Statuto dice
che le donne, di qualsiasi razza, religione, colore, sono tutte
sullo stesso piano. Questa è una caratteristica fondamentale
dello Statuto della Fidapa. C'era anche, fino a un certo periodo, la
limitazione per le casalinghe che non potevano diventare presidenti;
ma per questo bisogna andare ai tempi passati, quando le casalinghe
non avevano titolo di studio, cultura, ecc. , mentre oggi le
casalinghe sono generalmente anche lavoratrici e hanno un titolo di
studio. Fino a quel momento a una casalinga non era data la
possibilità di essere eletta presidente (le cariche sono
elettive), poi invece è stata eliminata anche questa
limitazione.
Per
capire tutto questo bisogna riandare alla fondatrice, Lena Madesin
Phillips, un'americana che si inserisce nel movimento del femminismo.
Lei era avvocato in America che, invece di fare la suffragetta e
partecipare a quelle che furono le manifestazioni – a mio
parere – scomposte...anche qui in Calabria alcune ragazze
giravano sventolando – forse lei non se lo ricorda – il
reggiseno, facevano gesti poco eleganti per una donna, per una
signora (non in senso di ceto, ma di animo). Questo avvocato in
America si assunse il compito di approntare, di costituire questa
associazione per affrontare e sostenere l'inserimento delle donne.
Dall'America passò in Europa; venne in Italia nel '29; a Roma
la sua iniziativa ebbe consensi e sostegno, così potè
istituire organizzazioni simili anche in Italia. Però poi il
fascismo chiuse tutte le organizzazioni non direttamente controllate
dal regime, quindi anche la Fidapa. Poi ci fu la guerra. A Catanzaro
si costituì nel 1961.
(…)
Catanzaro ha avuto sempre la presidente giusta al momento giusto.
Sono state tutte presidenti che, prima di tutto, non hanno mai
determinato un rapporto di dipendenza nei confronti di nessuna socia,
e non hanno mai esasperato un rapporto di contrasto, e quindi non c'è
stata mai la necessità di chiamare in soccorso la direzione
generale nazionale. I vari cambiamenti delle Presidenti sono serviti
per dare una varietà e un'articolazione di impostazione
culturale, perché la Presidente si porta dietro le suoi
conoscenti, le sue possibilità di rapporto culturale con
persone di altre città, e quindi la vita è stata sempre
molto fiorente. Infatti, Catanzaro risulta la sezione più
numerosa d'Italia.(…) Lo Statuto è stato pubblicato nel
1975, poi però ne è stato approvato un altro nel 1990
(lo abbiamo approvato andando a Firenze). A Firenze io andai come
rappresentante di Catanzaro; noi catanzaresi nel momento in cui
dovemmo discutere se si poteva fare presidente una politica votammo
per il no. Poi successivamente vi furono dei cambiamenti, anche
perché i tempi cambiano e bisogna adeguarsi. Noi catanzaresi
abbiamo votato per il no per una ragione semplice: se una socia ha
una coloritura politica così vistosa ne viene di conseguenza
un'impronta del tutto particolare, e quindi l'associazione sarebbe
per due-tre anni democristiana, poi comunista, poi socialista. Tutto
ciò creerebbe solo attriti. Prima, non essendoci la
possibilità di nominare una politica, nessuno veniva fatto
oggetto di pressioni politiche, per quanto si affrontassero tutti i
problemi, ma nella libertà della persona umana. Dalla
discussione del problema ognuna aveva la possibilità di fare
le sue scelte»13.
Capitolo
2
La
svolta degli anni Settanta:
Le
politiche sociali e i collettivi
di
Maria Marino
Premessa
A
proposito dell’UDI è Anna Rossi Doria che, pur
precisando si trattasse di un associazionismo sulla base di
schieramenti politici e non dell’appartenenza di genere,
sostiene che «al loro interno le militanti svilupparono tutta
una serie di sforzi volti a costruire una politica delle donne, non
certamente separata, ma in qualche minima misura autonoma da quella
dei rispettivi gruppi di appartenenza»14.Dentro
forme organizzative tradizionali, ereditate dalla tradizione di altri
luoghi, si sperimenta una forma di libertà che risulta
difficile da definire perché è nella singolarità
di ognuna che una parte di questa esperienza ha le conseguenze più
evidenti.
Fondamentale,
diventa il fatto di avere per la prima volta a disposizione un luogo
fisico dove la propria individualità può sperimentarsi,
dove si è riconosciute da tutte con il proprio nome, dove non
si è più “la figlia di” o “la moglie
di”, dove è possibile sentire l’orgoglio di essere
considerata “una donna intelligente”, dove anche la più
timida può e deve parlare. Nelle sedi Udi, infatti, si fanno
riunioni, ma anche si chiacchiera, si ride e si prende il the, pur se
la riflessione sul quotidiano non prescinde mai dalla dimensione
politica, una dimensione nella quale ci si muove orientandosi con la
“bussola” del costante confronto con le altre, con cui,
oltre alle parole, si condividono spazi e gesti.
L’Udi
diventa una scuola e resta un punto di riferimento a cui si guarda.
Anche per le donne che hanno trasferito in altri luoghi il loro
impegno politico resta sempre la nostalgia delle pratiche di
socialità raramente trovate altrove.
Delia
Fabrizi, componente dell’UDI catanzarese, trasferitasi poi a
Bologna, così spiega la particolarità
dell’organizzazione sul territorio di Catanzaro e la sua
conseguente difficoltà ad aderire all’UDI della città
in cui ora vive:
«Eravamo
quasi tutte signore borghesi. Caso mai iscritte al PCI, però
borghesi. Bisogna intendersi nei termini però; che vuol dire
borghesi? Di una certa estrazione sociale. E' la difficoltà
che ho io oggi nel rapportarmi con le donne dell'UDI dell'alta
Italia, perché loro hanno fatto un altro tipo di guerra, di
battaglie. Con cui non mi trovo proprio per questa diversità
di storia politica. Cioè, io sono andata, digiuna di politica,
a fare politica in un'organizzazione e ho iniziato lì –
annaspando all'inizio – i primi passi. Loro (…..)
sembrano ancora più legate ai diritti….hanno fatto un
altro percorso. Hanno un'altra storia. Noi, io…era più
un malessere dovuto all'ambiente in cui si viveva. Sì, le
guerre per i diritti le abbiamo fatte, ma qual era il diritto?
Adriana
Papaleo, che fu figura di riferimento per molte udine di Catanzaro e
provincia e che assunse anche incarichi a livello nazionale dopo l’XI
Congresso, al riguardo dice: «Questo gruppo di donne si è
sempre più allargato, fino a raggiungere quote inimmaginabili
dal punto di vista del tesseramento delle associate che nemmeno i
partiti di allora avevano raggiunto, perchè a Catanzaro
avevamo un grosso seguito. E poi la cosa particolare che aveva l’UDI
di Catanzaro, a differenza delle altre UDI d’Italia –perchè
poi noi andavamo sempre nelle riunioni nazionali- è che mentre
l’UDI in tutte le regioni d’Italia aveva una connotazione
precisa di carattere politico –erano tutte donne che venivano
dai partiti della sinistra, soprattutto dal partito comunista, e poi
era una classe medio/proletaria- a Catanzaro questo non avvenne, cioè
il nocciolo fondatore dell’UDI di Catanzaro apparteneva alla
borghesia, e c’erano donne di sinistra ma anche donne di
centro, oppure donne che non erano iscritte da nessuna parte. Quindi
c’era questa connotazione diversa tra noi e il resto, che
comunque ha contribuito ad avere un grande appoggio proprio dal punto
di vista dell’interesse esterno e una grande adesione da parte
di donne che non si sentivano subito etichettate con la targhetta
“donne di sinistra” ... E quindi noi abbiamo sviluppato
tutta una serie di iniziative, di lavori, soprattutto dal punto di
vista culturale; io credo che noi abbiamo lavorato, oltre a tutto
quello che riguardava i diritti civili e anche le conquiste che
riguardavano le donne dal punto di vista istituzionale, noi abbiamo
fatto un’operazione proprio di carattere culturale in quegli
anni, promuovendo una serie di convegni soprattutto su quelle che
sono state le femministe ante litteram, ...,tipo Rosa Luxemburg,
ecc.; abbiamo fatto seminari e ogni volta che facevamo queste
iniziative, oltre alle nostre associate, che comunque erano assidue
frequentatrici della nostra sede, avevamo proprio tutta la città
che veniva a prendere parte»16.
E,
comunque, si allacciavano rapporti e si promuovevano obiettivi comuni
con le lavoratrici agricole, come testimonia ancora Papaleo:
«...nelle campagne, per esempio, eravamo donne con donne; si
parlava in dialetto, quelle ti raccontavano in dialetto la loro vita,
ti facevano vedere cose che tu magari non riuscivi a vedere, entrando
proprio nel merito delle loro vicende personali, i rapporti con i
mariti, il loro lavoro (quello delle raccoglitrici di olive era un
lavoro da cani); poi c’era la Levato, di Santa Caterina, che
storicamente era una specie di caporale delle raccoglitrici di olive,
una donna intelligentissima, anche se non aveva fatto nessuna scuola,
ma con una vivacità intellettuale pazzesca; c’erano cose
che erano loro che insegnavano a te, altro che tu andavi a portare il
Verbo! Se non avessimo avuto la capacità di rapportarci in
questo modo...»
E
all’UDI si torna col pensiero o attraverso legami forti di
amicizia. Una lezione che non si impara dalle parole, ma che è
frutto della propria capacità di decodificare i segni intorno
a sé.
Nel
caso di Catanzaro la militanza in altre organizzazioni politiche non
sembra costituire un problema. Tuttavia - a differenza di quanto
succede a livello nazionale - il disagio delle udine catanzaresi non
viene avvertito all’interno dell’organizzazione, ma
fuori. Così risponde Anna Maria Longo, fino agli anni ottanta
leader carismatica dell’UDI catanzarese, alla domanda di
Giovanna Vingelli su come fosse il rapporto col partito comunista:
«Conflittuale. E' stato un rapporto molto conflittuale perché
questo movimento cresceva molto, e crescendo così tanto
portava dentro elementi di autonomia forte. Quindi lo sforzo...faccio
un esempio: noi avevamo il sindacato a Catanzaro, il sindacato
scuola, ma anche lì – quando aprimmo la battaglia per
queste maestre – ci rendemmo conto che c'erano canali
privilegiati, canali non trasparenti. E quindi ecco lo scontro forte.
Soprattutto la mia persona era diventata un personaggio d'attacco.
»17
In
ogni caso, anche se è forte il legame con l’area
comunista, la militanza nell’UDI determina sempre un mutamento
nel proprio modo di vedere la politica. Sempre Anna Maria Longo: «Io
ho vissuto la doppia militanza con grande sofferenza e scontro,
soprattutto. Perché lo scontro, il conflitto, c'era. Ne avevo
consapevolezza. Man mano che questo percorso andava avanti, io
sentivo le donne molto pronte, e ancora di più vedevo questa
organizzazione del partito maschilista,
questo
trincerarsi, questa paura del nuovo.»18
Il
rapporto con i collettivi femministi e', in un primo momento,
conflittuale; jn un secondo momento, al contrario si recuperano
approcci e pratiche tipiche del movimento:
«L'UDI secondo me fa un percorso un pò diverso; le
militanti del partito tentano di fare questo, l'UDI come struttura
solo di donne si scioglie e, secondo me, si riorganizza da un punto
di vista di movimento, quindi produce una rottura nei confronti dei
partiti, considerati espressione del maschile. […]L’UDI,
rompendo in questo modo, trasla, anima e corpo, nelle fila del più
sfegatato femminismo, perché in fondo loro scoprono, a loro
volta, in quegli anni, che cosa significa essere delle donne;
paradossalmente, scoprono la diversità femminile. Quindi, in
parte può essere stato strumentale, ma in parte, secondo me,
loro hanno fatto un percorso, per così dire, posticipato, di
quello che noi abbiamo fatto negli anni '70 »20.
Altrettanto
interessante per chiarire i rapporti tra i diversi gruppi è la
testimonianza di Fulvia Geracioti: «Abitavo a Catanzaro,
frequentavo per stima, simpatia, ammirazione le donne di sinistra e
del collettivo femminista come Lorenza Rozzi, Isa Mantelli, Aldina
Alcaro, Rosanna Maida, Amelia Morica, Elsa
Scarfone ed il gruppo misto dell’ass. “ Giuditta Levato”
tra cui Pasquale Alcaro, ma mi metteva un po’ a disagio il tipo
di rivendicazione “operaista” : ero di estrazione
borghese e a volte mi sentivo come se fossi un’infiltrata…;
soprattutto non capivo perché osteggiassero le posizioni
radicali a favore dei diritti civili, perché – dicevano
– che la lotta prioritaria era contro i padroni…Ricordo
che mi addolorò molto che non si vollero interessare della
raccolta di firme per il referendum contro i Patti Lateranensi perché
“ distraevano dalle battaglie per la riconversione industriale”
. Lo stesso disagio lo provai verso l’UDI : mi dis-turbava la
modalità delle rivendicazioni e, confusamente , sentivo che la
parità
mi trascinava come donna su un terreno non mio, la libertà
per come l’intendevo io non si esauriva con la conquista dei
diritti legali, aveva piuttosto a che fare con il senso ultimo
dell’esistenza, era uno spazio vitale in cui progettarmi,
dis-piegarmi. Non volevo sostituire i dogmi della chiesa con quelli
del partito, volevo libertà
di pensare il mio pensiero.»21
La
conclusione di queste esperienze, quella dell’UDI di Catanzaro
ma anche dell’UDI di Soverato e del Collettivo, non è
indolore. Le forme di leadership che si erano sviluppate al loro
interno cominciavano ad essere messe in discussione. L’autorevolezza
- che emerge attraverso i racconti in cui ognuna fa riferimento alla
“più grande”, a cui si guarda con rispetto e
ammirazione, non è mai un dato tranquillamente acquisito: è
una caratteristica strutturale del movimento quella di fare sempre i
conti con il passato e con
il
futuro.
Un po’ di cronologia
Tra il 1960 e il 1971, anno
dell’approvazione della nuova legge sulla tutela della
lavoratrici madri e di quella sugli asili nido, le politiche
familiari sono al centro delle rivendicazioni delle donne.
Nel 1963 viene varata la Legge
n. 7 che sancisce la nullità del licenziamento a causa di
matrimonio;
nel 1966 la Legge n. 604 del
15 luglio, che stabilisce la nullità del licenziamento
discriminatorio (cioè determinato da ragioni di credo
politico, fede religiosa, appartenenza ad un sindacato,
partecipazione ad attività sindacali)
Alla fine anni ‘60
appare il neo femminismo: le donne italiane iniziano ad ispirarsi
alle idee neo-femministe provenienti dagli USA e dall'Inghilterra e a
fare propria la pratica dell'autocoscienza, danno vita ad una
molteplicità di gruppi diversi, ciascuno dei quali rappresenta
e sviluppa un particolare aspetto dell'analisi femminista. In Italia
il movimento femminista si distingue in modo abbastanza conflittuale
da quelle posizioni che puntano esclusivamente sull’
emancipazione femminile.
Nel 1970 la legislazione
accoglie l'avanzamento dei diritti dei lavoratori determinato dalla
stagione di lotte del 1968/69, e il Parlamento approva la Legge n.
300 del 20 maggio 1970 - Statuto dei lavoratori - “Norme sulla
tutela della libertà e dignità del lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi
di lavoro e norme sul collocamento". Questa è la legge
cardine del diritto del lavoro italiano. Essa stabilisce tra l'altro
la nullità di patti o atti diretti a fini di discriminazione
sindacale, politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
Sempre il 1970 è l’anno
in cui l’UDI lancia una vertenza nazionale per gli asili nido e
per le scuole dell'infanzia. E’ inoltre l’anno
dell’approvazione della "Legge Fortuna" che
istituisce il divorzio.
Nel 1971 vengono approvate la
legge n. 1204 "tutela della lavoratrice madre" che
stabilisce, tra l'altro, la nullità del licenziamento della
donna dall'inizio della gravidanza fino al primo anno di età
del bambino e la legge n. 1044 "Piano quinquennale degli asili
nido"
Nel 1974 si tiene il
referendum sul divorzio: il tentativo delle gerarchie cattoliche di
ottenere l'abrogazione della legge istitutiva del divorzio non passa:
al referendum quasi il 60 % della popolazione vota contro
l'abrogazione della legge. Si tratta di una grande vittoria laica e
progressista.
Nel 1975 viene approvata la
Legge n. 151 del 19 maggio “Riforma del diritto di famiglia”.
Si conclude così una lunghissima discussione parlamentare
(iniziata nel 1969) accompagnata da vivaci iniziative e
manifestazioni politiche delle donne. Con questa legge le donne ed i
figli conquistano una posizione paritaria all'interno di una
famiglia che, fino a quel momento, era dominata dalla figura del
padre-marito. Il 1975 è anche l’anno in cui viene aperta
a Milano la Libreria delle Donne, tuttora attiva. Essa costituirà
un punto di riferimento a livello nazionale per chiunque si interessi
della produzione culturale scritta dalle donne. In molte occasioni è
stata una voce significativa del movimento femminista italiano. Negli
stessi anni a Roma nasce il Centro Virginia Woolf.
Nel 1977 viene approvata la
Legge n. 903 del 9 dicembre "Parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro", che vieta qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso sia per l'accesso al lavoro, che
nella retribuzione e nell'assegnazione delle qualifiche.
Dopo una lunghissima
discussione parlamentare (durata anni) sostenuta da innumerevoli
manifestazioni ed iniziative politiche delle donne (UDI, movimenti
femministi, donne dei partiti della sinistra) viene approvata la
legge 194/78 che garantisce l'interruzione volontaria della
gravidanza entro 90 giorni dal concepimento.
Nel 1981, tre anni dopo
l'approvazione della legge sull'aborto, la Democrazia Cristiana e il
Movimento Sociale promuovono il referendum abrogativo, ma gli
italiani votano per il mantenimento della legge con una maggioranza
del 68 %.
2.1 UDI: Circolo di
Catanzaro
L’UDI si riforma a
Catanzaro il 6 dicembre 1970. Il circolo nasce per iniziativa di Anna
Maria Longo, che sarà coordinatrice provinciale e regionale
dell’organizzazione dal 1970 al 1984. E’ lei che
raccoglie intorno a sé un primo comitato di dodici donne. Il
comitato catanzarese nel corso degli anni si allargherà sempre
di più, per scelta politica della dirigente. Dopo l’incontro
del 6 novembre(quale anno??) sono già circa ottanta le
tesserate.
La prima battaglia che l’UDI
di Catanzaro intraprende è quella per il diritto allo studio
che, come sostengono queste donne, “comincia a tre anni”.
A Catanzaro infatti nei primi anni Settanta l’unico asilo
esistente era privato. La battaglia per il diritto allo studio,
proprio perché riferita ad una fascia di età in cui il
bambino è ancora totalmente dipendente da qualcuno, serve a
far emergere i diritti e le esigenze elementari, ma allo stesso tempo
fondamentali, delle donne: «Quella di Catanzaro era considerata
fra le UDI più all'avanguardia in Italia, perché
l'elemento che noi abbiamo avuto il coraggio di affrontare non era
tanto il servizio sociale, la scuola per l'infanzia, ma il fatto di
dare alle donne un aiuto, una tranquillità, per essere più
libere, per pensare di più a stesse. Questo è stato un
elemento di novità; io dicevo: “Così potete
andare dal parrucchiere, perché sapete che il bambino è
sistemato, è seguito”. Era un rivolgersi alle donne come
fatto di liberazione dalla soggezione familiare, dalla dipendenza
familiare. Noi sviluppammo tutto questo filone.»
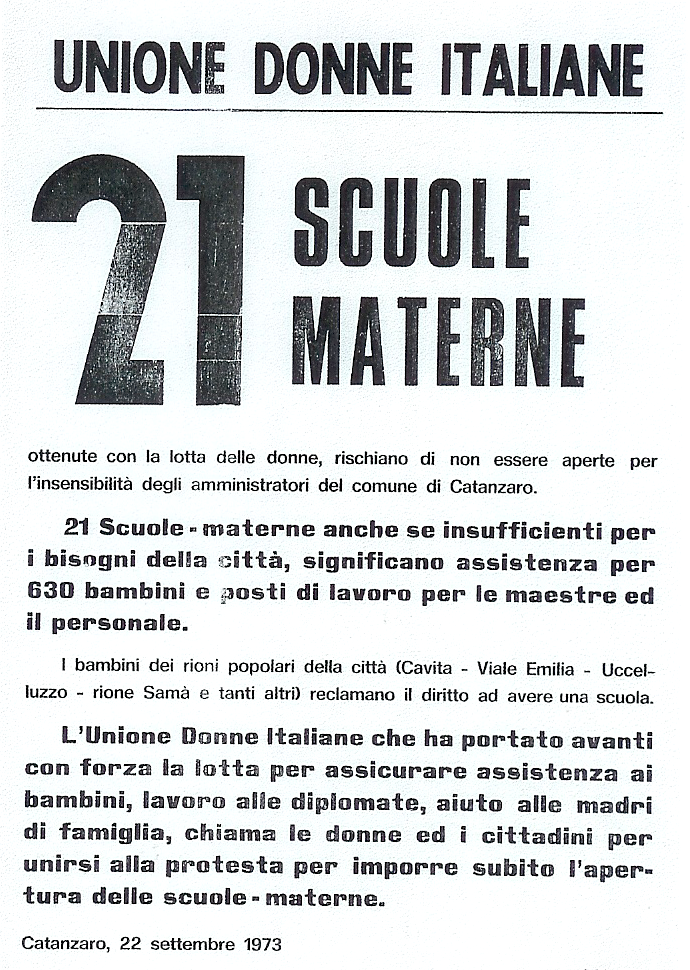
Il 29 e il 30 gennaio del 1972
al Convegno Nazionale “La donna e la maternità nel
quadro delle riforme” la posizione dell’UDI è per
la prevenzione dell’aborto attraverso l’istituzione
diffusa dei consultori. L’UDI ritiene che il rapporto
donna-maternità costituisca il punto nodale della questione
femminile, poiché vede un condizionamento negativo da parte
della società per il suo essere madre “potenziale o di
fatto”. Proprio su questo rapporto con la specie si è
fondata per l’UDI l’inferiorità sociale della
donna, inferiorità che ha trovato la sua espressione nella
cosiddetta “divisione dei ruoli”.
Il 5 marzo del 1972 alla
manifestazione che si tiene all’interno di un cinema
cittadino “Per la sicurezza delle famiglie per l’emancipazione
della donna un posto di lavoro sicuro e giustamente retribuito in una
Calabria moderna e rinnovata” sono presenti oltre 600 donne.
Nel 1973 le donne dell’UDI
denunciano la forte carenza di servizi sociali, soprattutto dopo le
alluvioni che quell’anno avevano colpito molti centri rurali
del catanzarese. Oltre ad annunciare l’arrivo di una
delegazione nazionale UDI nelle zone del nubifragio, il direttivo
provinciale incontra il 13 gennaio i responsabili
dell’amministrazione regionale e preannuncia l’apertura
di una vertenza con i comuni, l’amministrazione provinciale e
la regione, per la piena occupazione femminile e la creazione di
scuole materne e asili nido.
Alla manifestazione unitaria del 3 marzo, preparata da decine di
assemblee - a Borgia, Caraffa, Cropani, Taverna, a Catanzaro con le
lavoratrici della Sip, a Crotone e Nicastro nei quartieri più
popolari - aderiranno la CGIL, le ACLI e i partiti democratici di
sinistra. Nel corso di questo lavoro di mobilitazione l’UDI
porta avanti un’iniziativa di solidarietà in direzione
delle famiglie alluvionate dei paesi più colpiti. Due
delegazioni dell’UDI nazionale incontrano le donne e le
popolazioni di Roccelletta, Guardavalle, Amaroni e Nardodipace. Una
parte degli aiuti, provenienti soprattutto da Ravenna, verrà
distribuito nel corso delle assemblee tenute davanti alle case degli
alluvionati. Le alluvioni avevano causato 22 morti e 32 mila senza
tetto. Sotto accusa il governo Andreotti: ci si chiede infatti quale
fine abbiano fatto i 350 miliardi della legge pro-Calabria, spariti
senza alcuna opera di difesa e di protezione del suolo, e ci si
indigna quando di fronte a 700 miliardi di danni il Governo risponde
con un decreto definito «vergognoso e offensivo perché
elargizione di elemosina ai poveri calabresi.»
Tra l’altro nel decreto nessuna menzione veniva fatta della
chiusura di molte scuole, ancora utilizzate per ospitare la gente
colpita dalle alluvioni. Al centro dell’attività
dell’UDI resta dunque la battaglia per gli asili nido
scarsamente considerati dal governo Andreotti-Malagodi.
Nell’incontro con
l’assessore regionale alla Sanità l’UDI sottolinea
quali fossero gli elementi da tenere presente nel piano di attuazione
degli asili nido: il numero delle donne occupate; la mortalità
infantile; il numero delle case malsane. Si tratta perciò di
criteri che vanno oltre il principio demografico suggerito
dall’Assessorato. Da qui l’input per una riflessione più
ampia che, ribadendo comunque la primaria importanza dei servizi
sociali, si concentra sul problema dell’occupazione femminile.
Il dato emblematico di cui ci si serve è quello riguardante la
provincia di Catanzaro dove, nel 1971, il rapporto tra la forza
lavoro femminile rispetto a quella totale delle donne era
dell’11,39%: solo undici donne su cento erano entrate nel
mercato del lavoro. Per l’UDI il motivo di questa situazione
stava in primo luogo nel fatto che alle donne della provincia di
Catanzaro spettava il peso della cura di 900 mila bambini dai 0 ai 5
anni senza asili nido e con un numero insufficiente di scuole
materne.
In quali condizioni dunque la
donna calabrese affronta il lavoro, quali i lavori che le si offrono
e a quali condizioni. L’analisi delle condizioni di lavoro
delle braccianti e il salario da esse percepito consistente in due
bottiglie d’olio, per le lavoratrici di Cropani ad esempio,
chiariscono il quadro.
Nell’ ambito
dell’agricoltura le donne dell’UDI chiedono il
miglioramento del terreno agricolo e una programmazione. Di
conseguenza corsi di qualificazione per le braccianti, trasformazione
dei prodotti, sviluppo zootecnico e degli ortofrutticoli. Nell’ambito
dei servizi sociali: case, asili nido, scuola materna pubblica e
generalizzata, scuola elementare e media a tempo pieno, per dare
assistenza ai bambini e lavoro alle donne.
Il 1971 era stato per l’UDI
l’anno in cui il principio della maternità come valore
sociale aveva fatto un notevole passo avanti con l’approvazione
della legge per un piano quinquennale di asili nido, finanziati dallo
Stato e dai datori di lavoro, programmati dalle Regioni, costruiti e
gestiti dai Comuni.
L’8 marzo 1975
delegazioni femminili di Catanzaro, Crotone, Nicastro. Guardavalle,
Badolato, Girifalco, Borgia, Roccelletta, Cropani, Petronà,
Chiaravalle, Taverna e Satriano si recano alla Regione per chiedere,
nel quadro della concretizzazione del “valore sociale della
maternità”, l’immediato sblocco dei fondi: 800
milioni per il 1972, un miliardo e trecento milioni per il 1973
assegnati e destinati alla costruzione di asili nido; l’istituzione
di corsi professionali per puericultrici ed i contributi per
consentire alle partecipanti di poterli frequentare.
Le linee di azione dell’UDI
erano state tracciate nel corso dell’ultima riunione del
comitato provinciale. Nel documento ufficiale il comitato «prende
atto che l’aggravarsi della crisi economica nazionale ha reso
insostenibili i livelli di vita nella regione, colpendo in maniera
particolare le condizioni di vita e di lavoro per le donne, alla
quali si vuole far pagare il maggior costo della crisi economica.
All’aggravarsi oggettivo della crisi è corrisposta una
tendenza d’immobilismo, di paralisi e di impostazioni
conservatrici a livello degli enti pubblici ed in modo particolare a
livello del governo regionale, che ha disatteso le aspettative della
massa femminile vanificando anche la realizzazione della rete di
asili nido e di corsi di qualificazione professionale per le
puericultrici, i cui fondi assegnati giacciono inutilizzati da
tempo»
Il documento sottolinea
inoltre la necessità di legare il piano di asili nido a quello
dei consultori e ad una nuova legge per il diritto allo studio «che
dia realmente a tutti la possibilità di istruirsi ed educarsi
in una scuola moderna e rinnovata e cancelli tutti i carrozzoni
clientelari e gli sperperi che tanto hanno aggravato il dispendio di
fondi pubblici»
Nel 1977, in tal senso, viene
presentato un piano alla regione.
Divorzio
Nel
1971 l’UDI di Catanzaro apre una riflessione dedicata alla
riforma del diritto di famiglia. L’attività viene
portata avanti con l’organizzazione di un primo ciclo di
conferenze da tenersi all’interno del teatro comunale l’8,
il 16 e il 19 febbraio. L’intento è quello di dare
inizio ad un confronto democratico di opinioni sui problemi che
investono il diritto di famiglia. Durante gli incontri vengono
affrontati i temi della “condizione della donna oggi“ (a
cura dell’avv. Giovanni Lamanna), della “podestà
nell’attuale diritto di famiglia” (a cura dell’avv.
Aldo Stigliano) e dei “progetti di riforma del diritto di
famiglia” (a cura dell’avv. Luigi Tropeano). Nel corso
del primo dibattito l’avv. Lamanna ha messo in luce il grave
stato di arretratezza che la regione vive e sottolineato di
conseguenza quello della condizione femminile: il 63% della
popolazione in età lavorativa è costituita da donne e
di queste solo il 7% ha un posto di lavoro. Della condizione della
donna nel diritto civile si è occupato l’avv. Stigliano
che ha rilevato le contraddizioni tra codice civile e Costituzione,
soprattutto negli articoli 3 e 39 di quest’ultima che
sanciscono parità dei cittadini e dei coniugi. L’avv.
Tropeano ha affrontato i vari problemi con un’ottica politica.
La prima domanda che ci si pone è il perché i problemi
del diritto di famiglia siano stati tanto disattesi: la risposta
dell’UDI è che «le forze più reazionarie e
più retrive hanno difeso a spada tratta l’attuale
struttura famigliare gerarchica e autoritaria, il mutamento della
quale, non c’è dubbio, rappresenta, in senso
democratico, la base fondamentale di una società meno
autoritaria e meno gerarchica»27.
Durante le introduzioni ai dibattiti, infatti, Anna Maria Longo
ribadisce e rilancia l’unità antifascista tra le varie
forze democratiche, chiama a questa unità tutte le
organizzazioni e associazioni femminili ed i movimenti femminili dei
partiti democratici, perché la democrazia che si vuole far
avanzare tenga conto di contenuti e valori senza i quali non si
arriverebbe alla sua concreta realizzazione. Inoltre, a proposito
della riforma del diritto di famiglia, la Longo esplicita la sua
concezione gramsciana della famiglia intesa come centro di vita
morale e di solidarietà. Nel febbraio del 1974, un’altra
tavola rotonda promossa dall’UDI di Catanzaro ha per tema “Le
donne di fronte alla crisi e al referendum: nuovi impegni di lotta
per la propria emancipazione, per la democrazia e per il rinnovamento
della società e della famiglia”. In tutti gli
interventi, fra cui quelli di Vittorio Todaro, consigliere nazionale
ACLI, di Anita Pasquali, della commissione femminile nazionale del
PCI ed di Enrica Lucarelli, responsabile nazionale della commissione
femminile del PSI, si è data particolare rilevanza al quadro
politico generale italiano e alla crisi che investe il paese. Queste
le parole di Anita Pasquali: «Il referendum è una grave
manovra che vorrebbe abrogare una di quelle poche leggi che abbia
veramente funzionato nel nostro Paese. Il PCI non lo voleva perché
sapeva benissimo quali pericoli nascondeva e non già per
paura; perciò ora esso è già vivamente impegnato
nella lotta anche se per noi resta il referendum della discordia e
della divisione»28.
Il 24 aprile a conclusione del ciclo di conferenze verrà
organizzata una “tavola rotonda” dal tema “Motivi e
proposte per una riforma del diritto di famiglia”. Il 18, 29 e
30 marzo del 1974 sono dedicati dall’UDI tre seminari di
aggiornamento per approfondire i problemi giuridici e politici
inerenti alla campagna sul referendum. È qui che viene
lanciata per la prima volta l’idea di una Consulta Regionale
costituita in modo rappresentativo da tutte le organizzazioni
femminili. «Ci battiamo per l’approvazione della Riforma
del Diritto di Famiglia, perché è una grande conquista
di libertà! Siamo convinte che questa conquista rappresenti
non solo un grande fatto di rinnovamento giuridico, morale,
democratico della famiglia e della società italiana, ma essa è
la base per il riscatto delle condizioni di vita e di lavoro della
donna, di questa protagonista nuova della società italiana
degli anni ’70, che è presente, si organizza e combatte,
oltre che nelle lotte dure delle fabbriche, dei campi, delle scuole e
nei posti di lavoro, in tutte le altre lotte popolari e democratiche
con una propria tematica e articolazione rivendicativa»29.
È l’azione politica di massa - secondo Anna Maria Longo
- a dover spingere le forze governative a difendere gli interessi
primari delle masse femminili dall’attacco di un disegno
conservatore e reazionario che vorrebbe scaricare sulle spalle delle
donne i pesi maggiori della crisi economica. Il 12 e 13 maggio 1974
si tiene il referendum abrogativo della legge sul divorzio: «Fino
ad arrivare alla grande battaglia del '74 sul divorzio. Quella
l'abbiamo vissuta in solitudine, perchè lo stesso PCI non ci
credeva in questa battaglia. Ci fu una grande mobilitazione, non solo
nelle città, ma anche nelle campagne, nelle sezioni. Donne che
avevano delle perplessità, e ti ponevano il problema: noi
siamo consapevoli che nostro marito la sera viene ubriaco, ci
costringe a stare a letto con loro e ci mette pure incinte; ma se gli
diamo la possibilità pure di divorziare, come viviamo? Era il
problema economico che loro portavano avanti. E allora noi ad
assicurarle che avrebbero avuto dei diritti, che non era possibile
sopportare questo inferno. Comunque in Calabria, esclusa Reggio
Calabria (dove la battaglia è stata persa) noi abbiamo avuto
un successo che non era sperabile. C'è stato un tasso di
democrazia alto, messo in evidenza da queste battaglie.».30 Nel
novembre del 1974, in vista della manifestazione nazionale del 13 a
Roma promossa dall’UDI sul diritto di famiglia, l’UDI di
Catanzaro indice un’assemblea nella quale emergono le richieste
prioritarie dell’organizzazione: «Asili nido e scuole
materne per i propri bambini, una scuola a tempo pieno che garantisca
il “Diritto allo Studio” per tutti e dia lavoro e
occupazione alle migliaia di diplomate e laureate disoccupate; case
decorose a basso costo in cui abitare, assistenza sanitaria,
consultori di maternità, assistenza per gli anziani; trasporti
e servizi pubblici; l’utilizzazione stabile e qualificata per
milioni di energie produttive costituite dalle masse femminili, a cui
finora è stata offerta, quando e come è piaciuto ai
gruppi monopolistici, un’occupazione saltuaria, di riserva,
dequalificata, a sottosalario e nei margini e ruoli più
umilianti e mortificanti»31.
Relatore ufficiale è l’avv. Mario Casalinuovo,
consigliere regionale del PSI, il quale ha sostenuto che «la
mobilitazione di Roma deve interessare non soltanto le donne ma tutti
i democratici italiani, laici e cattolici, perché il problema
di una famiglia civile e democratica è problema fondamentale
di tutta la società e presupposto reale per una svolta
progressista del paese»32.
Nel suo intervento traccia per grandi linee la storia della riforma
del diritto di famiglia, attraverso gli atti della Costituente, le
previsioni costituzionali, i progetti di legge fino ad arrivare al
primo progetto governativo del 1963 (con il quale alla donna veniva
riconosciuta nel lavoro pari capacità di quella maschile a
tutti i livelli) «quando già, due danni prima
l’onorevole Fortuna aveva presentato il suo primo progetto per
il divorzio»33
Aborto
In
piena mobilitazione per la legge sull’aborto, le donne UDI
partecipano alle manifestazioni nazionali con propri volantini. In
uno di questi si legge: «Abbiamo lasciato le nostre case,
abbiamo viaggiato per tante ore, veniamo da Catanzaro per esprimere
insieme a te la nostra solidarietà di donna su un dramma che
finora abbiamo vissuto in silenzio»34
e raccolgono le firme per una petizione al Senato «per dire che
su quello che il movimento delle donne ha conquistato non si torna
indietro; per dire che devono far presto ad approvare la legge;
purché nella legge ci siano tutte le garanzie pratiche per
rimuovere ogni ostacolo alla sua piena applicazione»35.
Nel
volantino UDI dell’8 novembre, in cui si invita alla
partecipazione alla manifestazione regionale da tenersi a Cosenza in
difesa della 194, l’aborto viene definito un dramma doloroso,
sempre esistito e praticato nella solitudine dalle mammane con gravi
rischi per la salute.
La
194 ha in parte risolto il problema della clandestinità ma,
quando ancora molti sono i passi da compiere, si tenta di affossarla
a colpi di referendum. Dopo anni di battaglie per l’applicazione
della legge, approvata il 22 maggio del 1978, bisogna ritornare a
difenderla. Così si legge sul volantino sopra citato: «La
legge non ha certo inventato l’aborto, ma ha preso atto di una
realtà dolorosa e ha cercato di dare risposte che rispettino
la dignità e la sicurezza della donna. Grandi masse di uomini
e di donne, indipendentemente dalle convinzioni politiche, hanno
sostenuto il ruolo di uno stato laico che affronti i delicati
problemi della maternità e i suoi rilevati risvolti sociali.
Per questo hanno lottato e continuano a lottare. La legge 194 è
frutto di uno sforzo lungo e serio per far fronte ad una piaga
secolare, per liberare la donna dall’aborto. Dobbiamo
salvaguardarla con fermezza e farla funzionare correttamente ovunque.
Questa legge non si tocca»
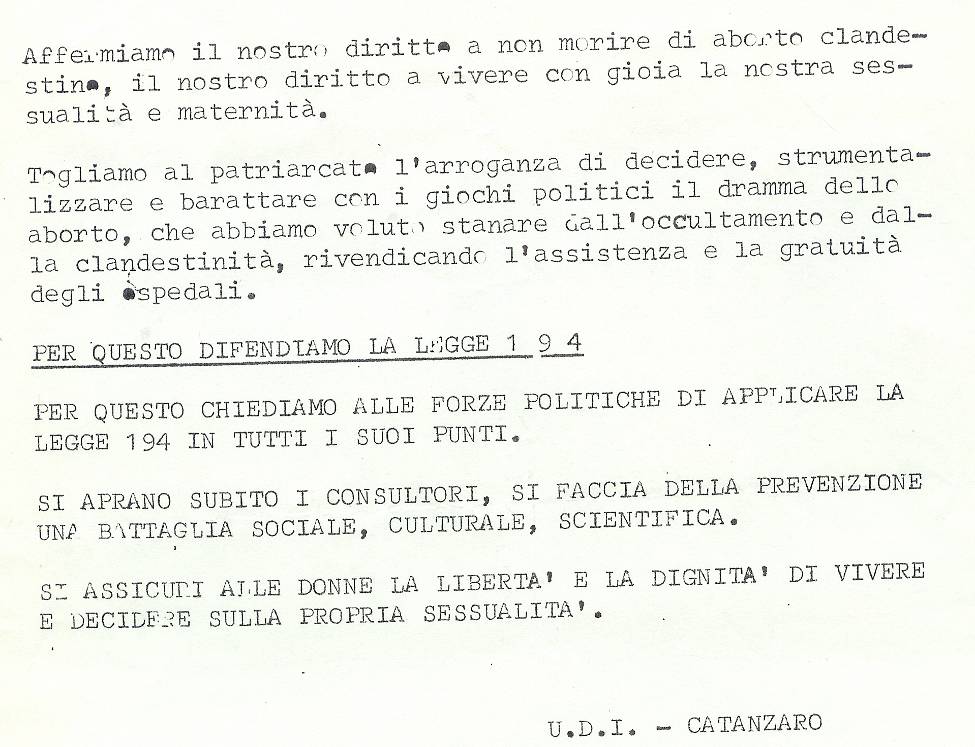
VOLANTINO
UDI CATANZARO IN DIFESA DELLA 194
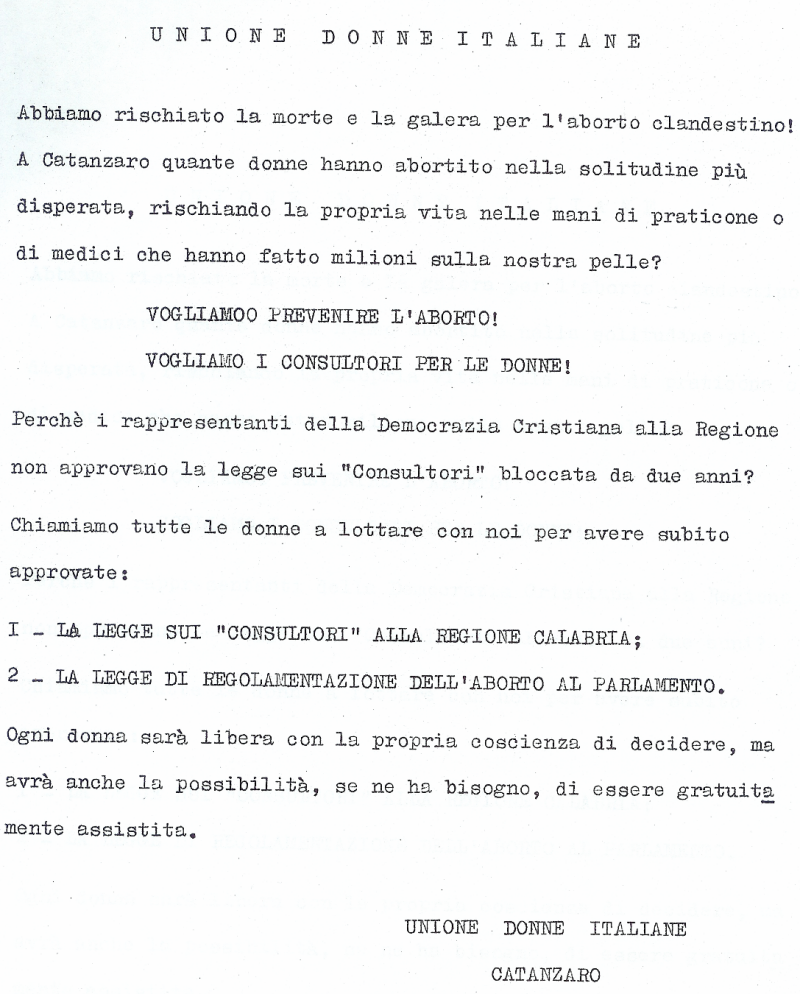
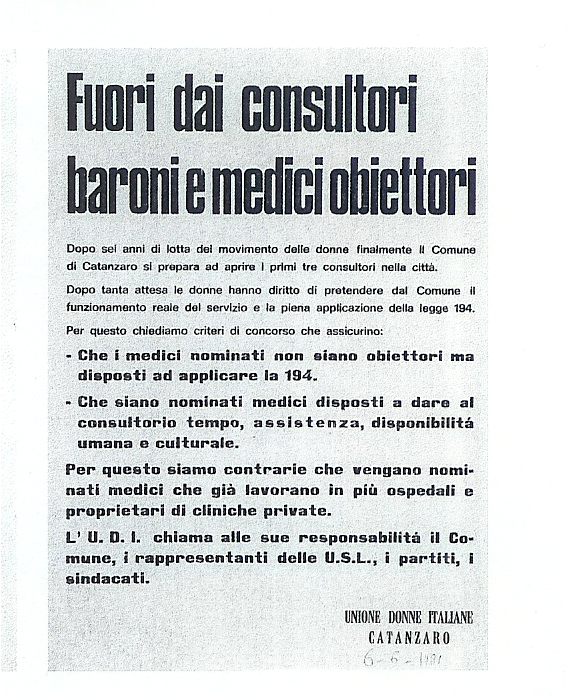
MANIFESTO
UDI CZ BATTAGLIA CONSULTORI
Gli anni ‘80 sono gli
anni della crisi innescata dalle profonde ristrutturazioni
industriali che impongono un duro arresto alla stagione di
avanzamento del movimento dei lavoratori e delle conquiste sindacali.
La crisi industriale, il declino della unità sindacale, il
clima di tensione creato dai ‘diversi’ terrorismi, la
difficoltà di gestire le differenze che si manifestavano tra
le donne e all’interno dei movimenti femministi, tutto ciò
pone termine alla stagione di lotte: continua da un lato
l'elaborazione teorica di intellettuali e filosofe condotta in ambiti
separati, e dall'altro l'attività delle donne nelle
organizzazioni sindacali, in particolare nella CGIL, e nei partiti.
Cessa l'esperienza delle "150 ore delle donne".
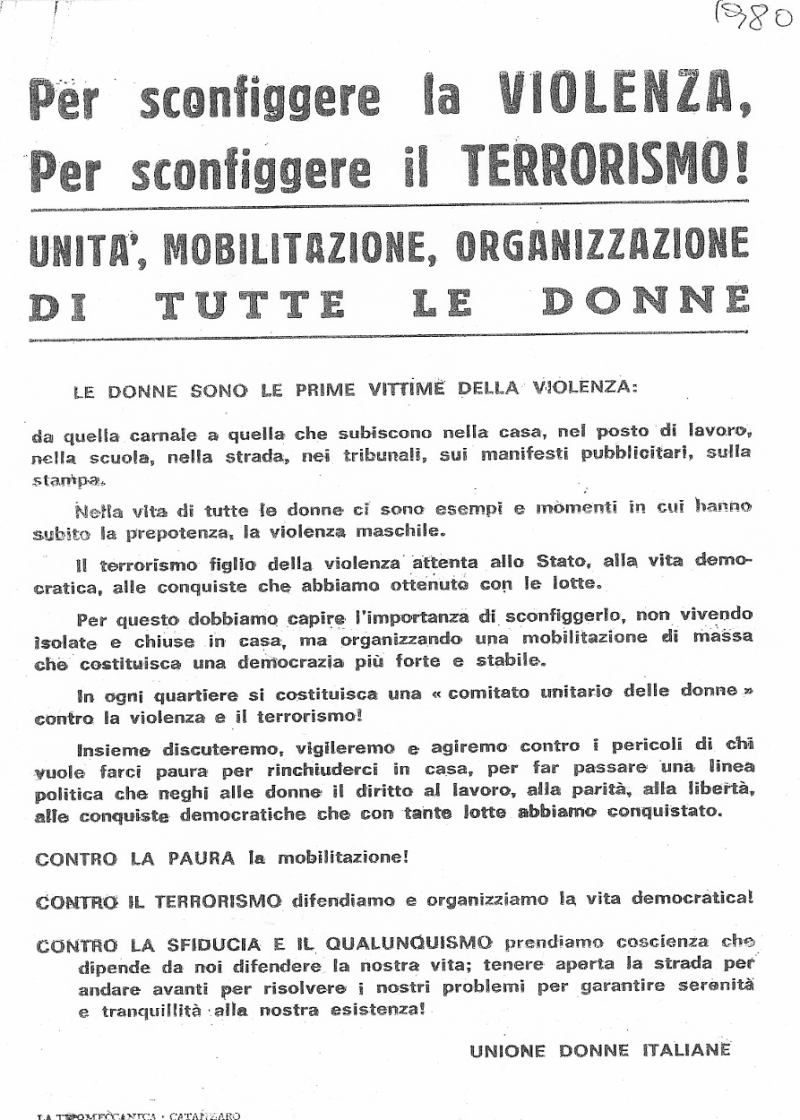
VOLANTINO
UDI CATANZARO CAMPAGNA DI MOBILITAZIONE CONTRO LA VIOLENZA E IL
TERRORISMO
Le
ultime attività
Nel
discorso introduttivo al convegno Anna Maria Longo parte dalla
constatazione che tutte le donne che hanno reso testimonianza non
hanno mancato di sottolineare l’immenso dolore che il parto
provoca, “un dolore, uno sfinimento, il senso della morte e
della fine” e si domanda: «si può forse amare di
più? Vi è capacità e facoltà di amare più
grande di questa spasmodica contrazione fisica d’immenso dolore
per poter generare un’altra vita? »36.
Per
l’UDI è ormai necessario dare una valenza politica a
questo rapporto, creare spazi in cui questa “diversità”
possa esprimersi senza essere sopraffatta. «Un nuovo ordine del
mondo, degli Stati, delle società, delle Istituzioni; dal modo
di produrre, di lavorare, di consumare, di legiferare, di spendere,
di focalizzare la vita ed i suoi interessi, questa è la
dimensione progettuale del nostro partorire, del nostro scegliere di
dare la vita ad altri essere umani»37
«Riappropriamoci
del parto, contestando poteri che ora assumono le vesti del padre,
ora quelle del medico, ora quelle della struttura ospedaliera, ora
quelle del legislatore, ora quelle della scuola, ora quelle del
mercato e della divisione del lavoro, ora quelle di ogni distorsione
economica, sociale, geografica, vuol dire far camminare la nostra
rivoluzione, vuol dire salvare l’umanità attraverso il
nostro bisogno di amore. Riappropriarsi del parto è la nostra
risposta di solidarietà, è continuare la lotta delle
donne argentine, delle madri di Plaza de Majo»38
I
risultati del convegno sono 27 racconti in risposta ai questionari e
la carta dei diritti della partoriente.
La
maggioranza di queste donne racconta di non aver avuto informazioni
sul parto.
Cambia
il modo di vivere perché cambia il modo di lavorare
è il titolo di uno degli ultimi convegni organizzati, in
riferimento al quale Longo dice: «Noi nell'84 facemmo un
convegno su come cambiava il modo di lavorare e di vivere con
l'informatica; è stato un convegno bellissimo, in cui noi
analizzammo i tempi delle donne, in rapporto alla macchina, il
passaggio dal lavoro manuale al lavoro con la macchina (anche negli
uffici), facendo un'inchiesta accurata. Ci preoccupammo di questa
meccanizzazione, come pericolo che sovrastava la libertà delle
donne, anche durante il lavoro. Capimmo allora che c'era, in un certo
senso, quasi una deresponsabilizzazione nel lavoro, un delegare tutto
alla macchina, quindi un chinarsi delle capacità di
organizzarsi il lavoro, di riflettere sul lavoro. C'erano i pro e i
contro di questa rivoluzione informatica.»Così Delia
Fabrizi descrive gli ultimi anni dell’esperienza Udi
catanzarese: « Dopo l’XI Congresso abbiamo realizzato una
serie di iniziative (l’XI Congresso è quello che ha
destrutturato il verticismo dell’UDI) e abbiamo fatto corsi e
percorsi molto interessanti, di cui ourtroppo, con la superficialità
con cui troppe volte noi donne consideriamo i lavori che facciamo,
non abbiamo pubblicato gli atti. E questo lavoro era su Virginia
Woolf, su Adrienne Rich, su Edith Warton e poi, in seguito, il gruppo
rimasto ha lavorato per realizzare l’ultima parte del progetto,
che abbiamo intitolato “Perchè la madre? Ipotesi sul
rapporto madre-figlia.”(...)Il seminario sul rapporto
madre-figlia aveva aperto una falla in ognuna di noi; eravamo
nell’85, in epoche molto primitive. Ricordo di quel periodo che
andammo a Roma Ketty Dominianni ed io per realizzarlo e venne Maria
Luisa Boccia...(...)...Mi ricordo che venne Maria Grazia
Minghetti...(...)»39.
Ma
si era ormai alla conclusione dell’esperienza dell’UDI
catanzarese: «...un problema di diaspora, perchè le
nostre vite, a un certo punto, hanno portato ognuna di noi per una
strada diversa, alla ricerca di un percorso proprio. Mantenendo,
però, con la maggior parte, un rapporto
affettivo...(...)...Seguivo...da Adriana (Papaleo) sapevo (lei era
una delle Garanti nazionali dell’UDI) quello che succedeva a
livello nazionale, ma non ho avuto più il desiderio, il
tempo...non di stare tra donne...ma di fare politica».
2.2
UDI: Circolo di Soverato

COLLETTIVO
DI ZONA: RINA TROVATO, ADRIANA PAPALEO, ANNAMARIA LONGO, ADRIANA
LERRO, MARIA GIOVANNA GRILLONE, ASSUNTA DI CUNZOLO
Nei
primi anni Settanta era nato un circolo UDI ad Argusto, la cui
attivita' si incentro' principalmente sulle campagne referendarie
riguardanti il divorzio e la 194. Il circolo conclue la sua attivita'
nel 1978 quando la sua responsabile, Lisa Maltese, si trasferi' a
Catanzaro. Nel
1976 era attivo il circolo UDI di Soverato. Così ricostruisce
la sua nascita Assunta Di Cunzolo: “una compagna di partito,
Maria Scarfone, unica donna nel Consiglio Comunale di Soverato con il
PCI all’opposizione, mi fece conoscere Annamaria Longo in
occasione di un comizio in piazza. Annamaria era la responsabile
provinciale dell’UDI di Catanzaro e fu la mia prima maestra di
politica...... . Maria Scarfone stava costituendo il circolo Udi a
Soverato ma non aveva intenzione di assumerne la responsabilità
perchè impegnata nel suo lavoro nel Consiglio Comunale e nel
partito; fui contenta quando mi propose di costruire questa cosa.”
Il
primo gruppo di donne si aggregò intorno al problema della
carenza dei servizi sociali nella zona, partendo dalle proprie
immediate necessità di giovani madri;
il
gruppo iniziò a riflettere sul “valore sociale della
maternità”, che era la tematica su cui l’UDI
nazionale e
provinciale
stava lavorando in quegli anni. Ad Assunta e a Maria si unirono sin
dall’inizio Adriana Lerro, Saveria Ciaccio, Rosa Mangione,
Maria Grazia Riveruzzi, Zina Lupo, Marina Prezzo, Laura Dominjanni,
Betty Moraca, Anna Screnci, Caterina Cilurso, Karen Serraino e
Francesca Fondacaro, tutte quasi trentenni o poco più; ma in
breve il circolo riuscì ad attirare anche donne più
giovani: Giovanna Grillone e Rosetta Carchidi, Marianna De Paola e
ragazze come Teresa Corapi, Luigia Barbieri, Eugenia Gallo, Katia
Tassone, Virginia Aloisio, Teresa Ciaccio. Oltre al lavoro di
riflessione interna,
il
gruppo si rapportò costantemente con l’esterno e con
l’Amministrazione Comunale avanzando richieste e accendendo
conflitti per la realizzazione dei servizi: asili –nido, mensa
e tempo pieno
nella
scuola elementare e materna, consultorio. Nel 1976 il circolo riesce
a far attuare il tempo pieno con un regolare servizio di mensa nelle
scuole materne, redige il regolamento per il funzionamento dell’unico
asilo nido comunale e ne ottiene la gestione sociale con la
rappresentanza delle utenti; fornisce inoltre all’Amministrazione
Comunale il bando per ottenere i finanziamenti necessari per la
costruzione di un nuovo asilo nido e una scuola materna che verranno
realizzati e ospiteranno in locali idonei i piccoli utenti finora
costretti in
appartamenti
o
buchi
di garage. «Di quel periodo ricordo i volantinaggi davanti alla
scuola materna ...., i comunicati e le interviste a radio Soverato,
fatte a rotazione da tutte perchè nessuna di noi aveva piacere
di esporsi, e seguite dall’immancabile recarsi dal Sindaco o
dall’assessore preposto per rivendicare un diritto...»,
riferisce ancora Assunta in una intervista. Se rivendicare un diritto
richiedeva impegno, in quegli anni “trasgredire” rispetto
ai costumi e alle tradizioni richiedeva di mettere in discussione
soprattutto l’educazione ricevuta e i confini delineati a
limitare
la propria
libertà:
«Nel 1976 iniziammo a festeggiare l’8 marzo anche qui a
Soverato. In quella occasione i camerieri si mostrarono palesemente
contrariati nel dover servire tavoli di sole donne, assumendo
atteggiamenti volutamente sgarbati. Avevamo finalmente raggiunto un
traguardo, ma il passaggio dalla liberazione alla libertà era
ancora ben lontano dall’essere conquistato». Intanto, in
linea con la tendenza nazionale e per contaminazione delle pratiche
femministe, anche all’interno dell’associazione locale si
manifestò l’esigenza di riunirsi in piccoli gruppi di
“autocoscienza”. Erano soprattutto le più giovani
ad avere l’esigenza di comunicare e confrontare esperienze di
vita e difficoltà nell’intento di rompere l’isolamento
in cui ciascuna viveva desideri ed emozioni considerati allora
indicibili. Anche se, al di là del gruppo, come testimonia
Rosetta Carchidi molti anni dopo in un articolo di Antonella
Mongiardo sul giornale locale “Ioniostar”, «le
donne conducevano la vita di sempre, quella di mogli e mamme, tutt’al
più impegnate anche nel lavoro fuori casa».
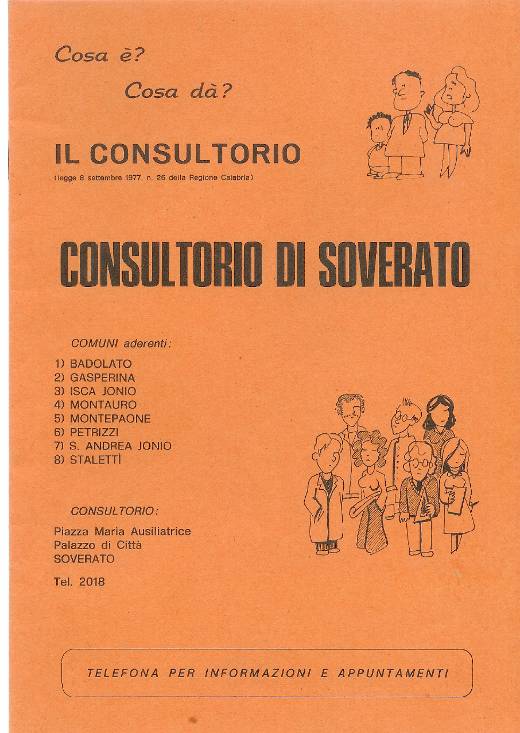
BROCHURE
DEL CONSULTORIO DI SOVERATO
Il
1975 è l’anno della legge nazionale sui consultori; l’11
giugno del 1977 le donne dell’UDI di Soverato indicono la prima
assemblea pubblica che ha per tema “I Consultori”.Il 25
giugno del 1977 all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di
Soverato c’è l’approvazione del Consultorio
Pubblico; relatrice è la consigliera di minoranza Maria
Scarfone. Le donne dell’UDI piantonano l’aula consiliare
riuscendo infine ad ottenere la delibera istitutiva del consultorio
che nasce come servizio comunale: «Tutto ci avevano insegnato e
tutto avevamo imparato, e, tra le cose che ci avevano insegnato,
c’era quella che il nostro corpo era vergogna e offesa per la
collettività; era quindi da nascondere e i suoi istinti
(emozioni diremmo oggi) da reprimere. Ricordo la ricerca affannosa
dei giri di parole utili a soppiantare ‘sesso’ e
‘sessualità’ soprattutto quando io e Maria
Scarfone abbiamo redatto l’intervento che lei avrebbe dovuto
fare in Consiglio Comunale per proporre l’istituzione del
Consultorio, ancor prima dell’istituzione dell’USL e
dell’approvazione della Legge Regionale. Fu una mobilitazione
incredibile, fatta nei quartieri e casa per casa, da tutte, madri e
figlie, ragazze e adulte, che si scontrava qui con una cultura
profondamente e diffusamente cattolica anche perchè gli studi
venivano in gran parte compiuti presso le scuole private gestite da
salesiani e salesiane. La presenza costante delle donne nella sala
consiliare indusse la maggioranza ad uscire di scena e, in seconda
seduta, con la sola coraggiosa presenza dell’assessore anziano
Antonino Maida e della minoranza PCI, passò all’unanimità
la proposta avanzata da Maria. Fu una vittoria che ci inorgoglì
molto; ci credevamo ormai forti, potenti e potevamo alzare il tiro».
Per oltre un biennio questo consenso rimase solo su carta.
Nel
1978 verrà approvato il regolamento, che ne garantiva la
gestione a donne utenti elette dall’assemblea delle utenti in
numero pari alle rappresentanze istituzionali previste da norma. Al
di là delle figure professionali femminili previste -una
ginecologa, una psicologa, un’assistente sociale e
un’infermiera professionale-, la responsabilità politica
e la gestione del consultorio era affidata al comitato di gestione
come previsto dalla normativa nazionale (art. 3 Legge n.26\77): un
rappresentante del distretto scolastico, un coordinatore del gruppo
di lavoro delle figure professionali; tre rappresentanti sindacali;
un rappresentante del consiglio di fabbrica; un rappresentante per
ciascuna organizzazione femminile a carattere nazionale fino a un
massimo di cinque persone; un numero di utenti da stabilire.
Nel
caso di Soverato fu stabilito che questo numero fosse pari al numero
degli altri componenti del comitato, così da avere una
gestione dettata dall’utenza e tutta al femminile. Il
consultorio a Soverato nacque come servizio comunale, prima ancora
dell’istituzione delle USSLL con cui il circolo UDI ebbe un
costante rapporto conflittuale sia riguardo le finalità del
servizio sia riguardo la gestione dettata dell’utenza e tutta
al femminile.
«Nelle
sue funzioni il consultorio di Soverato intende aderire e applicare,
in ogni sua parte, i criteri sanciti dalla legge 405\75, dalla legge
194 e dalla legge regionale n.26 del 1977, criteri che vogliono
assicurare ai cittadini\e un servizio specialistico, di assistenza
psicologica, sociale e sanitaria per la preparazione alla maternità
e alla paternità responsabile, ai problemi del singolo\a,
della coppia e della famiglia e alla problematica minorile».40
Ma il consultorio di Soverato resisterà nella sua funzione e
organizzazione iniziale, di servizio per la donna e della donna,
ancora fino alla prima metà degli anni ’90. Nel 1979, in
una lettera aperta sul “Giornale di Calabria” l’UDI
denunciava la carenza dei consultori familiari in Calabria (ancora
solo tre, nonostante fossero passati quattro anni dalla legge
nazionale e 57 fossero state le delibere in
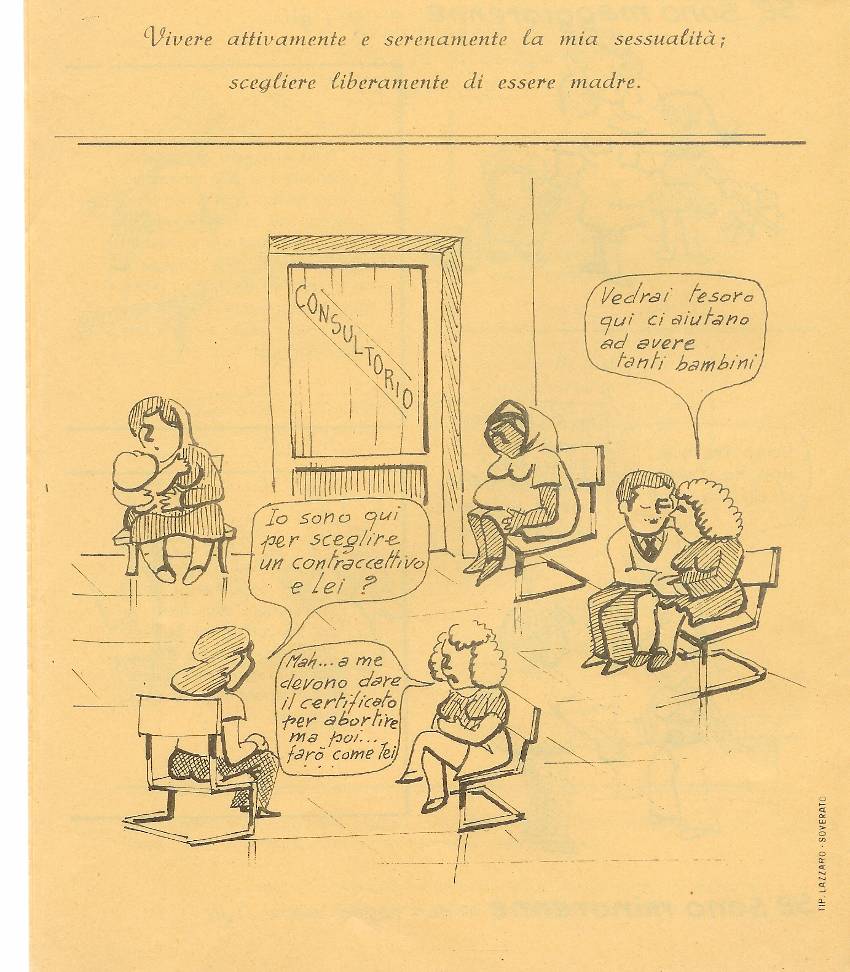
VIGNETTE
INFORMATIVE DIFFUSE DAL CONSULTORIO DI SOVERATO
tutta
la regione) e spiega la tortuosa vicenda del consultorio di Soverato:
«alle nostre pressioni per la realizzazione pratica del
servizio l’Amministrazione Comunale rispondeva con un carosello
di resistenza, incuria, ignoranza e interrogazioni. Arriva la tanto
attesa giunta di centro-sinistra ed ecco che sembra aprirsi uno
spiraglio di luce. Ma di fronte al problema delle assunzioni del
personale si erge un ennesimo ostacolo. ...Dopo quattro anni dalla
legge nazionale, la Regione Calabria e le molteplici amministrazioni
comunali stentano ancora oggi ad aprire gli occhi e a prendere
visione di una realtà che, nonostante le loro goffe
resistenze, sta profondamente evolvendosi.... ».
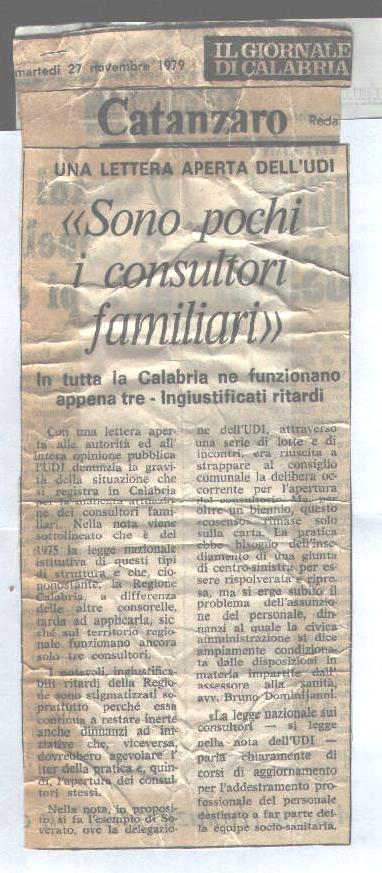
Nel
1979 saranno disponibili i locali dell’Hotel delle Terme, ma
solo nel marzo del 1980 il consultorio verrà aperto. In
seguito, con il trasferimento della gestione alle USSL, i comitati di
gestione dei consultori verranno soppressi o sostituiti da un unico
comitato di gestione dell’USSL, privilegiando l’aspetto
sanitario, medicalizzando tutto il servizio e trascurando la funzione
psico-sociale. Nonostante il trasferimento della gestione alle USSL,
il consultorio di S overato riuscì a mantenere le sue
caratteristiche, anche grazie al lavoro al suo interno di due
operatrici, Luigia Barbieri e Teresa Ciaccio, e alla conduzione
politica delle presidenti del comitato di gestione che si sono
succedute (Zina Lupo, Maria Grazia Riveruzzi, Marisa Gigliotti).
Questa la testimonianza di un’operatrice, Teresa Ciaccio: «Ho
iniziato a lavorare nel consultorio nel luglio del 1980. All’inizio
conoscevo poco del mio lavoro; ho imparato e continuamente imparo
grazie agli incontri quotidiani, alla ricchezza delle storie di vita
che ricevo in dono ogni volta che entro in relazione con le persone.
In questo processo di apprendistato ho imparato soprattutto dalle
donne, dalla loro storia, segnata spesso da una mancanza quasi totale
di consapevolezza di sé, del proprio valore, relegato nella
coppia e nella famiglia ad assumersi responsabilità e pesi
senza comprendere la potenza creativa del proprio lavoro»42.
Teresa si iscrisse all’Udi dopo avere incontrato nel
consultorio le donne dell’associazione. Assunta ricostruisce
così quegli anni in riferimento ad un suo intervento ad una
manifestazione dell’Udi nazionale alla basilica di Massenzio a
Roma nel ’77: «...”argomenti mai affrontati prima
dalle donne di Soverato in assemblee e pubblici dibattiti, come la
contraccezione, l’aborto e la sessualità, vengono ora
discussi in ogni
sede”,
cercando di veicolare il messaggio di una sessualità femminile
finalmente libera dalla vergogna e su cui ogni donna, educata a
disconoscere il proprio corpo, doveva e poteva interrogarsi per
liberarsi da un’educazione e cultura che, dalla nascita e a
prescindere dalla posizione sociale, imponeva alla coscienza singola
e collettiva di considerare la donna esclusivamente in relazione ai
bisogni del maschio a prescindere e nel soffocamento del proprio
desiderio»43
. Ci volle ancora un decennio perchè il consultorio potesse
rivolgersi alle giovani attraverso le scuole; la resistenza era
opposta
da
presidi e docenti oltre che dai genitori. A tale proposito per l’anno
1991\1992 il comitato di gestione presentò un programma di
massima rivolto soprattutto all’educazione alla salute delle
giovani. Sarà la Dott.ssa Carmen Leccardi del dipartimento di
Sociologia dell’Università della Calabria ad inaugurare
l’anno dedicato ai giovani in un incontro-dibattito del 12
ottobre 1991. Le tematiche relative alla conoscenza del corpo e della
sessualità e all’affermazione della propria
autodeterminazione avevano preso forma e sostanza con il X Congresso
Nazionale UDI che fu il Congresso della valorizzazione della
“diversità” nell’essere donna,
dell’individuazione della propria oggettivazione sessuale e
della traduzione politica dell’essere soggetti nelle proprie
scelte. E’ anche però il Congresso dell’autonomia
dal PCI e dagli altri partiti della sinistra e del separatismo
rispetto la politica dei luoghi misti. Alcune si recano a Roma per
partecipare attivamente, altre organizzano a Soverato riunioni di
piccoli gruppi nei quartieri. Il 1979 è l’anno della
proposta di legge ad iniziativa popolare contro la violenza sessuale:
“Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la
violenza sessuale e fisica contro la persona”. Questi gli
intenti dell’azione: «Un tentativo per modificare il
costume e la mentalità prevalente nella nostra società;
Non ci illudiamo, infatti, che serva cambiare il codice penale, senza
prima aver compiuto una campagna di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica su argomenti e problemi mai affrontati prima di ora o
affrontati male. La nostra azione riguardo la suddetta iniziativa
sarà pertanto duplice: da una parte le proposte concrete,
tecniche, qual è la proposta di legge (che abbiamo fatta
nostra) sulla violenza sessuale; dall’altra un’ azione
continua e il più capillare possibile sull’opinione
pubblica»44.
Viene organizzata una raccolta di firme e si tenta di far passare il
messaggio che il reato di violenza sessuale colpisce “una e
tutte”, a causa della storia collettiva di oppressione
sessuale. In quest’ottica vengono affrontati i temi della
casalinghità che accomuna tutte, della famiglia,
dell’organizzazione sociale e del rapporto di coppia. Nello
spirito dei decreti delegati l’UDI sollecita la partecipazione
dei genitori alla vita della scuola materna, non più intesa
come area di parcheggio ma importante momento educativo per lo
sviluppo del bambino. Dal 1980 in poi il gruppo, che si è
ridimensionato dopo il X Congresso, limita le manifestazioni
all’esterno. L’attività principale è quella
culturale: bisogna, dicono, riappropriarsi della storia, della
cultura, della politica. Partecipano infatti ai seminari del
centro-studi UDI Catanzaro (da Sibilla Aleramo al neo-femminismo,
1981), leggono i libri dello “scandalo” e tentano di
recuperare le radici attraverso la storia e la letteratura a partire
dai movimenti e dalle scrittrici di fine Ottocento. Il gruppo
partecipa attivamente alla campagna referendaria per il no ai
referendum abrogativi della legge 194, sempre più convinte di
dover difendere innanzitutto il diritto di autodeterminazione di
ciascuna. Nel 1982 nasce il Centro di consulenza legale donna. Così,
Assunta Di Cunzolo ricostruisce quella esperienza: «Poi vennero
gli anni delle battaglie per cambiare le norme che non riconoscevano
il reato di stupro come crimine contro la donna; per il codice
esistente lo stupro era un reato contro la morale pubblica, e questo
era incredibile e inconcepibile. Inoltre in casa si potevano
consumare i crimini più terribili contro le donne da parte di
mariti, padri, fratelli e -non si comprende perché- tutto
restava impunito. E questi erano i crimini più diffusi qui,
quelli che si consumavano nelle famiglie, come poi avremmo saputo
attraverso il Centro di Consulenza Legale per le donne che il circolo
istituì quando Virginia Aloisio, giovanissima avvocata,
rientrò, dopo gli studi, a Soverato. Il Centro fu aperto nel
1982 e continuò a funzionare con Virginia, Luigia e Teresa
Ciaccio anche dopo la chiusura del circolo; funzionò fino al
1990, quando Virginia decise di continuare la sua professione a Roma
nello studio legale di Tina Lagostena Bassi, la famosa avvocata dei
delitti del Circeo, con la quale aveva iniziato a collaborare durante
il percorso del Centro Legale e per consulenze. Non si rivolse al
Centro una folla di donne come invece ci aspettavamo, ma quelle che
ebbero il coraggio di accedervi raccontavano di soprusi terribili in
famiglia cui erano costrette insieme a figli e figlie; così
relazionavano le amiche che se ne occupavano mantenendo il più
stretto riserbo sui nomi, ancora oggi nell’anonimato più
assoluto.»45
Nello stesso anno si partecipa al XI Congresso Nazionale con il quale
l’UDI decide il suo autoscioglimento: « Ai congressi
avevamo anche noi votato per demolire l’UDI come struttura
verticistica -lo slogan era ‘meno organizzazione, più
movimento’- ma, dopo il XII° congresso , che io sappia, non
ci riunimmo più nel circolo di Soverato. Forse la lettura del
Sottosopra Verde, forse la convinzione che tutto appartenesse ormai
al passato senza prospettive e senza speranza, forse la stanchezza,
forse non reggevamo più il conflitto all’esterno ma
soprattutto all’interno. Non ricordo con precisione…ma,
se avevamo bene imparato ad attivare antagonismi e mediazioni
all’esterno, non eravamo ancora pronte o, meglio, non avevamo
gli strumenti per imparare a gestire i conflitti tra noi; sapevamo
solo soffrirne oppure godere dell’attacco all’altra
oppure sottrarci andando via. E, alla fine, non tutte insieme ma
ognuna andò via. »46
L’ultimo documento in nostro possesso risale al 1983: una
pubblicazione sulle pagine autogestite della rivista Noi
donne,
nella quale viene illustrata l’attività del circolo Udi
di Soverato a cura di Virginia Aloisio, Stella Palermo, Luigia
Barbieri, Teresa Ciaccio, Marianna De Paola, Adriana Lerro, Zina
Lupo, Assunta Di Cunzolo. Nei primi anni ’80 era nato anche un
circolo UDI a Tiriolo, che operò nella prima metà di
quegli anni guidato da Rita Cimino. E’ l’ultimo gruppo
Udi di cui abbiamo avuto notizia.
UDI:
Circolo di Lamezia Terme
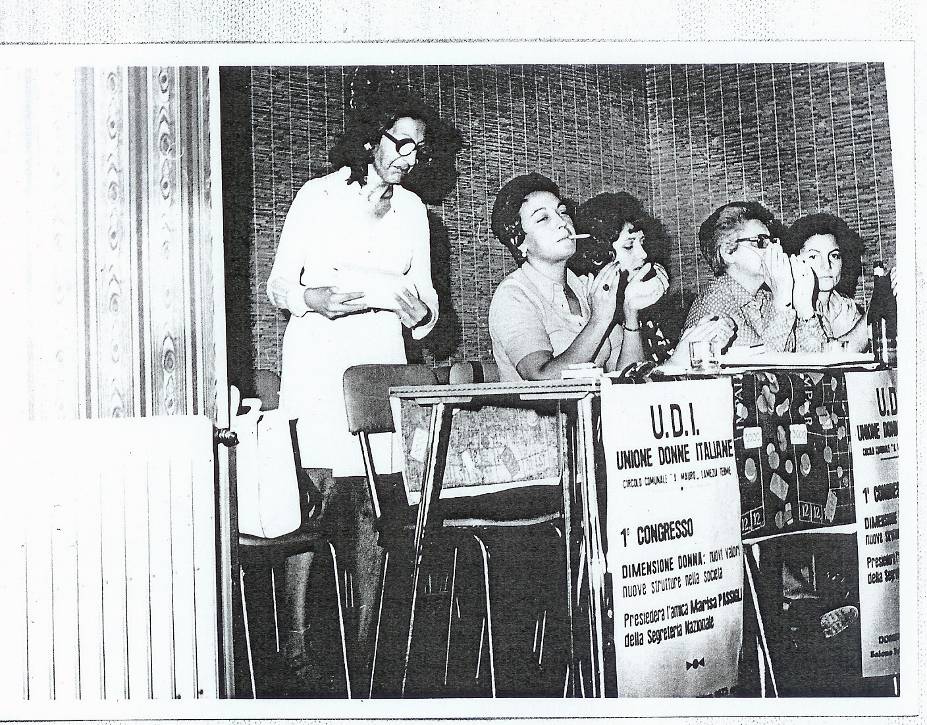
PRIMO
CONGRESSO PROVINCIALE: ANNA MARIA LONGO E VANNA DE PIETRO
La
nascita del circolo UDI di Lamezia Terme risale agli inizi del 1971.
Con il sostegno dell’UDI di Catanzaro viene aperta una prima
sede in Corso Numistrano al civivo 43, dedicata a Giuditta Levato.
Insieme a Vanna De Pietro ci sono le allora giovani studentesse Elsa
Gallina, Vera La Monica, Lucia Mercuri, Loredana Rubino e Maria
Spada. I primi strumenti di comunicazione sono la rivista “Noi
Donne” (diffusa dalle studentesse nelle scuole e dalle donne
nei loro quartieri), i volantini, i manifesti ma soprattutto gli
incontri, “dove ci si conosce, si socializza e si affrontano i
problemi del quotidiano”. Ed è qui che emerge come
priorità il problema dell’assenza quasi totale di
servizi sociali. «Il mio ragazzo mi disse che c'era questa
donna, questa architetta, che organizzava una riunione con delle
donne. Andai alla prima riunione addirittura. Mi piacque subito il
discorso. Comunque c'era materiale, c'erano cose da guardare, da
leggere. Poi l'UDI a Lamezia ha avuto un'organizzazione e un impulso
straordinari, perché sostanzialmente si sono organizzati dei
circoli, c'era proprio una rete organizzativa. Questo è stato
importante, ma è stato molto importante lo stare insieme tra
donne di generazioni diverse, di estrazioni sociali differenti. Tu
immagina: la studentessa con la bracciante del quartiere popolare, e
insieme a leggere “Noi Donne”, che è stata una
rivista importantissima, di rottura all'epoca. Io diffondevo le copie
di “Noi Donne” a scuola, abbiamo fatto un sacco di
incontri, molti con questo taglio sociale, dei quartieri popolari
nuovi che venivano costruiti a Lamezia, e lì la battaglia per
la luce, per i servizi pubblici, quindi c'era molto questo taglio
sociale.»47
Sotto
questa spinta sorgono presto altri punti di aggregazione nei
quartieri periferici: Razionale, San Teodoro, Bella e Campusano e
vengono aperte altre sedi dedicate a Irma Bandiera, Rosa Luxembourg e
Julieta Campusano. La crescita dell’organizzazione pone il
problema del finanziamento delle attività e allora le
insegnanti e le impiegate, tra le quali Clorinda Speranza, Maria
Porchia, Natalina Vescio, che fanno parte del gruppo dirigente,
sostengono l’UDI autotassandosi.
Le
più giovani organizzano nella sede piccole mostre e vendite e
si occupano della contabilità tenendo aperto anche nelle ore
serali.
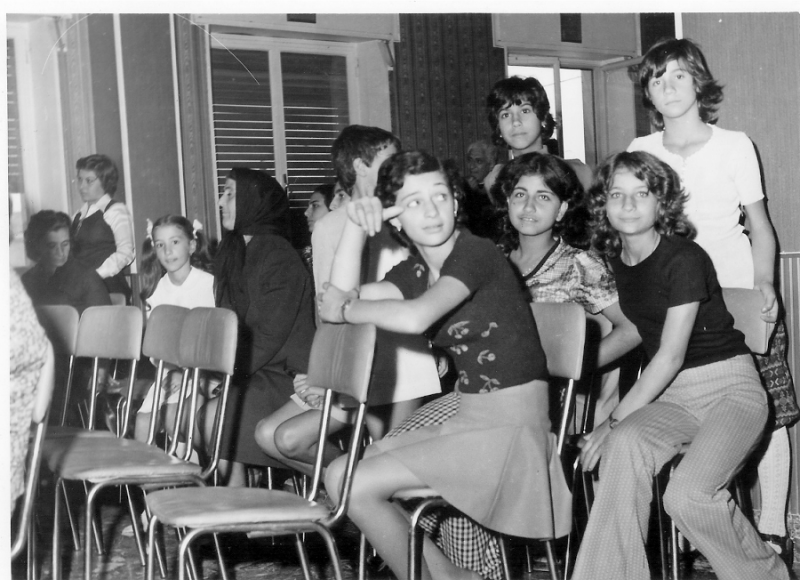
UN
INCONTRO CON LE DONNE DI BELLA (CZ)
Nel
1972, dopo una analisi sulla popolazione scolastica da 0 a 3 anni
(3980 erano i bambini nel comune di Lamezia Terme), l’UDI
elabora una indagine sul territorio comunale dalla quale risulta la
necessità di 73 asili nido. Il Comune, dopo vari incontri con
delegazioni di donne, eroga 60 milioni di lire per la costruzione del
primo asilo nido comunale. Parallelamente all’attività
esterna l’UDI apre una discussione culturale all’interno
dell’organizzazione, un ferrato confronto che inizia da un
lavoro di analisi delle riviste femminili di maggiore diffusione e
che termina con lo smascherare quell’ immaginario che non è
altro che il preludio dell’odierna invasione mediatica sul
corpo femminile. Vengono realizzate circa 300 diapositive, fatte
circolare poi anche in circoli UDI di altre regioni, in cui da una
parte viene proiettata la donna proposta dalle riviste, dall’altra
quella delle donne lametine nelle loro diverse realtà: da
quella dell’analfabetismo a quella delle contrade senza acqua e
senza luce. Nel gennaio del 1973, dopo l’alluvione, denunciano
gli sperperi di denaro pubblico e la conseguente negligenza delle
istituzioni preposte alla tutela del territorio e dei cittadini. Il
21 settembre, in occasione dello sciopero regionale indetto dalle
confederazioni sindacali è folta la presenza femminile. Il
mese di ottobre è dedicato invece ai congressi: il 21 ottobre
quello di Lamezia, la settimana successiva quello provinciale di
Catanzaro. Nel 1973 sono 241 le donne iscritte all’UDI e
organizzate nei quattro circoli territoriali, tra studentesse,
insegnanti, impiegate, disoccupate, casalinghe e contadine. Nel mese
di novembre si tiene a Roma il IX congresso nazionale e anche l’UDI
di Lamezia vi partecipa. Nel suo intervento Vanna De Pietro denuncia
la mancata concretizzazione del “pacchetto Colombo”,
presentato nel 1970 e che, fra le altre cose, prevedeva la
realizzazione di 35000 posti di lavoro in Calabria e in Sicilia,
l’apertura del V centro siderurgico, la SIR (Sud Italia Resina)
e un’industria chimica del gruppo Rovelli. Oltre a denunciare
l’esistenza solo su carta del progetto, viene messo in
evidenzia come nella forza lavoro prevista per l’impiego non
compaia neanche l’eventualità di assumere donne. Il 25
marzo del 1974 le donne del circolo UDI di Lamezia organizzano un
viaggio a Praia a Mare per far visitare a 50 donne l’industria
tessile “Marlane”, uno dei pochi casi nella regione di
impianto industriale a occupazione femminile. Così racconta
Vanna De Pietro la prima fondatrice del circolo, architetto, che da
Roma si traferisce a Lamezia nel 1970: «L’esperienza è
stata straordinaria: per queste donne si apriva un mondo nuovo e
diverso in quanto la maggior parte di loro era casalinga e quindi
estranea ad altre problematiche. L’unico lavoro che conoscevano
era quello di bracciante o di raccoglitrici di olive remunerato il
più delle volte con qualche bottiglia di olio»48
. Nei mesi che precedono il 12 maggio del 1974, anche l’UDI di
Lamezia partecipa alla campagna referendaria, sempre Vanna De Pietro
ricorda: «Eravamo consapevoli di quanto fosse chiaro il
tentativo di contrapporre il Nord al Sud, di mettere la disperazione
delle masse popolari del Sud contro la classe operaia del Nord,
tentando di svuotare di significato e di gravità una
situazione economica e politica che era la più grave del
dopoguerra[..] Di fronte a una situazione in cui venivano travisati i
fatti, in cui si speculava sui sentimenti, si seminava spavento e
timore sostenendo che quella legge era un’arma nelle mani dei
mariti emigrati che avrebbero potuto servirsene per abbandonare le
mogli, l’UDI non poteva non sentirsi direttamente colpita e la
sua mobilitazione è stata tutta rivolta a far capire che ben
altri erano i motivi della discriminazione delle donne e del loro
ruolo subalterno nella società: la disoccupazione, il
sottosviluppo del Mezzogiorno, la mancanza di attrezzature e di
servizi sociali». Si va in giro per i quartieri, per le
frazioni e le contrade con l’automobile attrezzata di
altoparlanti per parlare alla gente e non sempre le reazioni sono
pacifiche: «Ad un certo punto nei pressi di una scuola gestita
da suore, si viene letteralmente bombardate da uova, pomodori marci e
verdure d’ogni genere oltre che di improperi abbastanza
pesanti»49
Il 13 novembre del 1974 l’UDI di Lamezia partecipa alla
manifestazione nazionale per la riforma del diritto di famiglia. Si
parte di notte in treno :«Un intero vagone è pieno di
donne lametine di tutte le età e i ceti sociali. Molte di
loro, le meno giovani, si allontanavano per la prima volta lasciando
mariti e figli, per la prima volta vanno a Roma, per la prima volta
partecipano ad una manifestazione nazionale. Ricordo che i mariti le
affidavano a me. Non si era mai vista una manifestazione di donne
così imponente. Le vie della città erano piene di
donne. L’esperienza è stata indimenticabile»50

IL
CIRCOLO GIUDITTA LEVATO PER LE STRADE DI ROMA
In
preparazione al convegno del 22 aprile a Roma sui consultori di
maternità l’UDI diffonde un questionario tra le donne
dei quartieri popolari, che viene compilato dopo incontri e
discussioni sul significato di maternità come scelta libera e
consapevole e sull’aborto. Questi i risultati dell’indagine
su un campione di 227 donne. Alla domanda “hai voluto tutti i
figli che hai?” il 30% rispondeva di no; alla successiva
“desideri avere altri figli?” il 20% rispondeva
positivamente. Il 75% conosceva gli anticoncezionali, ma il 33% li
riteneva nocivi alla salute. Per ciò che riguardava l’aborto,
il 30% ammetteva di aver abortito, il 4% si rifiutava di rispondere.
Solo il 30% delle donne che avevano praticato l’aborto si erano
rivolte a un medico. Tra quelle che avevano abortito il 2,5% lo aveva
fatto più di una volta con casi estremi di dieci e più
aborti ancora. Favorevole all’educazione sessuale nelle scuole
e all’aborto negli ospedali è l’80% delle donne
interpellate.
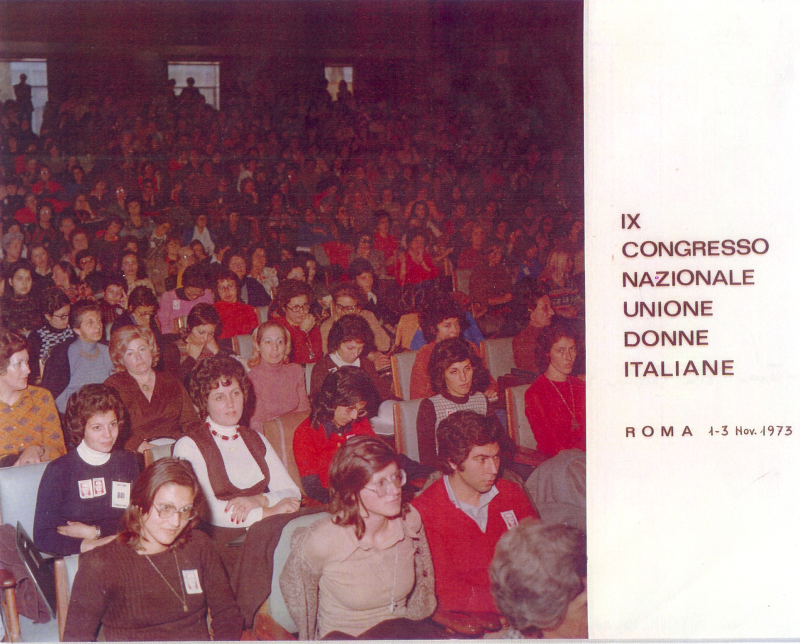
DA
SINISTRA: ELSA GALLINA,VANNA DE PIETRO, VERA LA MONICA, MARIA SPADA,
LUCIA MERCURI
2.4
IL Collettivo femminista di Catanzaro
(Questo
paragrafo e' stato rivisto da Donatella Brazzetti)
Nel
momento in cui si passa dalla ricostruzione dei percorsi di un gruppo
formalizzato e istituzionale come quello dell'UDI, a quella del
movimento femminista emergono tutte le difficolta' messe in luce da
quante e quanti in questi anni hanno variamente tentato di
ripercorrere le vicende. A Catanzaro, come altrove, e' difficile
trovare fonti documentarie, e' difficile riattraversare gli eventi
anche utilizzando lo strumeno della “storia orale”. Una
difficolta' che in generale molte pensatrici (Anna Rossi- Doria,
2005) hanno ricondotto in parte alla specificita' di un movimento che
si sedimenta intorno al problema della soggettivita' femminile, della
sessualita', e percorre strade come quella dell'autocoscienza, e del
non
dicibile. A
differenza della militanza “tradizionale” (anche quella
movimentista ed extra-parlamentare di quegli anni) – che si
sostanzia in atti pubblici,(manifestazioni, occupazioni, volantini,
documenti, assemblee, verbali, e quant'altro) – definirsi sul
piano della soggettivita' (collettivamente e individualmente) lascia
poche tracce documentarie, scava contraddizioni difficili a dirsi e
ad essere rielaborate, produce trasformazioni radicali non
traducibili nell'immediatzza di un evento comunicabile e
documentabile. In questo senso non e' facile restituire la portata di
una esperienza che ha comunque segnato un'epoca e costretto
direttamente o indirettamente forze politiche, gruppi
extraparlamentari, e senso comune a misurarsi con l'emergere di un
nuovo soggetto politico, non riconducibile ai canoni dell'agire
politico “tradizionale”.
Il
collettivo femminista nasce a Catanzaro i primi mesi del 1974
sull'onda dilagante dell'esperienza delle donne di altre zone
d'Italia e del mondo occidentale. Il tramite attraverso cui le
esperienze in corso arrivano a Catanzaro e' costituito, come in
moltissimi altri casi, dalle aderenti ai gruppi extraparlamentari e
in particolare dalle (giovani) donne di Lotta Continua. Come e' noto,
la componente delle donne politicizzate e legate all'esperienza dei
gruppi extraparlamentari e' particolarmente significativa nel
processo di costruzione del movimento femminista in Italia. Il
Collettivo raccoglie pero' provenienze molteplici non riducibili alla
sola appartenenza politica. Giovanissime studentesse e donne che
lavorano, donne fortemente politicizzate e appartenenti a formazioni
politiche differenziate (Avanguardia Operaia, Lotta Continua, Partito
Comunista), giovani che non hanno mai fatto politica in precedenza,
donne della buona borghesia, donne di estrazione proletaria e
sottoproletaria: il collettivo arriva ad avere oltre quaranta
aerenti. Le attivita' del Collettivo si muovono su piani differenti e
compositi, nel tentativo di trovare una propria identita'. In
particolare coesistono al suo interno, si intrecciano e spesso
configgono tra loro le spinte ad approfondire l'esperienza dei
piccoli gruppi di autocoscienza e l'intervento nel sociale, il
bisogno di andare a fondo sul senso della propria soggettivita' e la
mobilitazione su temi che riguardano la collocazione sociale delle
donne, il tempo per se' e il tempo per le altre. Il primo passo che
il Collettivo compie e' comunque quello di definirsi com “gruppo
di donne” , assumendo il separatismo come condizione fondante
della propria esistenza , una selta che crea forti frizioni e
incomprenzioni con i “compagni maschi”, ma anche con i
gruppi istituzionli di donne, come l'UDI, che in quegli anni e'
ancora fortemente influenzata dalla propria vicinanza ai partiti
della sinistra istituzionale. Le relazioni tra movimento e UDI sono
in questa fase ancora difficili. Il Collettivo inizialmente non ha
una vera e propria sede. Spesso si riunisce nei locali di Lotta
Continua in via Casa arse, spesso in case private. Solo piu' tardi
dara' avvio all'esperienza del Consultorio autogestito, un tentativo
di proporre anche a Catanzaro le eperienze dei gruppi di Self
Help, finalizzati
alla possibilita' che le donne imparino a conoscere a fondo il
proprio corpo, le proprie capacita' riproduttive, sottraendosi cosi'
al potere esercitato sui loro corpi dai medici e piu' in generale
dagli uomini. Il Consultorio e' pero' il portato di un percorso che
inizialmente si struttura soprattutto sull'esperienza
dell'autocoscienza, che nasce dall'urgenza di trovare risposte allo
scoprirsi oggetti
del
potere maschile ed appartenenti ad una comune condizione di
tacitamente e di oppressione. E' una scoperta al contempo esaltante e
drammatica: esaltante nel verificare, attravero il confronto con le
altre, che i problemi, le difficolta' nei rapporti sessuali, le
incertezze del vivere e del definirsi sono comuni a tutte: sono il
portato di una appartenenza sessuale; drammatiche perche' scoprirsi
come “secondo sesso” richiede di scavare dentro se stesse
per trovare nuove risposte e nuove dimensioni di identita', significa
misurarsi con i propri rapporti di coppia, significa trasferire
dentro il proprio vissuto lo scontro che molte avevano praticato nel
sociale contro un nemico esterno e spesso in nome di gruppi
“oppressi” estranei al proprio vivere. I piccoli gruppi
di autocoscienza rivelano questa drammaticita'. “Il gruppo di
autocoscienza – racconta Lorenza Rozzi – mi fece soffrire
come un cane rognoso. Misi in discussione il rapporto con mia madte,
con mia sorella (….) la sessualita' era un problema che non mi
toccava, la avevo sempre vissuta con serenita'. Ricordo un 8 marzo
davanti alla Prefettura, quando il giorno dopo in ospedale mi
chiesero se era vero che non portavo le mutande. Poi c'e' stato il
doloroso rientro nel nostro privato. I piccoli gruppi di
autocoscienza, dopo un percorso temporale abbastanza breve, si
scontrano, a Catanzaro come in moltplii altri posti, con la mancanza
di strumenti per approfondire i significati dei singoli percorsi
biografici, non hanno strumenti per governare un processo di
attraversamento del mondo interiore e della sessualita', producono
sofferenze e conflitti. In altre parti d'Italia, come a Roma e a
Milano, queste difficolta', a volte drammatiche, troeranno una
risposta nelle pratiche dell'incoscio, nell'intrapresa di un
confronto sul terreno della psicoanalisi. A Catanzaro l'esperienza
verra' invece sospesa, di fronte al carico di sofferenze, di
difficolta', di conflitto che mette in moto. Nel sociale, il
Collettivo avvia l'esperienza del Consultorio autogestito, ed e'
fortemente mobilitato sui temi dell'aborto, e della tutela della
salute riproduttiva delle donne. Questo interesse e' favorito dalla
forte presenza di aderenti al Collettivo dentro l'Ospedale e dal
momento di particolare consapevolezza e mobilitazione che si vive
dentro questa struttura. Alcuni medici davvero straordinari,
coadiuvati da paramedici altrettanto responsabili e disponibili
portano avanti in quegli anni un lavoro di rinnovamento profondo
della struttura. Il Consultorio si materializza in una microscopica
sede di due stanzette in via Case Arse, di fronte alla sede di Lotta
Continua. Ottiene in dotazione un lettino ginecologico e il supporto
di un ginecologo dell'ospedale. Ciascuna delle componenti del
collettivo posiede un suo speculum per l'autovisita. Il Consultorio
in verita' non funziona come struttura esterna, ma costituisce un
momento importante di scoperta del proprio corpo, di confronto, di
apprendimento dei delicati meccanismi che ben poche conoscono al di
la' delle mestruazioni. E' un percorso di scoperta di una diversa
intimita' che
ciascuna puo' costruire con il proprio corpo, con i suoi “luoghi”
piu' nascosti e da sempre tacitati. Annamaria Casalinuovo conserva
ancora gli speculum per l'autovisita. “Quando ho visto per la
prima volta il collo dell'utero ho pensato ad una piccola albicocca.
Ho pensato: ecco perche' il rosa e' il colore delle donne”. Ad
agosto del 1974 un evento gravissimo mette in moto la mobilitazione
sui temi del parto e della salute delle donne e contribuisce a
tessere la rete di donne intorno a cui si sedimentera' negli anni il
Collettivo.
Una
ragazza di diciannove anni, Antonina Pollizzi muore di parto
nell’ospedale di Catanzaro, a fine agosto. Le donne del
Collettivo con un volantino denunciano la situazione intollerabile in
cui versa il reparto di maternita'. La morte di Antonina e' il
segnale piu' drammatico di una condizione comunque inaccettabile.
Inizialmente
si crea uno stato di tensione con le infermiere del reparto, che
sentono pesare su di loro l’accusa della morte di Antonina.
Nascono così, da questo scontro iniziale, una serie di
riunioni, convocate all’interno dell’ospedale, tra il
collettivo femminista, le infermiere e le donne ricoverate.
L’incontro fa emergere anche la difficoltà per le
dipendenti di vedere in ogni paziente non solo un carico di lavoro
superiore alle loro possibilità: «Non c’è
dubbio che c’è una opposizione tra la donna ricoverata
che ha bisogno di tutto e le ostetriche e le infermiere affogate nel
lavoro che vedono in ogni ricoverata un carico di lavoro in più.
Ma c’è anche un’altra ragione, E’ una
contraddizione non facile da superare perché nasce non solo
dalle condizioni materiali di sfruttamento nell’ospedale, ma
anche da un patrimonio ideologico pesantissimo che richiede per
essere superato una lunga battaglia ideologica e una trasformazione
sociale profonda.»52
Esistono
infatti forti condizionamenti culturali, valori segnati da una
realta' dove ancora c’è il dominio della famiglia
contadina patriarcale, dove la sessualità si identifica
profondamente con la colpa e dove anche il parto e le malattie legate
all’apparato genitale vengono vissute come viziate da questo
“peccato originale”: «Se nei medici queste
convinzioni corrispondono al più profondo razzismo e
all’ignoranza verso i problemi e le malattie delle donne, nelle
infermiere diventa a volte rifiuto dell’altra donna,
insofferenza, chiusura ai loro bisogni, rifiuto di identificarsi in
una situazione comune» 53.
Un
articolo su “Lotta Continua” afferma «Già
non è facile accettare come naturale la morte per parto, ma è
ancor meno facile accettarla quando si partorisce all’ospedale
di Catanzaro, dove alla generale mancanza di organico, infermieri,
ostetriche, ausiliarie ecc. (e dei medici i quali dedicano
all’ospedale pochissimo tempo), si unisce un totale disprezzo
per le donne ricoverate e per il loro corpo. Così un
ginecologo in una lezione alle allieve infermiere è arrivato a
giustificare l’asportazione ad una donna, oltre che dell’utero
malato, delle ovaie perfettamente sane, con queste parole: “Che
cosa se ne faceva visto che senza utero non poteva più fare
figli?”. Un altro della stessa risma, a proposito dei tagli
cesarei, è arrivato a vantarsi che loro “per la
sicurezza delle donne preferiscono squartarle” e che solo nelle
cliniche fanno i taglietti invisibili.»54
Improvvisamente
si scopre dunque che il reparto ostetrico “faceva schifo”,
ma, nonostante ciò, nessuno risponde ai problemi delle donne
ospedalizzate e alle domande che esse si pongono: come è che
una donna può morire di collasso, dopo che da ben tredici
giorni era ricoverata nel reparto? Perché nemmeno il bambino
si è salvato? In che condizioni di sfruttamento si lavora?
Molte
cose comunque si muovono. Ostetriche e infermiere cominciano a
discutere collettivamente del proprio ruolo e delle condizioni di
sfruttamento in cui si lavora nell’ospedale. Licia e' una
levatrice che lavora in ospedale, appartine al Collettivo, e
organizza i corsi di parto indolore. La sua testimonianza ci
fornisce un quadro della situazione sociale e culturale dell’epoca.
Ricorda le parole di un’ostetrica in sala parto: «Apri le
gambe, così come fai quando stai con tuo marito?». E di
alcuni medici: «Quando in ospedale arrivavano donne che si
erano procurate l’aborto, alcuni medici si arrogavano il
diritto di infliggere loro la punizione non facendo l’anestesia.
Il pretesto era solitamente quello di chiedere se avevano lo stomaco
pieno e se loro rispondevano di sì, si sentivano legittimati a
procedere con il loro intervento barbaro. Noi a un certo punto
abbiamo cominciato ad avvertire le pazienti e le aiutavamo a
procurarsi il vomito» 55
«Poi lì è successo che una serie di episodi...una
ragazza era morta di parto per esempio, un'altra ragazza era morta
perché aveva tentato l'aborto, aveva abortito ficcandosi degli
stecchetti di rosmarino...non so di che cosa...dentro nell'utero, ed
era morta di setticemia, una cosa terrificante, una cancrena
gassosa...per cui l'impegno era anche fortissimo nel senso di fare
lavoro...stavamo alle porte dell'ospedale come prima io stavo alle
porte della fabbrica, dando volantini, dicendo che ci voleva questa
legge, non era proprio possibile.»56
Dentro l’ospedale lavoravano anche Lorenza Rozzi e Isolina
Mantelli. Isa e' medico e proviene da un ambiente borghese e non ha
problemi di parola, e quando viene assunta in ospedale ricorda che
«non riverivo e non avevo paura di nessuno». Fa politica
fin dal liceo. L’elemento di congiunzione è per lei la
scoperta del conflitto con la madre: «Io ero figlia di padre,
per capire mia madre ho dovuto attaccare mia figlia al petto»57.
E’ convinta che la verità non può stare
nell’ideologia. L’attacco all’ideologia è
stato per lei sia il livello della dissacrazione che quello della
liberazione: «Questo è dimostrato dallo scontro con
“lotta continua” a cui molte di noi sono state legate ma
con cui non hanno avuto problemi a rompere quando sono finiti i punti
i convergenza. La mia appartenenza è “guarda sempre il
volto dell’altro ma senza mai proiettarci il tuo”».58
Lorenza, responsabile della scuola di formazione per gli infermieri
specializzati, viene da Reggio Emilia e dall’esperienza
politica del PCI. Ha sempre vissuto in un ambiente operaio altamente
politicizzato, i suoi zii hanno direttamente partecipato alla
resistenza partigiana. Vive la militanza come un dovere ed appena
arrivata a Catanzaro desta stupore nell’ambiente del partito il
suo gesto di destinare alla tessera una somma più alta di
quella che abitualmente veniva data. Viene cooptata nel comitato
federale. Arriva a Catanzaro dopo essersi diplomata a Roma alla
scuola infermieristica e specializzata nel ‘68 a Parigi
nell’assistenza ai malati di neurochirurgia ed aver lavorato
nella tendopoli del Belice. Dopo quest’ultima esperienza
Susanna Agnelli le propone di organizzare la scuola infermieristica
in Calabria. Catanzaro le era stata descritta come la città
tra i due mari, ma la delusione per questo piccolo errore di
collocazione geografica, viene compensata dalla piacevole sorpresa di
trovarsi a contatto con un mondo medico che definisce altamente
qualificato ed aperto a fornire alle infermiere le possibilità
di poter esprimere la loro professionalità. A quei tempi
Lorenza comprava l’Unità ed il solo fatto di esporlo in
guardiola veniva considerato come un gesto rivoluzionario. «I
rapporti con i miei superiori hanno avuto anche dei momenti molto
critici come quando cercarono di impedirmi di partecipare ad un
concorso interno. Chi però mi ostacolava, non ebbe il coraggio
di affrontarmi faccia a faccia, ma chiese l’aiuto ad un altro
medico».59
Lorenza ricorda che molti malati tornavano dopo essere stati dimessi
solo per mangiare la “fettina” e che un’ infermiera
rimase incinta e venne cacciata. Quando Lorenza incontra il
femminismo lo fa tramite l’UDI ma se ne allontana presto poiché
non condivide il protagonismo della dirigente: « Il femminismo
è importante per me poiché mi ha dato la parola, la
consapevolezza del mio essere donna e dell’invidia, la bellezza
del rapporto con le altre donne. Le componenti del collettivo legate
ai gruppi extraparlamentari e in particolare a Lotta Continua,
oltre allo scontro sul piano sociale e su quello intimo e personale
attraversano un conflitto difficile e contraddittorio con
l'organizzazione e in particolare con la sua componente maschile. Un
primo elemento di conflitto e' comune a tutti i contesti
politicizzati: e' un conflitto tra lealta' al gruppo e al femminismo,
tra priorita' delle contraddizioni da affrontare , tra i tempi della
politica e quelli della riflessione e della presa di coscienza, tra
fare e pensare. E' un conflitto profondo sul significato stesso di
“politica” , su che cosa significhi trasformazione, sui
soggetti che la producono. E' un conflitto che mette in luce le
disparita' di potere che oppongono maschile e femminile dentro
l'orgnizzazione. L'assemblea nazionale di Lotta Continua del 1976
fara' esplodere queste contraddizioni che mineranno il senso stesso
dell'organizzazione e in questo scontro le donne di Catanzaro danno
un contributo importante, a partire dalle loro esperienze nella
mobilitazione all'ospedale. Nel
Collettivo sono presenti anche giovani donne sposate. Rosanna
Marafioti inizia l’attività politica all’università
di Pisa in pieno ’68. Aderisce a Lotta Continua. Nel ’72,
dopo l’università, torna a Catanzaro ed è l’unica
del gruppo sposata con una casa e un figlio. «La mia casa era
un porto di mare ma non è mai mancato nulla... . Nel ’79
andai via dall’Italia e mi trasferii in Olanda a Delft. E’
lì che ho iniziato a frequentare la Casa Delle Donne. Quando
sono tornata a Catanzaro, nell’85 era gia tutto finito»63.
Anna Maria Casalinuovo entra nel collettivo ha 30 anni e sente di
vivere una grande utopia. Viene da una famiglia proletaria di quasi
tutte donne. A 14 anni va a lavorare a Bergamo ed è lì
che si forma la sua coscienza di classe. Il ritorno a Catanzaro è
per lei particolarmente difficile: «Mentre a Bergamo non mi
sentivo povera il rientro a Catanzaro è drammatico: finisco
casalinga, sposata e in una situazione economica non delle più
felici, non mi sentivo di appartenere più a niente»61,
ma le altre ricordano come la sua casa fosse da subito diventata
punto di riferimento per le donne del quartiere emarginato in cui
viveva. Sono
decine comunque le donne attive al suo interno, da Graziosa, ad
Aldina, a Flora, a Carol, a Paola, a Olimpia....
La
presenza di un gruppo femminista costituisce un sovvertimento
profondo in una citta' apparentemente impermeabile al cambiamento.
Quando nel 1978 alcune decidono di andare a vivere “da sole”
in un grande appatramento comune a Pontegrande, gli inquilini del
palazzo raccolgono firme per allontanarle, le imputano per disturbo
alla quiete, di amminae in casa di notte, di attentare all'integrita'
dei loro figli (!). Eppure queste donne sono serissime professioniste
e insegnanti ormai ultratrentenni. Contravvengono pero' alla regola
non trasgredibile che una donna esce dalla famiglia di origine solo
per sposarsi (o al piu' per andare a studiare in un altro luogo).
Al
Collettivo fanno riferimento anche molte giovanissime studentesse e
una delicatissima giovane donna del gruppo dei cosiddetti
“Giardinetti”, un luogo che nelle rappresentazioni del
perbenismo catanzarese significa droga ed emarginazione.
Di
fatto la droga fa la sua comparsa a Catanzaro. Attraversa
l'esperienza di alcune giovanissime donne che nel processo di
trasformazione che travolge la societa' della seconda meta' degli
anni '70, non trovano gli strumenti per una ricomposizione.
Nessun
riferimento polotico e' in grado di offrire una prospettiva
credibile. Queste giovani vite, alcune spezzate per sempre, sono il
sintomo di un cambiamento che segna la fine di una esperienza, quella
della mobilitazione di massa delle donne e dell'illusione che il
cambiamento del mondo fosse a portata di mano. La forza straordinaria
del movimento, le grandi manifestazioni per l'aborto che richiamano
tutte a Roma o comunque in piazza, con la fine degli anni '70 e dopo
l'approvazione della legge sull'aborto, sembra dissolversi. Come
sottolinea Lorenza “c'e' stato il doloroso rientro nel nostro
privato”. L'assassinio di Moro nel '78 e, di li a poco, nel
1981 la grande sconfitta degli operai della FIAT sanciscono il
passaggio ad una diversa fase politica.
Se
il movimento si disperde restano pero' le donne che hanno attaversato
quella esperienza profondissima e indimenticabile. Non a caso
ciascuna ha continuato in mille diverse forme il proprio impegno,
lasciando una traccia nella storia della citta'.
2.5
Collettivo Femminista di Lamezia Terme
Il
collettivo femminista di Lamezia Terme nasce nel 1975 da una costola
di Avanguardia Operaia. Successivamente ne nascerà un altro
denominato Collettivo Donna. Le donne dei collettivi lametini sono in
stretto rapporto con la sinistra partitica infatti aderiranno anche
alla Carta delle donne del PCI. Del lavoro di questo collettivo
abbiamo testimonianza attraverso i documenti di seguito integralmente
riportati, tutti concentrati sul problema dell’aborto. La loro
lettura chiarisce come, fino agli ’90, in un territorio come
quello di Lamezia Terme, questo diritto non fosse ancora pienamente
garantito.
IL
CONSULTORIO IMPOSSIBILE
Ma
non doveva essere già funzionante questo consultorio o donne,
bambini
Coppie,
singoli, cittadino, utente?
O
è ancora quell’oscuro oggetto del desiderio?
Nel
dicembre ‘78 il sindaco rappresentante della giunta DC-PSI
appoggiata dal PCI sentenziò che per il consultorio tutto era
pronto, “la cattiva” era la regione che non si decideva a
dare i soldi! E’ passato, un’anno i soldi sono stati
dati, il consultorio non solo non è stato ancora istituito ma
non ha più nemmeno i locali, ceduti all’ufficio
sanitario. Dove sarà, ubicato il consultorio? Sulla luna? Ci
piacerebbe saperlo! Ma questa della sottrazione dei locali non e la
sola cosa che ci stupisce. Il sindaco ha riproposto un regolamento
che per essere un pò originale rispetto alla legge regionale
introduce in qualche modo nel consultorio la figura del prete. Non
abbiamo niente contro i preti, con alcuni di essi si lotta anche
insieme, ma siamo convinti che l’assistenza deve essere laica e
che nessun ricatto morale è giusto nei confronti delle donne.
Per
noi questa è la manovra di chi vuol mantenere sotto il
controllo della morale cattolica, di quella più deteriore,
temi quali la sessualità, gli anticoncezionali, l’aborto
ecc.; inoltre ci sembra un po’ troppo, che secondo il
regolamento così come è stato proposto, il consultorio
sia affidato a ben 3 medici, un’assistente sociale, un
assistente sanitaria, un ostetrica e uno psicologo.
Vogliamo
fare un poliambulatorio per poi non fare niente?
Noi
diciamo che il consultorio può funzionare con le figure base
previste dalla legge quadro: psicologo, assistente sociale,
ginecologo da poter consultare (naturalmente non obiettore di
coscienza) affinché le donne
non
si ritrovino davanti un giudice o semplicemente uno che se ne frega
dei loro problemi, che saranno anche quelli relativi all’aborto,
piaccia
o non piaccia a chi vuole anche dopo la legge tacere questo problema.
Nel consultorio le donne, gli utenti, devono avere un ruolo centrale
di massima partecipazione.
Questo
regolamento non lo garantisce!
Noi
diciamo che nel comitato di gestione devono entrare ulteriori
rappresentanze di donne e di utenti scelti dal basso e non delegati
dai partiti.
Chiediamo
anche che l’attuale amministrazione ci chiarisca come vuole
assumere il personale del consultorio perché non ci fidiamo
affatto dei suoi metodi. Infine, un consultorio per tutto il
comprensorio di Lamezia non è tropo poco?
Lo
sapevate che i soldi ci sono anche , per il secondo consultorio?
In
una riunione dei giorni scorsi su questi temi, da cui Democrazia
Proletaria è stata esclusa il PCI insieme al PDUP PSI ed ACLI
si è impegnate a migliorare il regolamento. Queste forze
hanno posizioni differenziate.
Il
PSI che fa parte della giunta, è molto ricattabile, il PCI è
oggi all’opposizione.
Ma
compagni del PCI, vi batterete per avere un consultorio pubblico e
per le
cose
dette anche in questo scritto che almeno in parte avete detto di
condividere? Oppure la vostra e solo una opposizione strumentale in
vista delle elezioni?
Non
è questione di sfiducia, è che riteniamo, come D.P.,
che tutti questi interrogativi debbano uscire dal chiuso delle
riunioni dei partiti per essere discussi dalla gente e perché,
e questo l’unico modo per battere la violenza del potere, della
DC in particolare, ma anche per aprire occhi ed intelligenza
“compagni e compagne di tutta la sinistra” su una realtà
che non è più quella di una volta. Altrimenti ad essere
impossibile non sarà solo il consultorio.
Ciclinprop.
DEMOCRAZIA PROLETARIA Via Garibaldi,75 Lamezia Terme 1979
OLTRE
LA DENUNCIA: PERCHE’ LE DONNE NON SIANO PIU’ SOLE
DI
FRONTE AL PROBLEMA DELL’ABORTO
Lunedì 19 Febbraio sarà
celebrato il processo contro i tre ginecologi della USSL 17 accusati
di violazione della legge 194 e di altri gravissimi reati.
Già
nel novembre scorso, dopo la notizia del rinvio a giudizio dei tre
medici, ci costituimmo in “Comitato per la difesa e la corretta
applicazione della 194” e, cosi organizzati, incontrammo il
presidente della USSL Paolo Caglioti e il responsabile del reparto di
ostetricia e ginecologia Dr. Barese, per denunciare la gravità
della situazione e indicare proposte concrete, atte a rimuovere le
cause che avevano reso illegalmente applicata prima, e tuttora
inapplicabile la legge per l’interruzione di gravidanza.
Adesso
nell’imminenza del processo, vogliamo innanzitutto riconoscere
alla magistratura il merito di avere avviato e concluso celermente
l’istruttoria, permettendo la realizzazione del dibattimento
pubblico in
tempi
brevi. È un segno positivo, insieme di coscienza civile e
giuridica e di riconoscimento del significato della denuncia che
conduciamo da anni con l’obiettivo di rendere concreto il
diritto di tutti alla cura e alla salute.
Vogliamo,
poi, rivolgerci alle donne che sono parte offesa e che costituiscono
la testimonianza vera del disagio con cui si è costretti ad
affrontare, nella nostra USSL, un problema difficile e
contraddittorio come quello dell’aborto. Ad esse offriamo la
nostra concreta solidarietà, la nostra disponibilità al
confronto, tutte le nostre risorse a fornire assistenza giudiziaria.
Ci
rivolgiamo, infine, alla USSL 17 e all’Assessorato alla Sanità
della Regione Calabria. Denunciamo con forza la mancata costituzione
di parte civile in un dibattimento che vede assenti proprio gli
istituti responsabili della cura e della salute dei cittadini.
Il
comitato ritiene comunque di sostenere le forze politiche e le
associazioni che decidessero di costituirsi parte civile e chiede
principalmente alle donne, e a tutti i cittadini di partecipare
attivamente alle iniziative di questi giorni.
COMITATO
PER LA DIFESA DELLA
194
Centro
donna Lilith, Tribunale dei diritti del malato, Comunità
Progetto Sud, Democrazia Proletaria, Partito Comunista Italiano.
Lamezia
Terme 15 febbraio 1990
SOLIDARIETA
ALLE DONNE
La USSL deve applicare la
Legge 194
Il
2
aprile al Tribunale di Lamezia si terrà la seconda udienza del
processo ai tre ginecologi indiziati per aver percepito denaro in
seguito ad Interruzioni Volontarie di Gravidanza presso l'Ospedale
della nostra USSL.
E’
senza ombra di dubbio una vittoria delle donne e delle organizzazioni
politiche che in questi anni si sono battute perché la Legge
194 venisse applicata integralmente mediante una programmazione
efficiente che garantisse la riservatezza, la funzionalità e
la assoluta gratuità del servizio.
A
questo processo seguirà un altro che vede direttamente la USSL
responsabile di non garantire il servizio di I.V.G. Ha dunque buona
ragione il P.M. Calderazzo quando afferma che «ci vorrebbe un
magistrato a tempo pieno che si occupi di tutte le pratiche della
gestione della USSL».
MA
ALLE DONNE E A NOI IL PROCESSO NON BASTA!
La
nostra preoccupazione e la nostra mobilitazione hanno lo scopo di
salvaguardare la dignità della donna, affinché una
legge dello Stato sia applicata anche nella nostra USSL.
QUESTO
DI FATTO NON AVVIENE!
Sono
ormai trascorsi 6 mesi senza che alcun provvedimento risolutorio sia
stato preso dal Comitato di Gestione della USSL per risolvere
l'interruzione del servizio di I.V.G. Inutili a questo punto sono
stati i ripetuti incontri avuti col Presidente della USSL, eppure
avevamo
proposto diverse soluzioni:
a) funzionalità
del servizio presso l'Ospedale di Lamezia, per due giorni a
settimana, mediante l'utilizzo dei sanitari non obiettori
dell'Ospedale di Soveria Mannelli;
b)risoluzione
della difficoltà a reperire gli anestesisti mediante garanzie
certe per gli stessi, circa la non estemporaneità del servizio
di I.V.G., la programmazione e la necessaria serenità
professionale a svolgere un servizio così delicato;
c) rilancio
della credibilità operativa del Consultorio familiare pubblico
quale strumento fondamentale dell'iter che porta ad una maternità
consapevole, libera, gratuita ed assistita, mediante la messa a
disposizione di spazi interni all'Ospedale che garantiscano la
necessaria riservatezza e il sostegno socio-psicologico alle utenti,
ricomponendo soprattutto la legalità delle tappe che portano
una donna a scegliere consapevolmente di abortire;
d)chiarimenti
e soluzioni atte a superare l'eccessivo e in alcuni casi non
giustificato ricorso all'obiezione di coscienza anche da parte di
figure professionali sanitarie per le quali non è prevista e
motivabile tale possibilità.
A
QUESTE PROPOSTE NON E’ MAI SEGUITO, DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL
COMITATO DI GESTIONE DELLA USSL, ALCUN ATTO CONCRETO CHE MIRASSE ALLA
SOLUZIONE ANCHE DI UNO SOLO DEGLI IMPEGNI PRESI
E
a nulla serve dire che il servizio è comunque garantito a
Soveria o nella struttura privata convenzionata. Il nostro
Ospedale deve garantire un servizio previsto per una città di
70mila abitanti!
DENUNCIAMO
QUINDI L'IMMOBILISMO E L'ASSENZA DI VOLONTA’ AMMINISTRATIVA DI
QUESTO PRESIDENTE E DEL COMITATO DI GESTIONE E DELLA USSL n. 17 E
CHIAMIAMO ALLA MOBILITAZIONE ANCOR PIU’ DONNE di
quante finora si stanno coraggiosamente impegnando affinché,
oltre al ripristino della legalità e alla condanna di quanti
si fossero resi responsabili di odiosi ricatti sulla vita delle
donne, sia applicata in tutte le sue parti la Legge 194.
INVITIAMO
DONNE E UOMINI Di QUESTA CITTA’ A MANIFESTARE LA LORO
SOLIDARIETA E AD ESSERE PRESENTI IL 2 APRILE ALLE ORE 10 IN
TRIBUNALE,
PER
CONTRIBUIRE A CRESCERE NELLA COSCIENZA DEI DIRITTI DI TUTTI.
Lamezia
Terme, 31 marzo 90
Centro
Donna Lilith, Tribunale per i Diritti del Malato, Comunità
Progetto Sud, Democrazia Proletaria, Partito Comunista Italiano.
OLTRE
LA DENUNCIA: PERCHE’ LE DONNE NON SIANO PIU’ SOLE DI
FRONTE AL PROBLEMA DELL’ABORTO
Nel
maggio scorso Democrazia Proletaria ha denunciato un fatto molto
grave: l’eventualità molto concreta di “tangenti”
pagate per abortire in ospedale.
Oggi
quella denuncia politica è diventata inchiesta della
Magistratura. Trentanove donne, su quaranta sentite dai Carabinieri,
avrebbero ammesso di aver “pagato” per abortire nella
struttura pubblica quando una legge dello Stato, la 194, ne assicura
la completa gratuità.
Tre
comunicazioni (avvisi di garanzia) sono state inviate dalla
magistratura a tre ginecologi del reparto di ostetricia.
Al
di là dell’esito giudiziario della vicenda, ci sembra
importante sviluppare alcune riflessioni.
Riteniamo,
infatti, che la speculazione sugli aborti a Lamezia sia consentita di
fatto da una Gestione dei Servizi Sociali e Sanitari estremamente
degradata, inaffidabile e irrispettosa dei diritti più
elementari delle persone.
Parto,
aborto, malattia, tutto si tollera che venga monetizzato anche quando
si ha diritto alla gratuità delle prestazioni, anche se questo
è contro le leggi dello Stato.
Ci
chiediamo se un fatto del genere sarebbe potuto avvenire in presenza
di un primario di reparto, di una direzione sanitaria e di un
comitato di gestione seriamente e responsabilmente impegnati a far
rispettare la legge.
Tutti
fanno finta di non sapere e di non aver mai saputo niente. Da
garantisti d’accatto, Presidente e Comitato di Gestione ,
preferiscono attendere l’esito dell’inchiesta.
Magari,
poi, per dire che il problema è di coloro che la Giustizia
indicherà come responsabili.
Ed
è vero: se si accerteranno responsabilità, queste
saranno direttamente dei medici sotto inchiesta.
E’
anche triste per noi constatare che sarebbero proprio i non obiettori
quelli chiamati in causa. Sicuramente questo è sintomo di una
caduta di tensione ideale, del senso di solidarietà, del
rispetto del proprio lavoro.
D’altro
canto, anche i medici non obiettori dovrebbero davvero interrogarsi,
se obiettori seri sono:
sono
proprio sicuri di essersi adoperati perché non ci fossero
irregolarità nella applicazione della legge, perché
consultori e ambulatori funzionassero? Oppure, non hanno anch’essi
preferito tacere e tollerare per spirito di casta o per non avere
seccature, come a volte, per non avere problemi, hanno obbiettato?
Si, perché anche sulla obiezione ci sarebbe molto da dire: si
obietta o non si obietta per i motivi più svariati, non sempre
di natura etica. Oggi, ad esempio, sono diventati obiettori tutti gli
anestesisti dell’ospedale di Lamezia e, cosi , ufficialmente
non si può più abortire. Vi sembra serio, giusto,
etico?
Infine
, una cosa bisogna avere il coraggio di dire:
Le
donne e gli uomini, i partiti e i collettivi che ci battemmo e
lottammo per la 194, tutti abbiamo dimenticato in questi anni che non
bastava una legge, non bastava l’istituzione dei consultori per
garantire diritti ed evitare soprusi.
Abbiamo,
tutte e tutti, dimenticato che da sole con il proprio problema si è
troppo deboli, ricattabili.
Abbiamo
perso il potere di critica, di vigilanza collettiva, la solidarietà,
e così è potuto succedere di aver pagato per abortire
il prima possibile, senza rumore, senza il pericolo di essere
additate nel reparto di ostetricia.
Oggi,
allora, che l’autodeterminazione delle donne viene attaccata da
più parti, oggi che la tendenza alla privatizzazione dei
servizi consente l’illegalità e vi convive, oggi non è
più possibile rimuovere, dimenticare.
Tutti,
donne e uomini che per anni abbiamo contrastato l’aborto
clandestino, la speculazione di medici e ostetriche sul corpo delle
donne, riprendiamoci in mano la vita perché la subordinazione
e la mercificazione non si ripropongano definitivamente sotto
l’ipocrita tutela della struttura pubblica.
DEMOCRAZIA
PROLETARIA
sez.
A. Argada
26.10.1989
Lamezia Terme
MAI
PIU SOLE DI FRONTE ALL’ABORTO
Ancora
oggi, dal settembre ‘89 nell’Ospedale di Lamezia Terme
non è possibile sottoporsi ad interruzioni volontarie di
gravidanza.
Aumentano,
pertanto, le prestazioni per tale servizio pagate alla Villa
Michelino, con maggiori costi per la USSL n°
17
e quelle per l’Ospedale di Soveria Manelli con maggiore disagio
per gli operatori sanitari e per le donne.
Tutto
questo avviene nonostante gli impegni presi dal presidente del
Comitato di Gestione Dott. Caglioti e dal primario di Ostetricia
Dott. Barese per riattivare il servizio nell’Ospedale di
Lamezia Terme e per promuovere un più stretto legame tra
attività del Consultorio e Ospedale, cosi da avviare con gli
operatori di Ostetricia una discussione sulle modalità di
assistenza al parto anche questa, pare, spesso effettuata dietro
illecito pagamento.
Ma
evidentemente per gli amministratori della USSL n° 17 così
come per molti primari, è più facile promuovere
convegni e progetti “ad alto contenuto scientifico”,
piuttosto che affrontare e risolvere “gli oscuri e banali
problemi che le donne quotidianamente vivono in Ospedale”.
Pertanto Lunedì 25
Giugno si celebrerà, dopo il rinvio di aprile, il processo ai
tre ginecologi accusati di: concussione, falso ideologico e
violazione della 194.
L’indifferenza
di chi gestisce la USSL e il gioco al rinvio per quanto riguarda il
processo, non sminuiscono la nostra voglia di chiarezza, di
giustizia, il nostro impegno per il rispetto dei diritti delle donne.
Noi
non siamo stanche, saremo presenti in Tribunale Lunedì 25
Giugno e invitiamo tutte le donne alla partecipazione e alla
mobilitazione.COMITATO
PER LA DIFESA DELLA 194
Centro
donna Lilith, Tribunale dei diritti del malato, Comunità
Progetto Sud, Democrazia Proletaria, Partito Comunista Italiano
Giugno
1990
2.6
Fidapa di Lamezia Terme
La
Fidapa viene fondata a Lamezia da Angelica Biacca nel 1970.
Attualmente conta 130 socie e, all’impegno per la
valorizzazione e la promozione della donna, ha sempre aggiunto altri
interessi sociali, come narra la past pres. Ines Pugliese:
«L’emancipazione delle donne passa attraverso la cultura,
quindi da essa si sono diramate tutte le varie attività che
hanno creato interesse e dibattito nella città in cui abbiamo
operato. Sono state fatte mostre d’arte, presentati libri di
poesie delle nostre socie, cenacoli culturali con la recensione di
romanzi famosi, dibattiti politici, premi musicali. ...Abbiamo
partecipato, insieme alle altre associazioni femminili, alla nascita
dei Consultori Familiari denunciando le numerose carenze di
informazione e di assistenza sul problema della procreazione. Si è
partecipato all’Admo alla campagna per la lotta contro la
leucemia e per la donazione del midollo spinale. Siamo state vicine
ai Disabili collaborando anche con l’UNITALSI o con tutti
coloro che ci hanno chiesto collaborazione. ... E’ stato
denunziato il problema dell’acqua e fatta una ricerca sulla
qualità delle acque minerali, sono state individuate opere
d’arte in disfacimento e quindi restaurate... Il tema nazionale
“Donne, potere e politica” è stato svolto da tutte
le angolazioni dando rilievo all’arte, alla musica, alla
conoscenza dell’ambiente per la valorizzazione dei piccoli
centri e per la difesa delle nostre coste».
CAPITOLO 3
GLI
ANNI OTTANTA E NOVANTA.
Di
Maria Marino
Premessa
Gli
anni Ottanta e Novanta sono gli anni di quello che oggi viene
definito “femminismo diffuso”.
Il
movimento apparentemente si ritrae, ma non cessa la necessità
e l’esigenza di cercare luoghi e relazioni che portino il segno
di questa esperienza. All’interno dei gruppi di cui andremo a
parlare ritroveremo così anche quelle figure che negli anni
Settanta si erano rese protagoniste di un altro tipo di politica.
Alla visibilità esterna si preferisce la riflessione e simili.
Da qui il bisogno di leggere e approfondire tematiche nuove, spesso
fortemente radicali. Fra queste, quelle di “Sottosopra”,
di “Via Dogana”, saggi come “L’ordine
simbolico della madre” di Luisa Muraro o, ancora, testi di
Adriana Cavarero. Tutte donne queste che seguono con attenzione la
produzione culturale femminista degli anni Ottanta e talvolta la
fanno talmente loro da rischiare di cadere nella trappola di cui
parla Paola Melchiorri: «La
“madre simbolica“, una delle figure trascendenti, le
“donne divine“ che escono dalla conflittualità e
dalla lacerazione delle donne reali e rimuovono il reale contenuto
dei loro “affetti”, assumono la pura statura del padre. E
il femminismo si rivela in questa accezione un ultimo sogno virile».
E’
qui che viene rintracciato uno dei problemi storici del femminismo,
cioè la scoperta, dopo un primo momento di “inebriamento
ideale“, che le donne non sono immuni da ciò che ha
spinto l’uomo a strutturare in modo psichicamente così
violento il rapporto con l’altro sesso. L’assenza
dell’uomo non le salva da tale pericolo. Tutto ciò sta a
dimostrare come la nascita di un genere, la scoperta di sé
come appartenente ad un genere non è, per una donna, anche
nascita di sé come individuo, autonomo e capace nello stesso
tempo di relazione. Anche se la nascita di genere diventa
necessariamente premessa per l’altra nascita, il percorso tra
le due è lungo e doloroso.
La
storia del femminismo però, dice Paola Melchiorri, può
essere letta anche prima della formulazione ufficiale dell’
“ordine simbolico della madre”, in quel percorso
intellettuale e esistenziale di donne che hanno scoperto e vissuto le
forme della relazione tra donne, a partire da quella tra di loro.
Se
le donne del primo movimento hanno ricercato madri e padri, sono
state –osserva ancora Paola Melchiorri- le difficoltà
incontrate in questo percorso ad accelerare l’instaurarsi
dell’ordine materno come una soluzione capace di “fare in
fretta”, sottovalutando i costi personali di una ricerca che è
dolorosa perchè rischia di riprodurre gerarchie e poteri
immaginari: «Se
i rapporti tra donne, eliminando il corpo maschile, hanno il pregio
infinito di farci vedere a nudo la profondità dell‘impianto,
in ogni individuo, della polarità maschio- femmina e la
difficoltà di un andamento di individuazione che non usi, per
il processo di distacco, l’inimicizia degli opposti per dare
voce all’ elaborazione dell’ ambivalenza verso il simile,
essi non ci tutelano dalla loro ripetizione. Le differenze, di sapere
e potere, si trasformano nella polarizzazione potere/impotenza del
modello maschile/femminile e la somiglianza si gioca in un
attaccamento mortale, portatore di soggezione e schiavitù»
La
narrazione della vita di molte delle donne che incontreremo nel
paragrafo successivo radica spesso la consapevolezza di sé
nell’infanzia e nell’adolescenza, perché è
lì che si assorbe la prima lezione di vita dalla madre e dalle
donne della famiglia: «La
mia indignazione di bambina e di adolescente si focalizzava sulla
povertà, l’oppressione nel lavoro, l’ingiustizia
sociale. Le donne della mia famiglia e le suore mi mostravano come
compiere gesti quotidiani e personali per aiutare: sono stata
educata a non soccombere all’impotenza, ma ad agire “hinc
et nunc”.
Vivere nel gruppo ma restare fedele a me stessa.»
Kore,
Tempo di Marea
KORE
Kore
è un gruppo di riflessione che nasce a Soverato nel 1987 e si
costituisce nella forma di associazione nell’89. E' Assunta Di
Cunzolo, che proviene dall'esperienza ormai conclusa dell'UDI
soveratese, a volere la nascita di questo gruppo ed a scegliere le
donne che ne sarebbero entrate a far parte. Dopo le prime riunioni,
alcune andarono via e il gruppo fu stabilmente costituito da Delia
Fabrizi, Maria Grazia Riveruzzi, Fulvia Geracioti, Maria Procopio,
Teresa Ciaccio, Viviana Santoro, Marisa Rotiroti, Patrizia Greto e
Patrizia Fulciniti. Ne ha fatto parte, fino alla sua morte avvenuta
nel 1998, anche Giovanna Veneziano. Kore opera come un gruppo
separato e privilegia il lavoro e la relazione politica al proprio
interno. E' sempre stato un piccolo gruppo per scelta, ed è
conosciuto all'interno di un circuito di relazioni attraverso le
quali sono stati costruiti dei progetti politici: i seminari aperti
per confrontarsi con altre donne , il lavoro nelle scuole con le
insegnanti sulla pedagogia della differenza sessuale, il lavoro nel
Comitato di Gestione del Consultorio familiare di Soverato, la
realizzazione della Biblioteca delle donne insieme con la Fidapa, la
partecipazione alle riviste “Mediterranea” prima e “Tempo
di Marea” dopo. Il materiale documentale prodotto dal gruppo è
prevalentemente ad uso interno, ma si trova testimonianza degli
elaborati su “Tempo di Marea”, la rivista di riflessione
e pratica politica di cui si dirà nel paragrafo successivo.
Obiettivo principale delle donne di Kore è quello di costruire
pensiero, che aiuta a trasformare se stesse e la realtà che le
circonda, a partire dalla pratica delle relazioni politiche tra
donne. Per tutte, l'ingresso nel gruppo segna un “nuovo
inizio”: «A partire da questo, molte possibilità
si sono aperte per noi: di riflessione e rimessa in discussione del
rapporto figlie/madri/figlie; di cambiamento della relazione tra noi,
che è diventata più ricca, più profonda, anche
con un confronto più acceso sia sul piano politico che su
quello affettivo; di modificazione del nostro linguaggio come una
delle forme essenziali con le quali ci rappresentiamo il mondo; di
avvertire il senso di libertà con cui ci muoviamo nei nostri
luoghi di vita per l'autorizzazione alla libertà che nel
gruppo prendiamo»67
Per anni queste donne si incontrano una volta a settimana, leggono,
si confrontano, discutono spesso in maniera accesa. I riferimenti
politici che stimolano la costruzione di questo percorso sono
rappresentati dalle produzioni di pensiero da parte della Libreria
delle Donne di Milano , del Gruppo “Diotima”
dell'Università di Verona, del Centro “Virginia Woolf”
gruppo A e B di Roma. Alcune esponenti di queste realtà
vengono invitate a patecipare a seminari interni al gruppo. Il
confronto non sempre è facile e le discussioni sono molto
animate perchè all'interno del gruppo non c'è una
univocità di pensiero, con una elaborazione articolata che si
sviluppa attorno alla questione “Ordine simbolico della
madre/Ordine simbolico femminile” : «...Stiamo discutendo
di autorità, del gruppo e di chi esprime l'autorità al
suo interno, se è riferita ad una sola o a più donne;
delle nostre relazioni duali e di come si esprimono e si
differenziano; dei conflitti e del disagio che nascono se da una
relazione duale, che si avverte come privilegiata, ci si sente
escluse; dell'autorità di Kore che definiamo come Autorità
circolante. Stiamo discutendo anche se ci può aiutare
l'accettare un legame nuovo, non temporale, tra dipendenza ed
autonomia in cui l'una non escluda l'altra, come suggerisce Evelyn
Fox Keller ne “Il genere e la scienza”. Su queste cose,
come su tutto il resto , ci sentiamo in cammino»68
In particolare, uno dei momenti significativi di questa discussione è
rappresentato dalla riflessione, avvenuta nel corso del 1992/93, sul
testo di Luisa Muraro “L'ordine simbolico della madre”.
Il primo effetto è stato quello di riconoscere che “il
saper amare la madre” implicava necessariamente un incontro con
la madre reale. Ne sono venute fuori, in primo luogo, domande,
osservazioni anche dolorose, ribellione e sofferenze. La libertà
di una donna, il suo modo di stare al mondo, si domandano, può
dipendere esclusivamente dalla consapevolezza dell'amore per la
madre, o non è forse conquista giornaliera, continua, per
molti versi autonoma ed indipendente da questo sentimento? Le
risposte delle donne del gruppo sono diverse. C'è già
chi ha recuperato e fatto chiarezza nel suo patrimonio di memorie e
di simboli: «Di mia madre ho chiara una immagine, anche perchè
il fatto, ricorrente, avveniva davanti ai miei occhi da quando ero
piccola fino all'età di 33 anni: mia madre e le sette sue
sorelle sulla terrazza della loro casa materna che ascoltavano mia
nonna e godevano della sua compagnia. Ogni domenica mia madre si
consentiva il ritorno alla madre». Altre parlano in modo
diverso: «c'è un muro di granito che mi impedisce di
pensare ad una madre che, mettendomi al mondo, voleva, ha sempre
voluto, la mia indipendenza simbolica».
Pertanto,
nel dispiegarsi del pensare, da una parte si afferma che «nella
costruzione di un ordine simbolico il riferimento è alla
potenza materna che va di madre in figlia... Il discorso filosofico
di Luisa Muraro è un atto fondativo di ordine simbolico: atto
politico che si basa sulla nascita, sul corpo, sul desiderio,
sull'amore, sulla relazione, sull'armonia (tra corpo e mente, tra sé
e l'altro da sé). ... ed è nell'ordine simbolico della
madre che, sin dal principio, è contenuta la capacità
di accogliere le differenze, di comprendere l'altro da sé, di
creare un luogo mediato in cui le differenze possano esistere, che
permette l'esistenza e il divenire del mondo composto di due sessi:
quello femminile e quello maschile»69
Dall'altra,
«altre voci hanno espresso l'idea che nostra madre è il
mattone primo della costruzione del nostro essere al mondo, il
principio... Altri luoghi dove trovare buoni mattoni ci sono stati
indicati da una (più) donna. Infatti tutte noi facciamo
riferimento ad una madre simbolica o ad un simbolico materno che ci
ha aiutato a ri/nascere, senza con questo voler rinnegare la prima
nascita, alla maniera in cui lo hanno fatto filosofi e scienziati,
poiché la seconda nascita è sempre avvenuta ad opera di
una donna. Una donna, più donne, hanno mediato tra noi e il
mondo, mostrandoci nuove vie di libertà, insegnandoci un altro
linguaggio, inserendoci in una genealogia femminile.... La nostra
prima esperienza è di figlie, si dice ancora, il nostro primo
nucleo di identità avviene attraverso nostra madre, in seguito
intervengono le esplorazioni del maschile paterno. Questo per
ricordare che siamo figlie di madre e di padre e che i processi
biologici non possono essere ignorati; ... La sovranità di
ciascun genere richiede pieno riconoscimento culturale, simbolico e
politico. Ora, il dato fondamentale di ciascuna di noi è
l'essere donna. Il femminile armonizza potenzialità, potenza e
potere. Potenzialità di essere secondo il nostro progetto
radicato nel sesso biologico; potenza di un genere assunto e
operante; potere etico e politico»70
Attorno
a queste idee si sviluppano riflessioni appassionate, a volte anche
aspre. Contemporaneamente, si cerca di operare un punto di incontro e
di verifica tra le teorizzazioni (riconoscimento di autorità
ad un'altra donna, pratica della relazione politica, ecc.) e la
realtà delle nostre relazioni vissute nell'esperienza
quotidiana (nel gruppo stesso, nei luoghi familiari, in quelli di
lavoro), perchè, afferma Maria Procopio che da anni coordina
il gruppo, «è importante ancorarsi alla realtà in
cui si vive e non parlare solo in via teorica e di rapporti teorici.
Ne nascono, da una parte esperienze interessanti: seminari con le
donne in alcuni luoghi di lavoro, assunzione di cariche
politico-amministrative in alcuni Enti locali, e tutte gli altri
progetti di cui si è già parlato e che Kore ha promosso
o ha contribuito a realizzare; dall'altra, l'esperienza reale dà
la misura dell'importanza dell'essere in relazione politica con
un'altra donna per costruire simbolico e trasformazione, ma, nello
stesso tempo, “costringe” ad incontrare continuamente,
innanzitutto partendo da sé, anche ciò che fa ostacolo
alla costruzione o al mantenimento di relazioni politiche, l'invidia
in primo luogo e la rivalità, nonostante ciò che viene
teorizzato. La capacità delle donne di Kore probabilmente è
stata quella di avere scelto la via difficile del confronto al
proprio interno, anche duro, cercando sempre una mediazione a partire
dal riconoscimento anche dei sentimenti negativi e senza mai operare
una assunzione dogmatica della relazione politica tra donne. E'
questo che ha consentito al gruppo di non rompersi, di essere ancora
oggi una realtà significativa nel luogo in cui opera e di
continuare a costruire relazioni e progetti di cambiamento»,
così come era già stato affermato nel ‘93: «...I
luoghi delle donne, il nostro luogo separato, come
necessità/desiderio per continuare una strada di soggettività
femminile, di visibilità politica, di relazioni tra donne, di
costruzione di simbolico femminile ma, anche, a partire da questi
luoghi, dalla libertà e dall'autorità che ce ne viene,
la proposizione di un dialogo intersoggettivo tra i sessi, tra generi
differenti»71
IL
GRUPPO KORE CON PINA NUZZO (UDI NAZIONALE)
Diversi,
come si diceva prima, sono i progetti politici avviati dalle donne
di Kore; di alcuni di questi si parlera' nei paragrafi successivi,
qui' vogliamo ricordare l'esperienza del comitato di gestione del
consultorio di Soverato e l'incontro avvenuto all'Acero nel 1991 tra
numerose associazioni del catanzarese.
L'esperienza
della gestione del consultorio da parte delle utenti e' una prassi
che va avanti fino a tutti gli anni '90 e riveste significativa
importanza l'esperienza del comitato di gestione dal '90 al '95
presieduto da Maria Grazia Riveruzzi del gruppo Kore. La gestione,
infatti, si basa sulla pratica della relazione politica tra donne e,
come dice direttamente Riveruzzi “Questa pratica politica fatta
di relazioni e di mediazioni e agita nel consultorio conferi' alle
donne utenti l'autorita' di porre le loro regole e il loro modo nuovo
di fare politica dentro e fuori il consultorio, di opporsi alle
strumentalizzazioni, all'arroganza o all'indifferenza della classe
medica, agli ostruzionismi e alle meschine furbizie della classe
politica o amministrativa, ai protagonismi ed a tutto cio' che poteva
ledere la salute della donna. Il comitato di gestione in quegli anni
fu un luogo che permise la crescita politica delle donne consapevoli
del diritto alla propria liberta' e “autodeterminazione”.
Molteplici sono stati gli interventi attivati di informazione e di
prevenzione, di profilassi al parto, di educazione alla sessualita'
nelle scuole del comprensorio e tutti gli interventi previsti dalla
legge 194.
L'incontro
dell'Acero, invece, fu promosso nel giugno 1991 da Fulvia Geraciori
con l'obiettivo di organizzare un raduno di donne singole o
appartenenti a gruppi anche misti. Cosi' Geracioti riferisce riguardo
a questa esperienza: “Il deiderio di comunicare la rivoluzione
copernicana del femminismo della differenza era in me fortissima. Il
gesto piu' libero e gioioso che feci fu l'organizzazione nel '91 di
un incontro all'Acero, in montagna a San Vito sullo Jonio, distante
pochi chilometri da Soverato. Un incontro tra donne che stimavo e a
cui desideravo comunicare il mio percorso politico/esistenziale nel
segno della differenza di genere. Mi aiutarono fattivamente ad
accogliere trenta donne Assunta Di Cunzolo, Patrizia Greto, Lina
Santoro, Giovanna Veneziano. Vi parteciparono donne gia' “nella
differenza” come Ghita Peluso e Titti Voccoli di Taranto e le
amiche di Kore e di Lilith, sia altre con cui avevo condiviso in
altre circostanze l'impegno sociale e ne conoscevo la passione
civile. Tra quete Lorenza Rozzi, Adele Colacino, Sonia Serazzi, Nuzza
Barbuto, Marina Galati e Nunzia Coppode' dell'associazione Progetto
Sud, Aldina Alcaro del WWF, Rosanna Macrillo' e Franca Fortunato che
poi intrapresero il percorso della differenza collegandosi a Luisa
Muraro e a Via Dogana, la rivista della Libreria delle Donne di
Milano. Quell'incontro fu ricco di scambi, di emozioni, e anche di
incredulita; per tutte fu un seme che ciascuna fece germogliare
secondo i suoi tempi e i suoi desideri. A me in particolare diede
l'idea di fondare una rivista che fosse luogo di riflessione
politiche, testimonianza di pratiche tra donne consapevoli del
proprio genere che si giocano il desiderio di “esistere e fare
mondo”. La scommessa della rivista Tempo di Marea fu di tenere
aperto lo scambio politico senza ricorrere a schemi neutri,
nell'intento di unificare quello che il pensiero occidentale di
Aristotele in poi aveva diviso: il corpo e la mente, la teoria e la
pratica, il desiderio e la progettualita'”.
Tempo
di Marea
«23-24-25
luglio in Calabria (Mediterraneo) nel giardino e nella casa di
Assunta – nella Tredicesima ora – è nata la
creatura-rivista Tempo di Marea. Promotrici dell’incontro Anna
Scacco, Assunta Di Consolo, Elena Hoo, Fulvia Geracioti, Patrizia
Fulciniti. Noi tutte provenivano dall’esperienza redazionale
della rivista Mediterranea
l’osservatorio delle donne e
siamo state – con altre le fondatrici dell’associazione
omonima. Nel giugno dell’89, insieme a Teresa Barberio, Lina
Santoro, Martha Bache-wiig ci siamo chiamate l’un l’altra
per collaborare alla rivista ideata da Nadia Gambilongo. Tra acune di
noi esistevano relazioni duali maturate in altri contesti, ci
accomunava tutte il desiderio di comunicare con altre donne
attraverso il tramite della scrittura. Era per tutte la prima volta:
grande entusiasmo, quindi, molta ingenuità e alcuni errori
conseguenti. Un’esperienza comunque formativa. L’errore
fu la mancata valutazione dell’importanza di una chiara
relazione politica tra tutte noi della redazione: davamo per scontato
che bastasse essere donne, voler comunicare con le donne perché
la scommessa riuscisse. Il desiderio di ciascuna era sincero e forte,
ma informe, senza regole comuni, come se qualcuna scoccasse la sua
freccia su un bersaglio senza centro. Il risultato fu una rivista
volenterosa ma politicamente-simbolicamente confusa (…) Dopo
due anni sospendemmo la pubblicazione perché il disagio
interno impediva la circolazione creativa del desiderio. Noi, le
ideatrici-genitrici di Tempo
di Marea,
credendo ancora fortemente nella validità creativa di un luogo
di comunicazione stabile e dinamico, di un tempo-spazio di
costruzione del mondo quale è la rivista, abbiamo cominciato a
riflettere su come il nostro desiderio potesse avere forma chiara e
comunicabile tra noi e con le altre donne. Su come, dunque, il
desiderio potesse avere significato politico mettendo in atto quel
“processo creativo-divino di pensare parlare agire che è
Nominare”. Volevamo un progetto condiviso, attuabile attraverso
una rivista, che consentisse alle donne, legittime eredi della “dea
Verbo” di pervenire ai “poteri del Divenire attraverso le
parole Elementarmente Metamorfiche (…) che spostano le forme
dello spazio e del tempo (…) che ridisegnano le linee di
forza, irrompono al di là dei confini e li cambiano”.
Mezzo e orizzonte ci apparve subito essere la relazione consapevole
tra donne: la “ginergia”
che, dispiegata, creasse grandezza femminile. Libertà
femminile. Ordine femminile»72
«Ci
ritroviamo spesso a pensare nel gruppo che il valore del pensiero
della differenza sessuale sta nel fatto di avere svelato ciò
che è, di aver messo in parole ciò che esiste e che
veniva occultato, e questo è stato possibile grazie alla
pratica del partire da sé, dal corpo, dalla propria esistenza
materiale. Così sono stati svelati artifici, alchimie, bugie,
inconsistenza e danno di una cultura che, basata sulla negazione del
corpo, ha fatto del mondo un deserto di vita. Ed è questo
deserto che noi donne vogliamo far fiorire: solo noi possiamo farlo,
ne siamo consapevoli da tempo, anche se oggi molti sono pronti ad
affermarlo»73
«Tempo
di marea» è dunque una rivista di riflessione ma anche
di pratica politica. La sua struttura si articola in tre parti
direttamente ispirate a “Le tre ghinee” di Virginia
Woolf. Le produzioni teoriche, i saperi e il pensiero delle donne
vengono raccolti nello spazio de la Signoria
del pensiero
«Prendi
questa ghinea e la usi per radere al suolo l’intera
costruzione(….) E che le figlie degli uomini colti danzino
intorno al grande falò (…) mentre le loro madri
sporgendosi dalle finestre più alte, gridano: ”Che
bruci!Che bruci!Non sappiamo che farcene di questa istruzione”».
La seconda Ghinea accoglie le esperienze delle donne impegnate nelle
professioni e quindi liberate dal bisogno, la Signoria
della produzione:
«Che le figlie delle donne incolte intreccino una danza intorno
alla nuova casa (…). E le loro madri rideranno felici nella
tomba: “Per questo abbiamo sopportato insulti e disprezzo!
Illuminate le finestre della nuova casa, figlie! Che risplendano!”».
Ed infine lo spazio dedicato alla terza ghinea intesa come
possibilità aperta per la donna che agisce nel mondo,
la
Signoria dell’etica che
fa riferimento alla risposta data da V. Wolf a chi le chiedeva di
lottare
insieme agli uomini nella II guerra mondiale contro il nazifascismo:
«il
modo migliore per aiutarvi a prevenire la guerra non è di
ripetere le vostre parole e seguire i vostri metodi, ma di trovare
nuove parole e inventare nuovi metodi».
Esplicative
del senso e dell'impostazione della rivista sono ancora le parole di
Geracioti “... In questo numero, accanto al nostro nome, ci
sara' il nome di nostra madre, perche' nessuno dimentichi che siamo
nate da donna. Portiamo nel nostro pensiero, nelle nostre parole i
segni, le cure e i doni che abbiamo ricevuto dalle nostre Madri: la
donna a cui particolarmente devo l'energia per intraprendere questo
volo di gioia in “Tempo di Marea” e' Mary Daly: sono i
suoi pensieri che scrivo tra virgolette, sua e' la parola-concetto
che da' nome alla rivista.
Da
Virginia Wolf sono giunti a noi preziosi insegnamenti, la
presentifichiamo scegliendo, per la scansione delle tematiche della
rivista, il simbolico rappresentato da Le
tre ghinee. Ma il mio e' il debito
di tutt le redattrici e' anche verso le genealogie mute
che ci hanno tramandato vita e saperi. Ed e' anche verso le donne
viventi che con il mostrare la loro liberta', con lo starci accanto
ci indicano strade nuove: alcune sono qui nominate, altre saranno
rese visibili in tutti i numeri della rivista: lunga vita a “Tempo
di Marea”, dunque, affinche' il debito sia pagato e il
ringraziamento sia chiaramente espresso.
Accanto
a noi, del nucleo redazionale originario, a noi che assumiamo di
vivere in Calabria come topos di mediterraneita', ci sono le donne
che vivono in Puglia e sono in relazione politica con noi, a partire
dalla condivisione di questo dato originario che trascende la
categoria goegrafica per offrirsi come luogo di concreta pregnanza
simbolica: Maria Grazia Napolitano, Marilena Cataldini, Margherita
Peluso, Titti Voccoli, Rita Groffedo. A noi e a loro appartiene la
maternita' di “Tempo di Marea” poiche' l'averle
incontrate ha suscitato in noi nuove energie, entusiasmi,
prospettive”.
Centro
Lilith, Le Lune
Il
Centro Donna Lilith
Nasce
nel marzo del 1988 dal desiderio di alcune donne di Lamezia Terme
(incontratesi in occasione della manifestazione romana delle donne di
CGL CISL e UIL) di creare un “luogo privilegiato di relazioni
tra donne”.
UNA
RETE DI RETI
↓
Donne
di Lilith
↓
Suore
Oasi Bartolomea
↓
Centro
Roberta Lanzino
↓
Mediterranea(Nadia
Gambilongo, Anna Scacco)
La
costituzione ufficiale avviene il 20 dicembre 1988. Nel marzo del
1991, a seguito del finanziamento concesso dalla Regione Calabria
(finanziamento erogato per la gestione di un solo anno e mai più
rinnovato), apre l’ufficio di consulenza e assistenza legale.
Si tratta di un servizio, erogato nell’ambito del «Progetto
Donna» - sostenuto allora da Simona Dalla Chiesa - di
consulenza e assistenza legale gratuita, che comprende la
costituzione di parte civile nei processi penali ed altre iniziative
a tutela dei diritti e degli interessi delle donne. Il servizio
legale si svolge attraverso una prima fase di consulenza gratuita,
mentre l’assistenza legale viene fornita gratuitamente solo a
chi non è in grado di sostenerne le spese per oggettive
difficoltà economiche. Il Centro utilizza, per liquidare le
parcelle degli avvocati, il “Fondo spese legali” facente
parte del “Progetto contro ogni forma di violenza –
Istituzione del servizio regionale di consulenza e assistenza legale
alle donne”, approvato dalla Giunta regionale con delibera del
18 gennaio 1990. Coordinatrici del servizio sono le avvocate Virginia
Aloisio, Paola Garofalo, Patrizia Maiello e Anna Puleo. L’assistenza
legale, fornita grazie alla collaborazione di avvocati
particolarmente sensibili all’argomento, è ben
documentata da un dossier pubblicato dal Centro «per offrire un
significativo spaccato, certo assai parziale, di violenze, soprusi ed
abusi subiti dalle donne calabresi, specie da quelle più
socialmente ed economicamente svantaggiate».
Donne
vittime di minacce, cacciate di casa dal marito, soggette a violenza;
il motivo che ricorre frequentemente tra le donne che si rivolgono al
Centro è la violenza fisica e psicologica subita dai mariti.
Nel
dossier ritroviamo casi di separazione da mariti violenti, cause per
l’affidamento dei figli, cause per il recupero degli alimenti,
cause di lavoro, cause per violenza carnale e una consulenza legale,
per cui si è fatto riferimento alla legge 125 sulle Pari
Opportunità, per il caso di tre vigilesse decadute dalla
nomina per motivi di altezza. Nel 1990, inoltre, il Centro Lilith
partecipa, insieme ad altri gruppi e associazioni, al “Comitato
per la difesa della 194” e richiede la costituzione di parte
civile in occasione del processo tenutosi a Lamezia Terme a carico di
tre medici accusati di eseguire aborti a pagamento all’interno
di strutture pubbliche.
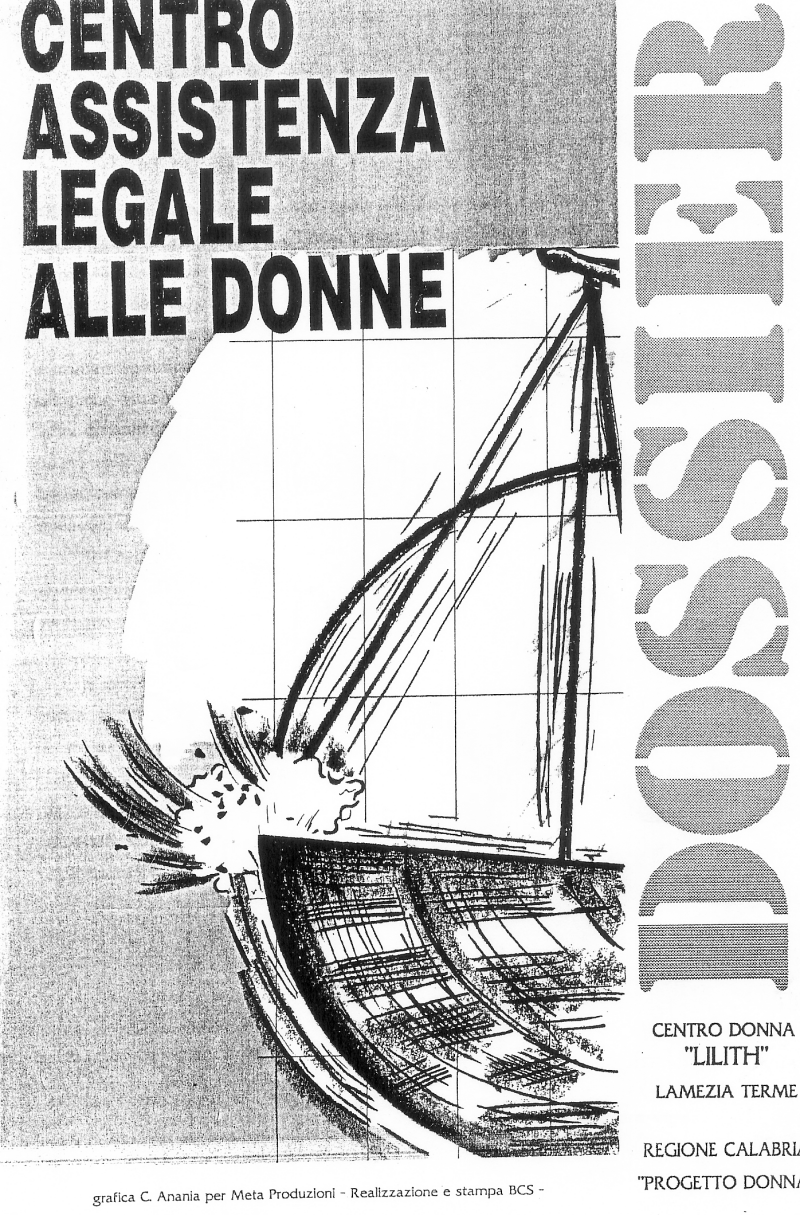
Il
Centro Donna Lilith si propone di «creare, potenziare e
diffondere una cultura basata sul rispetto della persona e della
dignità umana per una migliore qualità della vita e per
favorire lo sviluppo culturale sociale e politico della realtà
donna».
L’obiettivo
è dunque quello di modificare le logiche di sopraffazione che
regolano la società e di cui sono vittime non solo le donne
ma, in generale, i soggetti più deboli. Fattore
indispensabile, affinché questo cammino possa avviarsi, è
quello di organizzare una vasta comunicazione tra donne che rafforzi
la consapevolezza del proprio portato culturale e che favorisca la
trasmissione nella società dei valori della cultura femminile.
Lilith, dunque, cerca di incidere anche sul piano culturale
scegliendo, nel maggio del 1988, di aprire la campagna di
sensibilizzazione in merito alla legge sulla violenza sessuale con lo
spettacolo teatrale “Storia di Giovanna e altre” della
compagnia Teatro Danza di Verona. Il giugno seguente il Centro
Lilith riesce a raccogliere circa duemila firme, spedite poi alla
Camera, in appoggio alla legge.
Nel
1990 il Centro organizza quattro seminari tenuti dalle ricercatrici
dell’associazione Nosside dell’Università della
Calabria: l’ 8 novembre 1990 “Il genere nei modelli
culturali” (G. Greco); il 22 novembre 1990 “Gli archetipi
femminili: un itinerario antropologico operante” (F.
Geracioti); il 5 dicembre 1990 “Uguaglianza e differenza nella
storia delle donne : l’antichità” (I. Verace); il
20 dicembre 1990 “Immaginario pubblicitario e rappresentazione
femminile” (A. Salvo)
Nel
febbraio del 1991 le socie decidono di dare vita a riunioni serali
settimanali di lettura e studio sui temi del pensiero della
differenza sessuale. In queste riunioni si leggevano i “Sottosopra”
e i vari numeri di “Tempo di Marea”. Contemporaneamente
grazie al rapporto tra Teresa Barberio e le suore dell’Oasi
Bartolomea si crea un gruppo di laiche e cattoliche
che
svilupperà un ciclo di
incontri
sui temi della differenza analizzati da un orizzonte teologico.
Tuttora alcune donne di Lilith continuano questo percorso di
riflessione.
Era Teresa Barberio a passare
“Via Dogana” a suor Rosetta: “Siamo riuscite a
ritrovare nelle suore la donna. La non maternità ce le faceva
vedere come non donne. Ma la riflessione sulla differenza ci apre
nuovi orizzonti perché non è la maternità il
ruolo fondamentale della donna”
Ricordano suor Evelina che
dava assistenza ai malati terminali: «Non “io”,
diceva, ma “la bambina che è in me”. Questa suora
aveva più consapevolezza della propria identità
sessuale di quanta ne avessimo noi che ci sentivamo femministe. La
Messa veniva celebrata in modo diverso. Il prete faceva il minimo
indispensabile ed anche le presenti intervenivano se volevano.»
E ricordano anche Vittoria,
Suor Emmanuelle Marie, che e’ stata una suora di Betania
(ordine nato nell’800 per l’accoglienza di ergastolane e
prostitute). Nata a Parigi entra trentenne in un ordine religioso
contemplativo e vi rimane per circa 40 anni. Ora, lasciata la
clausura, continua la sua testimonianza nel mondo mettendosi al
servizio dei più poveri. Le donne di Lilith la conoscono
quando ha già lasciato i voti. Il vescovo della sua diocesi a
Roma la accusa di una lettura troppo libera del vangelo. E’ lei
a spiegare il valore del silenzio. L’urgenza di narrare deve
fare spazio alla capacità di aspettare. Emanuelle Marie
reagisce alle provocazioni del Vangelo con tutta la sua sensibilità
di donna e di credente e vi scopre l'immagine di un Dio che si
identifica con i poveri, gli emarginati, i rifiuti della società.
Importanti, per lo sviluppo di
questo percorso, sono stati gli incontri delle donne Lilith con suor
Antonietta Potente.
Il
Centro di assistenza legale Lilith chiude nel 1996 per mancanza di
fondi regionali e devolve tutti i fondi residui alla Fondazione “Mago
Merlino”, la casa di accoglienza per ragazze madri fortemente
voluta da suor Rosetta Colombo. Lina Mazzei tenne in piedi questa
rete fino alla chiusura del Centro.
L’esigenza
che dà vita a quest’esperienza è quella di stare
negli ingranaggi della società, non con spirito da
“crocerossine”, ma mettendo in discussione prima di tutto
se stesse.
Non
più il filtro del partito, del sindacato o dell’UDI, ma
la pratica della solidarietà tra donne. Un legame tra esse che
è il frutto di riconoscimento reciproco. Un’applicazione
quasi alla lettera del L’ordine
simbolico della madre che,
raccontano, «abbiamo letto, riletto, sottolineato» e che
ovviamente come ogni teoria applicata alla pratica non manca di
rivelare i suoi limiti di praticabilità. Raccontano, infatti,
che i conflitti all’interno del Centro nascevano, più
che dalla sete di potere (anche se “qualcuna pretendeva
autorità”), da un’ esigenza forte di
riconoscimento. Così racconta Gabriella De Pascale: «Sono
io però che devo riconoscerti autorevolezza, non puoi dartela
da sola, perché se te la do io, io esisto, altrimenti io non
ci sono, non conto niente. Siamo cresciute nel disconoscimento, siamo
assetate di riconoscimento...che esistiamo, che abbiamo un valore,
che la nostra parola e il nostro agire è importante. Bisogna
evitare di amare l’altro senza dargli libertà, come
tante volte si amano i figli. Devi riconoscere che sono persone, che
la possono pensare diversamente da te. Amare è rispettare
l’altro e riconoscerlo come altro.»
Ed
in questo mettersi in discussione -«alle riunioni ci mettevamo
sulla graticola»- fondamentale è la rielaborazione del
rapporto con la madre: «Le nostre madri non erano per noi un
buon modello perché le vedevamo come perdenti e siamo
cresciute con quest’idea della donna perdente, per questo a
volte siamo così aggressive».
Interessante
risulta il dialogo che segue e che ripropongo per come si è
svolto : «Ma perché non c’è benevolenza tra
noi donne? E’ come se ci si sforzasse per essere positive e
benevole (L.R.); Perché secondo me nelle debolezze delle altre
vediamo la debolezza della madre e la nostra. Ti fa male dell’altra
quello che ti appartiene (G.D.); Ad esempio a me la donna egocentrica
non piace, magari mi stanca ma non mi fa arrabbiare (L.R.) Quella che
da fastidio a me mi ricorda mia madre, per questo mi fa rabbia, se
avesse un altro difetto probabilmente potrei essere anche più
benevola (G.D.); Ricordo un clima positivo con le altre donne.
Andavamo agli incontri anche con i figli, e meno male che questi
figli hanno respirato mamme che uscivano. Non c’è
rottura con i nostri figli e questo forse crea anche dei problemi.
Per noi la normalità era pensarla diversamente dai nostri
genitori, mentre noi finiamo per essere anche più ingombranti.
A volte bisognerebbe fare un passo indietro, perché altrimenti
si rischia di far scomparire la figura del padre. Hanno sempre
lavorato e non hanno avuto una comunità di riflessione come la
nostra (L.R.)».
E alla domanda sul motivo del
vuoto di comunicazione tra la loro esperienza e la nostra generazione
rispondono che «forse passano i modelli più che le
parole».
Le
Lune
Le
Lune è un’esperienza che nasce a Catanzaro nel 1989
quando le ACLI organizzano un corso per creare consigliere di parità
(era un corso pensato per donne occupate, circa 10). Le fondatrici
sono: Lina Scalzo, Ornella Lavitola, Maria Rocca, Anna Maria De
Marco, Rosanna Barbuto, Lorenza Rozzi, Maria Teresa Iuliano, Anna
Puleo, Maria Rosaria Sganga, Francesca Ferraro, Pina Paparatto. In
seguito si sono aggregte altre, tra cui Serena Procopio e Rosanna
Macrillò. L’esperienza comincia così: le ACLI
decidono di far gestire il corso alle donne dell’associazione e
tra loro, all’interno del coordinamento femminile, c’è
Anna Maria che è anche responsabile provinciale. Ciò
che si cerca per primo è un esperto di normative europee per
il lavoro della donna. A Cosenza è da poco arrivata Cristina
Marcuzzi, che accetta il compito con un moto di gioia: aveva
esperienza di collettivi che riflettevano sulla differenza. Il primo
consiglio che da è quello di non usare docenti di sesso
maschile. Tra le docenti vi sono Renate Siebert, Anna Salvo, Ida
Vece, Giovannella Greco, Ida Rende, Carmen Leccardi, Donatella
Barazzetti, Ida Dominianni, Gianna Gilardi. Al corso insegna anche
Anna Rossi Doria che indica come primo passo quello di guardare anche
la donna più lontana da sé. Anna Maria racconta, ad
esempio, che il corso le ha insegnato il valore dell’ambivalenza,
che lei ha usato per pacificare i rapporti con la suocera. Lorenza,
che aveva vissuto la fine della sua esperienza lavorativa
nell’ospedale come uno scacco, comprende, grazie alla lettura
dell’ultimo “Sottosopra”, che la sconfitta non era
sua, “bensi' di un sistema che non avevo contribuito a
costruire e che anzi combattevo, intriso a tal punto di corruzione e
potere da convincermi dell'impossibilita' di un suo cambiamento. Sono
cosi' riuscita a rielaborare la dimensione dello scacco”. Anna
Rossi Doria corregge inoltre le loro brochure, eliminando i termini
più lamentosi. La cosa straordinaria è che
quest’esperienza nasce come occasione tecnica e poi si
trasforma in un’occasione per ripensare alla propria vicenda
personale ed anche al movimento politico delle donne. Anche se non si
fa più politica delle donne, il segno di quest’esperienza
è tangibile. Anche le ACLI portano il segno di questa nuova
soggettività femminile. Durante il corso erano state avvisate
che sarebbero uscite con una forte carica che avrebbero poi dovuto
saper gestire all'esterno. Le più politicizzate riuscivano a
gestire questa specie di “doppia militanza”. “Lina
Scalzo, raccontano, interveniva sempre per ancorare ogni discorso
alla quotinianita' dei vissuti. Lei, sindacalista, riportava alla
realtà”. Tra le attività esterne di cui ci rimane
traccia ricordiamo: una serie di seminari coordinati da Anna Rossi
Doria; Raffaella Lamberti (Libreria delle donne di Bologna):
“Esperienza delle donne tra esclusione e voglia di contare”
da novembre del ‘90 a gennnaio del ‘91; Amalia Signorelli
(storica): “Condizione della donna calabrese tra famiglia e
familismo”; Dacia Maraini: “Corpo e pensiero di donna.
Pensiero e separazione”. I seminari permettono al gruppo di
aprirsi, c’era sempre molta gente. Ad un incontro con Renate
Sierbert (presentazione del testo “E’ femmina però
è bella”) c’erano Anna Salvo e Ida Dominijanni.
Il gruppo, in effetti, si scioglierà perché
“probabilmente erano finite le cose da dirsi, anche se non si
e' interrotta la relazione profonda che abbiamo costruito”.
Alcune di loro hanno voluto incontrare suor Antonietta Potente
recandosi all'Oasi Bartolomea di Lamezia: “Sono rimasta molto
colpita da questa donna colta e ascetica, che, tra le presenti
desiderose della sua amicizia, ha scelto Lina - racconta Lorenza
Rozzi - ; ancora oggi mi trovo a riflettere sulla loro intesa, tra
donne: quella tra una creatura tutta proiettata verso il cielo, suor
Antonietta, e una creatura fortemente ancorata alla terra, Lina; a
dispetto delle diversita' ne e' nata una bella amicizia, ne abbiamo
tutte goduto e comunque rimane un insegnamento e un ricordo
incancellabile”.
3.3
Federcasalinghe, Fidapa di Soverato
Federcasalinghe
La
Federcasalinghe nasce nell’89 dietro l’input della
presidente nazionale Federica Rossi Gasparrini ed a Soverato trova la
sua sostenitrice in Anna De Marco Parrello, attualmente responsabile
provinciale dell’associazione.
«Premesso,
dice Anna De Marco, che tutte le donne sono casalinghe, alcune a
tempo pieno altre part time, è stato difficile cancellare
quella falsa immagine, tanto che l’associazione ha dovuto
imporre un cambiamento culturale per riuscire a rappresentare la vera
realtà della casalinga, colei che gestisce le risorse
affettive , culturali ed economiche del suo nucleo familiare».
Inizialmente
aveva obiettivi di tutela dei diritti delle donne, come il
riconoscimento giuridico del lavoro familiare, poi ha cominciato a
pensare all’assegno di maternità per le mamme
casalinghe, cosa ottenuta; quindi all’assegno per sostenere le
famiglie in difficoltà, alla legge per la tutela contro gli
incidenti domestici, all’assicurazione per le casalinghe, cosa
realizzata dall’INAIL. Così De Marco ricorda quegli
anni: «Lentamente si è innestata un’azione
culturale di crescita delle donne e di impegno per una loro maggiore
presenza nei centri di gestione del potere politico ed economico.
Agli inizi, organizzavo gite per le associate, cosa che può
sembrare banale, ma che in effetti fu da stimolo ad una maggiore
coesione tra gruppi di donne che non si erano mai incontrate e che
cominciarono ad interessarsi della storia della Calabria, delle
testimonianza del suo passato, poiché la presidente sapeva
unire al dilettevole (l’uscita in compagnia), l’utile
(notizie storiche sui tanti siti archeologici che si andavano
visitando)».
All’inizio
nella provincia di Catanzaro ci furono 12 mila socie, poi, anche la
Federcasalinghe visse la crisi dell’associazionismo ed il
numero delle iscritte si ridusse. La responsabile dell’associazione
a Catanzaro in un primo tempo fu Marilina Ranieri, Anna De Marco
Parrello fu eletta responsabile provinciale, carica che ancora
occupa.
Le
Federcasalinghe hanno una sede anche a Lamezia, all'interno del
Centro Studi Lazzati.
Ad
Anna De Marco Parrello sono state rivolte alcune domande, allo scopo
di contestualizzare la progettualità e l’azione del
gruppo.
Quali
obiettivi avete raggiunto?
«Abbiamo
raggiunto gli obiettivi prefissati, come il sostegno alla famiglia
numerosa, chi ha tre figli minori percepisce un assegno annuo di
circa 4.800.000 delle vecchie lire; ultimamente, in seguito alla
crisi delle associazioni, la Federcasalinghe si è trasformata
in holding sociale con varie diramazioni, dal sostegno alla casalinga
si è passati all’attenzione verso la famiglia: in
tutt’Italia c’è stata l’apertura di
Sportelli Informafamiglia, e qui lo abbiamo realizzato a Sant’Andrea,
perché in questo paese ho insegnato e quindi conoscevo bene la
sua realtà socio economica».
Nel
2001 si ha l’affermazione dello Sportello Informafamiglia dopo
la chiusura dei corsi di formazione svoltisi in tutto il territorio
nazionale. Tre anni di volontariato allo Sportello che però,
aggiunge la presidente provinciale, «mi hanno permesso di
imparare tane cose, conoscere meglio la gente e fare tanto lavoro».
Allo
Sportello collaborano tre avvocati, ha sede presso il Comune dove il
Sindaco ha messo a disposizione una bella stanza e la sua
collaborazione. Lo Sportello oggi è un punto di riferimento,
si avvale della disponibilità delle Istituzioni e facilita il
quotidiano di tante donne, che spesso hanno delle titubanze quando si
tratta di parlare col Sindaco o con le forze dell'ordine. «Si è
creato un circuito di relazioni e di amicizia, ma specialmente di
sostegno a tante donne: un esempio, 150 donne hanno fatto la Moc
gratuitamente, e molte, che non avevano mai fatto una visita
ginecologica, sono state visitate. Le lotte sostenute
dall’associazione sono state dure e difficili, ma alla fine si
sono raggiunti gli obiettivi desiderati. Nella finanziaria del 99
erano stati introdotti due provvedimenti che rientrano negli accordi
elettorali sottoscritti tra Donne Europeee Fedrecasalinghe ed Ulivo e
cioè l’assegno di maternità per casalinghe
disoccupate di lire 2.500.000 rivalutabile annualmente, l’assegno
per i nuclei familiari con tre figli minori ed a basso reddito di
lire 2.500.000, rivalutabile. Altamente positiva, nel 2001, la
nascita del fondo famiglia, Legge 124/93, una pensione accumulata con
gli scontrini della spesa, che in poco più di un anno ha
ottenuto un aumento del 154 % del patrimonio. Le socie seguono
l’attività dell’associazione , scoprendo così
anche il gusto di rapportarsi, di conoscersi, ed anche di divertirsi
insieme.Tante sono state in questi anni le iniziative della
Federcasalinghe: convegni sugli infortuni domestici, sulla
prevenzione in medicina, partecipazione a trasmissioni televisive
sulle reti nazionali, divulgazione delle informazioni su come poter
fare imprenditoria, gemellaggi fra donne europee, e tant’altro.
Il tesseramento –spiega la Parrello- offre numerosi vantaggi:
ricordiamo solamente il soccorso medico offerto dalla centrale
operativa “Inter partner”, i prezzi agevolati presso le
terme e presso i centri diagnostici, assicurazioni auto a prezzi
speciali sconti per l’acquisto di libri presso le librerie
Mondadori e Sele Book».
Come
sono stati i rapporti con le altre associazioni?
«In
un primo tempo non ci hanno apprezzato, forse l’idea che ad
associarsi fossero le casalinghe era considerata “popolare”:
lentamente però è stato chiaro che eravamo una forza
dalla quale poteva nascere uno scambio di esperienze e cultura e
l’atteggiamento di indifferenza verso la Federcasalinghe è
lentamente mutato»
A
tuo giudizio qual è il problema più diffuso oggi tra le
donne?
«Vivono
male in casa, nella famiglia, c’è un disagio familiare
terribile, a volte dietro atteggiamenti che possono sembrare “strani”
ci sono situazioni di malessere psico fisico incredibili». La
Federazione si è recentemente battuta per il lavoro
interinale, ha creato i fondi pensione, si sta battendo per un
progetto di “baby parking”, per dare maggiore
tranquillità alla donna che lavora, ma sta pensando anche alle
donne che in casa curano gli anziani, per le quali propongono un
contributo economico da parte dello Stato.
Ma
questo non vuol dire invogliare la donna a stare sempre a casa?
«No
davvero, ognuna è libera di fare delle scelte, part–time,
lavoro interinale... Qual
è stato il tuo rapporto con il pensiero femminista in questi
anni?«Il
femminismo nel senso “esagerato “ del termine non mi ha
visto mai d’accordo, ma se c’era una lotta da fare io ero
sempre pronta, se convinta di essere nel giusto e senza mai
rinunciare alla mia femminilità».
Se
ti chiedessero un impegno in politica, ci penseresti o accetteresti
subito?
«Me
l’hanno chiesto in tanti, io però non mi sento di vivere
la politica, che per me non è una cosa limpida così
com’è, ti impone un habitus e dei compromessi; si può
fare politica anche come facciamo noi, aiutando donne e giovani
attraverso lo sportello e parlando con le donne che vogliono stare
assieme, per incontrarsi e discutere di tante cose».
Fidapa
di Soverato
La
Fidapa di Soverato nasce nel 1990, grazie a Francesca Lovecchio
Fondacaro e ad Angelica Biacca, «alla quale -dice Francesca-
tutta la sezione è grata per l’animus di madrina di
battesimo, e per il supporto morale e fattivo con cui ha sempre
seguito la fase iniziale di vita del club». Il club è
nato col contributo di 22 socie: Angela Alfierazzi, Tina Alvaro,
Rosalba Aversa, Adriana Castellotti, Antonella De Pace, Caterina
Galasso, Fulvia Gioffrè, Francesca Lovecchio, Antonella
Marvaso, Sandra Federici, Manny Megali, Manuela Pennacchi, Vanna
Peronace, Rosalba Pugliese, Marisa Rotiroti, Lilli Rosso. Oggi ne
conta 48. Dalla documentazione in nostro possesso si evidenzia che
l’associazione è cresciuta sempre di più negli
anni «grazie alle attività legate alla realtà del
territorio e alla valorizzazione delle potenzialità di ognuna
delle socie, che ha permesso la crescita di legami politici ed
umani», afferma ancora Lo Vecchio. Ogni presidente Fidapa
indirizza la programmazione secondo i propri intenti e le proprie
progettualità, ferma restando l’adesione al tema
nazionale biennale. Francesca Lo Vecchio ha iniziato la sua attività
di presidente con una conferenza sulle strategie delle Pari
Opportunità ed ha concluso il suo biennio con una tavola
rotonda sul tema “Donne e potere”, facendo il punto sulle
conquiste delle donne e sul ruolo importante che hanno nella società.
Il secondo biennio, guidato da Marisa Rotiroti, è stato
caratterizzato dall’incontro col gruppo “Kore” che,
pur con modalità differenti, lavorava sull’identità
femminile: da questo incontro nascerà il progetto della
Biblioteca delle Donne, come luogo di riflessione politica. Il
biennio si concluderà con un incontro su ”Donne e città”
che analizzava il rapporto tra le donne e le istituzioni. Il terzo
biennio, presieduto da Caterina Galasso, ha visto l’associazione
dibattere sul tema: “Rapporto tra donne e politica, desiderio o
necessità?”, dal quale è emerso che la
partecipazione delle donne nella vita politica è necessità
per un’evoluzione qualitativa della politica stessa. Tematiche
trattate in questo biennio sono inoltre riferite all’orientamento
e alla formazione professionale, indispensabili per un ingresso
paritario delle donne nel mercato del lavoro. Durante il quarto
biennio, la presidente Vanna Peronace, considerando il lavoro uno dei
nodi cruciali del Sud e della Calabria in particolare, decise di
farne il filo conduttore di diversi incontri, trattandolo sotto varie
sfaccettature. Nel primo incontro il tema e' stato sviluppato da
Donatella Barazzetti del dipartimento di sociologia dell’Università
della Calabria. La conferenza su “Comunicazione, informazione,
alle soglie del III Millennio” e' stata tenuta dal giornalista
Sandro Curzi e l’antropologo Luigi Lombardi Satriani.
Nell’ambito della conoscenza di culture limitrofe diverse, e
uniformandosi al tema nazionale e' stato promosso un incontro su
“Reti di relazioni tra donne in un progetto di cooperazione e
scambio tra donne israeliane e palestinesi” Il quinto biennio,
presieduto da Marisa Gigliotti, ha assunto come tematica centrale il
patrimonio artistico del territorio, con la conoscenza e il recupero
degli aspetti gastronomici e culturali. Attraverso incontri e visite
guidate si è data continuità al tema delle prospettive
occupazionali delle donne , legate all’espressione artistica.
Le iniziative, le attivita', le finlita' e gli obiettivi che il club
ha perseguito e continua a perseguire sono cosi' sintetizzate da
Francesca Lovecchio: “Ls Fidapa di Soverato svolge un'attivita'
socio-culturale, avendo come oggetto di studio, di meditazione, di
approfondimento molti aspetti dei problemi che travagliano la nostra
societa'. Si orienta verso quei problemi che investono le coscienze
di tutti in modo da portare un contributo alla formazione di una
cultura omogenea che, oltre ad essere un modello di vita e di
comportamento, sia emblematica della nostra identita' come
associazione che vuole contribuire a costruire un mondo migliore.
L'Associazione mira soprattutto a sollecitare nelle socie un'attenta
presa di coscienza di se' e la conoscenza della realta' che le
circonda per assumere poi, nei confronti di essa, le proprie
responsabilita', facendo emergere tutte le potenzialita' sia sul
piano professionale che su quello della vita sociale. Per questo le
socie si alternano come presidenti assumendosi ognuno la
responsabilita' di guidare il club come fosse una palestra di
esercizio di governo. Il club ha sempre cercato di intrecciarsi con
la vita della citta', dimostrando quanto sia arduo il cammino delle
donne in un ambiente che considera la donna fragile e subalterna”.
La Fidapa di Soverato è un’associazione attenta anche ad
altri bisogni della città; infatti nel ‘92 si fa
promotrice della donazione di un’emoteca. Nel ‘95 un
gruppo di fidapine (Angiola Alfierazzi, Tina Alvaro, Rosalba Aversa,
Francesca Lovecchio, Paola Nucciarelli, Vanna Peronace, Marisa
Rotiroti, Lilli Rosso, Anna Sia, Eva Winser) assieme al gruppo Kore
fanno nascere la Biblioteca delle Donne, con l’obiettivo di
valorizzare i saperi femminili. Così, pur attraverso percorsi
diversi, i due gruppi assumono lo stesso obiettivo e decidono di
lavorare insieme per perseguirlo. «L’associazione è
stata ed è per tutte un luogo di crescita umana e culturale:
non si sono tentate nè analisi né soluzioni corporative
o femministe, ma certamente sono state accettate e condivise lotte e
obiettivi del movimento delle donne. Non si è andate oltre
perché abbiamo pensato che avrebbe avuto poca importanza
innovativa sostituire a un vecchio “ismo” uno nuovo,
avendo la società bisogno di quell’equilibrio naturale
tra donna e uomo, pur nella loro specifica diversità.
Continueremo a lavorare in questo senso, almeno lo spero, con serietà
e continuità, in modo che nessuno potrà mettere in
dubbio il valore delle doti che fanno delle donne un punto di
riferimento e di sicurezza in un mondo disorientato e sordo ai
richiami dei valori». Nella sostanza, la finalita' che persegue
il club di Soverato e' l'impegno a costruire: “al di sopra di
ogni barriera ideologica, religiosa, razziale e geografica, con
tenacia e perseveranza quotidiana, una societa' migliore per essere
una forza che pesa nelle scelte e che, acquistando sempre piu'
autorevolezza, cerchera' di assicurare ad ogni donna una maggiore
dignita' della vita”.
3.4
La Biblioteca delle Donne Kore - Fidapa
L’idea
della Biblioteca delle Donne di Soverato nasce in un incontro
promosso a Lamezia dal gruppo di lavoro del ”Progetto Donna”.
Il Progetto Donna, ideato da Simona Della Chiesa nel 1987 come luogo
politico delle donne, era un organismo della Giunta Regionale e,
anticipando le Azioni Positive della legge sulle Pari Opportunità
per valorizzare la soggettività femminile (1992), stimolava la
formulazione di progetti da parte delle donne e delle associazioni
femminili e proponeva anche l’istituzione di Biblioteche e
Centri di Documentazione Rosa Tavella di Rifondazione Comunista,
unica consigliera regionale donna, nell’ottobre del 1992, dando
continuità a quanto si era stabilito in precedenza, insieme
con le donne del gruppo di lavoro e delle associazioni, decide di
erogare finanziamenti per progetti finalizzati ad attività
culturali e in particolare per le Biblioteche delle donne. Così,
nel dicembre dello stesso anno, a Soverato, le due associazioni KORE
e FIDAPA (Assunta di Cunzolo – presidente di Kore e Marisa
Rotiroti–presidente di Fidapa) presentano il progetto
Biblioteca al P.D. Per la stesura del progetto e del regolamento è
stata creata una rete di relazioni con associazioni (“Orlando”
di Bologna che gestisce il “Centro di documentazione delle
donne”) e donne di altre città, (Matilde Avenali della
Biblioteca delle donne di Ancona, con la mediazione di Adriana
Papaleo), che hanno offerto il contributo della loro esperienza. Nel
progetto della Biblioteca, 17 donne di KORE (Assunta Di Cunzolo,
Fulvia Geracioti, M. Grazia Riveruzzi, Viviana Santoro, Delia
Fabrizi, Maria Procopio, Teresa Ciaccio, Patrizia Greto) e FIDAPA
(Lilly Rosso, Rosalba Aversa, Eva Winser, Angiola Alferazzi, Tina
Alvaro, Vanna Peronace, Paola Nucciarelli, Anna Sia, Francesca
Lovecchio) con una diciottesima donna- Marisa Rotiroti - appartenente
ad entrambi i gruppi, si assumevano la responsabilità della
gestione. Dall’inizio ad oggi, la coordinatrice della
Biblioteca sarà Marisa Rotiroti; questa, la sua testimonianza
«La pratica della riflessione politica è stato il
contributo che le donne di Kore hanno portato nella Biblioteca,
mentre tutta l’organizzazione interna ed esterna è stato
il contributo delle donne della Fidapa. Sono stati anni ricchi e
fecondi di riflessioni e di incontri tra le donne delle due
associazioni e con le donne delle istituzioni»78.
L’Amministrazione Comunale “Pedalando Volare”
guidata da Gianni Calabretta79
, con Assunta Di Cunzolo vice sindaco, comprendendo come il pensiero
delle donne fosse diventato “cultura
della politica”, condivide
il progetto e concede i locali nel Palazzo di Città. Nel 2000,
in un rapporto dialettico e costruttivo, le donne delle associazioni
“Kore” e “Fidapa” stipulano una Convenzione
con l’amministrazione e, come atto di amore verso la città,
scelgono di donare, dopo 30 anni, tutto il patrimonio costruito dalla
Biblioteca delle Donne alla Biblioteca Comunale. L’amministrazione
s’impegna a concedere i locali e a mantenere anche in futuro la
denominazione “Biblioteca delle Donne KORE-FIDAPA” «quale
costruzione della memoria dei saperi delle donne»
. «La scelta della fondazione della Biblioteca a Soverato non è
stata casuale dice Marisa Rotiroti perché qui, a Soverato,
c’erano le condizioni favorevoli in quanto donne di due
associazioni culturali Kore
e Fidapa”
stavamo
riflettendo (ognuna per conto proprio e con modalità
differenti) sui percorsi di libertà delle donne; avevamo il
desiderio di uno spazio politico di relazione e di scambio di
esperienze tra donne al di la' delle appartenenze; c'era la
necessita' di un luogo fisico dove custodire tanti libri per
diffondere i saperi e la cultura delle donne”. Dal momento
della progettazione le donne delle associazioni si incontrano con
scadenza quindicinale per discutere di disparita', invidia, potere e
autirita' femminile, temi che in quegli anni si dibattevano anche a
livello nazionale, con posizioni e sfumature diverse tra i gruppi.
Tra le donne della Biblioteca non sempre c'e' uniformita' di vedute,
c'e' la storia, il non detto e il rimosso dei percorsi individuali e
collettivi di cui terner conto, ma il collante che consente loro di
governare i conflitti, a volte anche aspri e dolorosi, e' il
desiderio/necessita' di mettere in campo tutte le energie e le
mediazioni possibili per la realizzazione del progetto. La pratica
della relazione tra donne diventa, cosi', lo strumento funzionale al
conseguimento dell'obiettivo. Cosi' Marisa Rotiroti riassume
l'attivita' svolta dal 1996, data della fondazione della Biblioteca,
secondo la duplice modalita' di seminari interni, finalizzati alla
costruzione e all'esercizio della pratica di relazioni, e incontri
aperti all'esterno, nell'ottica della trasmissione di saperi, con
presentazione i scrittrici e loro libri, rappresentazioni teatrali di
donne, proiezioni di films con pa presenza di registe. “Molto
significative le discussioni sui Sottosopra (Rosa, Verde, Blu, Oro,
Rosso), documenti fondanti del pensiero delle donne, editi dalla
Libreria delle Donne di Milano. Il Sottosopra Rosso del 1996, che
nominava la rottura dell'ordine patriarcale, ha dato alle piu'
giovani l'opportunita' di raccontare la propria esperienza di figlie
liberate e di confrontarla con quella delle donne piu' anziane, che
avevano guadagnato il senso di essere libere attraverso il percorso
dell'emancipazione nell'UDI, nei partiti, nel mondo cattolico, nelle
associazioni e individualmente. Il seminario sul pensiero di Hannah
Arendt e' stato l'occasione per aprire il dialogo con insegnanti del
comprensorio e agire, nei diversi campi del sapere, uno spostamento
di sguardo che tenesse conto della nostra specificita' sessuata. La
rassegna di films di registe, iniziata con la consulenza
dell'Associazione Lucrezia
Marinelli di
Sesto San Giovanni (MI) sul tema Relazioni
tra donne, ha
proposto e legittimato uno sguardo sui modelli e comportamenti altri,
evidenziando, attraverso le emozioni suscitate dalle immagini, come
la comunicazione e i legami tra donne siano importanti per la
costruzione della soggettivita'. Dal 1997 le donne della Biblioteca
hanno rivolto una cura particolare alla formazione di genere delle
giovani generazioni lavorando molto con le scuole su letteratura e
cinema. Le/gli studenti hanno incontrato Joyce Lussu, donna della
Resistenza, e scrittrici del Sud di cui avevano letto i libri: Maria
Rosa Cutrufelli, Renate Siebert, Silvana La Spina. La rassegna di
films ha indotto la riflessione su come il diverso posizionamento
dell'occhio della macchina da presa sui corpi dei personaggi, da
parte di un uomo o di una donna, possa incidere sull'immaginario
collettivo. Infine, la sperimentazione di una pratica relazionale col
mondo sociale e con le istituzioni, laddove e' stato possibile
stabilire un rapporto, ha attraversato in modo trasversale tutto il
lavoro delle donne della Biblioteca concorrendo all'affermazione di
una soggettivita' femminile individuale e collettiva e di una cultura
in cui uomini e donne possano riuscire a costruire insieme una
societa' rispettosa delle reciproche differenze”.

Incontro
con Maria Rosa Cutrufelli. Da sinistra: Rosalba Aversa, Marisa
Rotiroti, Vanna Peronace, Maria Rosa Cutrufelli, Eva Winser, Fulvia
Geracioti
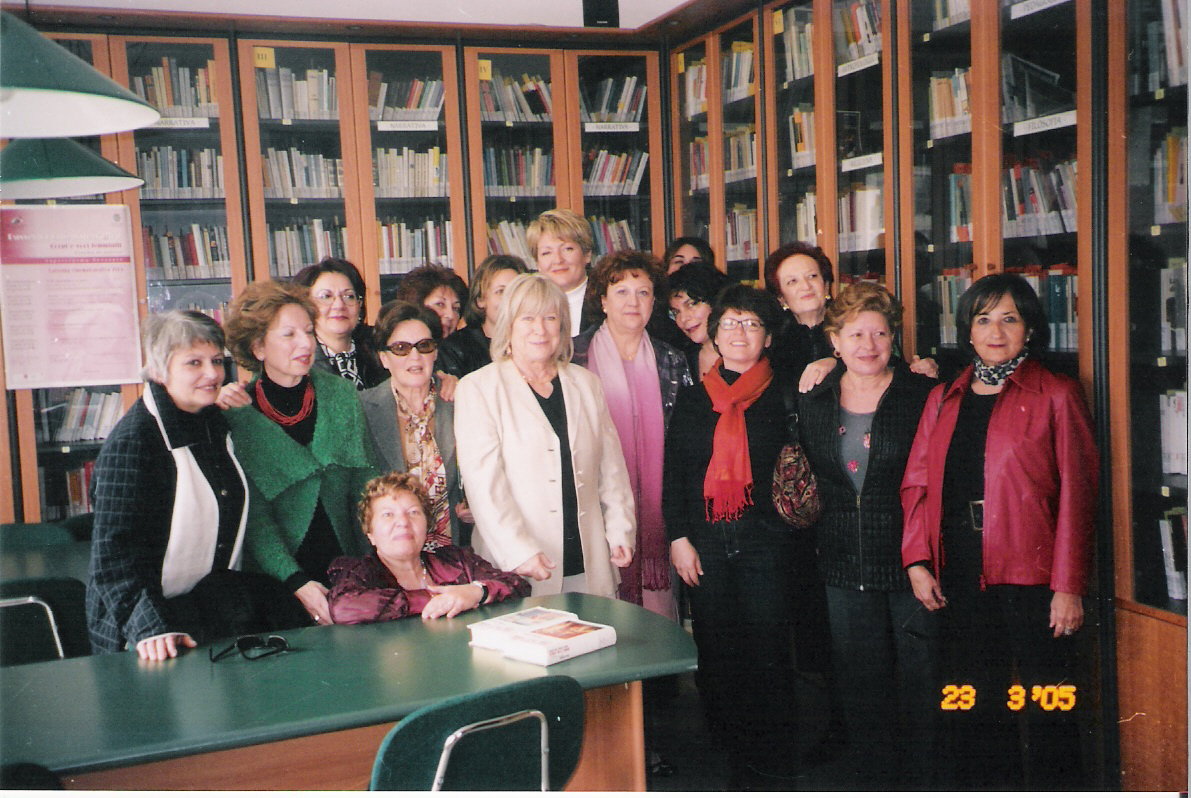
Incontro
con Margarethe Von Trotta. Da sinistra: Rosa Mangione, Vanna
Peronace, Rita Monaco, Rosalba Aversa, Viviana Santoro, Assunta Di
Cunzolo, Lilly Rosso, Margarethe Von Trotta, Paola Nucciarelli, M.
Grazia Riveruzzi, Fulvia Geracioti, Rosa Tavella, Maria Procopio,
Marisa Rotiroti Anna Sia, Adriana Esposito.
CAPITOLO
4
IL RACCONTO
Di
Giovanna Vincelli
Parole
e silenzi
Parte
della ricerca sui gruppi di donne della provincia di Catanzaro è
stata condotta attraverso interviste in profondità. In
particolare, sono state condotte 17 interviste che hanno interessato,
in maniera trasversale nel tempo, molti dei gruppi presenti, dagli
anni Settanta ad oggi, nella realtà territoriale oggetto di
indagine. E’ un lavoro sulla memoria, sul recupero del ricordo,
delle rappresentazioni che la memoria ha conservato. Un tentativo di
tenere insieme la memoria con la storia (Baeri, 2005), che ha
suggerito, a livello metodologico, di preferire un itinerario di
auto-rappresentazione
delle donne intervistate. Non è stata quindi adottata una
griglia rigida d’intervista, ma si è lasciata la più
ampia libertà alle donne interpellate di raccontarsi.
La
presa di parola ha, in questo senso, molteplici significati. Per
molte donne intervistate la parola non è semplice descrizione
di avvenimenti o ricostruzione di un percorso individuale e
collettivo: è anche un continuo ribadire l’oralità
come interazione significativa nell’autocoscienza; spesso è
il racconto (solo apparentemente paradossale) di un silenzio
come “uscita” dall’universo simbolico maschile.
Alcune donne intervistate, infine, hanno deciso di scrivere
(o
riscrivere) la loro intervista, utilizzando la scrittura
come “risorsa” di verifica e di una trasmissione che
superi
l’immediatezza del ricordo. In questo caso, i contributi delle
intervistate si caratterizzano per una maggior identificazione
dell’interlocutrice all’interno dei gruppi di
riferimento, mentre le interviste in profondità hanno
maggiormente evidenziato la biografia personale, la soggettività,
le priorità e le scelte individuali (pur fortemente legate a
un’esigenza molto sentita di riconoscimento verso le altre
donne).
Le
fonti orali sono state, in questo caso, sollecitate da una
ricercatrice-intervistatrice. Il rapporto tra intervistate e
intervistatrice è in ogni caso complesso e ‘generativo’
di forme e contenuti particolari. In questo caso, il rapporto con
l’intervistatrice è stato caratterizzato dalla diversa
età anagrafica, che si è tradotta nella possibilità
di interpretare le fonti con uno sguardo situato e particolare: in
primo luogo la possibilità di leggere i materiali in maniera
‘intima’ (grazie alla conoscenza del dibattito teorico e
della storia del movimento femminista), ma allo stesso tempo
‘estranea’, in cui l’estraneità è
declinata come possibilità di distacco critico dalle relazioni
e dai contesti della ricerca.
Le
intervistate hanno offerto la loro testimonianza su temi specifici
(il lavoro, la partecipazione a lotte sociali e politiche, la
quotidianità, l’ambito privato) o narrato liberamente
spezzoni della loro storia di vita). Ogni testimonianza è
stata accompagnata e preparata da un contatto informale, e il
colloquio è sempre stato poco direttivo, sempre accompagnato
da domande che hanno lasciato spazio alla possibilità, per
l’intervistata, di stabilire le proprie priorità
(domande come “raccontami la tua vita”, “parlami di
te” o “raccontami i tuoi anni Settanta”).
La
trascrizione delle interviste è stata, il più possibile
letterale.
Questa scelta è legata alla necessità di non rendere
opaca e irriconoscibile la fonte orale; tuttavia, in un secondo
momento, si è scelto di sottoporre alle intervistate il testo
trascritto, per permettere una riflessione aggiuntiva: in questo
senso, le interviste sono diventate fonte primaria e, allo stesso
tempo, momento di riflessione e ri-definizione. Non a caso, le
ri-scritture non si sovrappongono mai al parlato, ma lo completano e
lo approfondiscono.
L’interpretazione
ha posto quindi l’accento sulla soggettività (sia
dell’intervistatrice che dell’intervistata), ma
necessariamente anche sulla loro interazione, permettendo di dare
valore all’aspetto qualitativo, individuale, di cogliere le
sfumature, le ambivalenze, le conflittualità, le scelte, i
‘successi’ e le ‘sconfitte’. Il largo spazio
dato alle soggettività ha indirizzato l’interpretazione
verso le modalità con cui ogni soggetto costruisce la sua
autopresentazione, comunica un’immagine di sé, (ri)
costruisce la propria esperienza e la racconta liberamente, con
alcune precise sollecitazioni. Nell’interazione che si crea
attraverso il dialogo, il racconto si carica di senso, e la memoria
ritrova e ricostruisce il ricordo nel momento stesso in cui avviene
l’intervista.
Nella
ricerca, e nel lavoro di interpretazione dei testi
a disposizione, si è scelto di mantenere questi molteplici
livelli di interazione.
Una questione metodologica
aperta, all’inizio della ricerca, si è rivelata la
definizione di “movimento delle donne”, stante la
differenza fra soggetti, culture e movimenti in cui si è
espressa la soggettività femminile negli anni oggetto
d’indagine. Secondo Guerra «”Femminismo”
comprende un’accezione più vasta rispetto a ‘movimento
delle donne’ o all’espressione anglosassone “women’s
liberation movement” […] Con il termine femminismo
intendo riferirmi ad un corpus complesso di teorie e di pratiche che
attraversa gran parte degli ultimi due secoli e che negli anni
Sessanta e Settanta si è espresso nella forma visibile,
allargata e coinvolgente del movimento» (2005: 25).
Non tutte le donne
intervistate si definiscono femministe, né tantomeno alcuni
gruppi oggetto della ricerca sono riconducibili all’esperienza
storica dei movimenti neofemministi. Elemento in comune è,
tuttavia, l’attenzione verso l’autonomia e l’iniziativa
delle donne, la consapevolezza di una discriminazione e la ricerca di
strumenti per combatterla. Nel corso della trattazione, si preferirà
quindi definire i gruppi in oggetto come parte del movimento delle
donne, «quell’eterogeneo arcipelago sociale formato dai
soggetti che, nei partiti, nei sindacati, nel mondo del lavoro e
delle professioni, si impegnano in prima persona per trasformare l
relazioni di potere tra i generi» (Leccardi, 2005: 103).
In
ogni caso, l’intento di questa ricostruzione di esperienze non
vuole essere quello di tracciare un bilancio definitivo, ma di
suggerire ipotesi interpretative e di rileggere la “sfida”
posta dai movimenti delle donne alla luce del presente. Per questo
motivo, ampio spazio è lasciato alle parole delle
intervistate, che hanno ricostruito non solo gli aspetti
istituzionali della storia dei loro gruppi, ma hanno legato la loro
esperienza agli aspetti personali ed esistenziali. Un contributo che
non vuole essere solo Memoria, ma vuole utilizzarla per ritessere
trame e discorsi, perché oggi «c’è comunque
un grande silenzio: per tutto ciò che nelle vite, nei rapporti
con l’uomo e con le altre donne non si riesce più a
nominare, per paura di ulteriori divisioni, o per paura di perdere
anche le persone più vicine» (Melandri, 2004).
La
ricerca analizza quindi i percorsi dei singoli gruppi di donne in una
realtà territoriale periferica – la provincia di
Catanzaro
- ma diventa anche l’analisi dei percorsi di singole donne che
abitano questi gruppi (dagli anni Sessanta ad oggi), alcune con una
certa continuità, altre con interruzioni e ambivalenze. La
ricerca non è stata condotta in maniera sistematica su tutti
i
gruppi di donne che si sono formati in questi anni, ma dà
conto di tutte le aggregazioni ritenute sufficientemente
significative e quindi in grado di fornire indicazioni complessive.
L’elaborazione a posteriori delle intervistate contiene,
inevitabilmente, elementi di reinterpretazione del passato alla luce
delle esperienze presenti. Come ricorda Portelli (1979): «il
narratore di adesso è diverso da quello che era quando prese
parte agli avvenimenti narrati […] Spesso c’è
stata un’evoluzione nella sua coscienza soggettiva e nella sua
condizione materiale che lo porterà a modificare, se non il
suo racconto dei fatti, almeno il giudizio che ne dà e quindi
la forma del racconto. […] Una selezione a priori è già
stata compiuta dal ricercatore nel momento in cui ha scelto i temi
della ricerca e le persone da intervistare; e una selezione a
posteriori avverrà nel momento della pubblicazione. Perciò
la ricerca condotta con fonti orali ha sempre caratteri di parzialità
e lavoro in corso che la distinguono dalla ricerca storica come siamo
abituati a concepirla, col suo requisito ideale di consultare tutti
gli archivi, leggere tutte le pubblicazioni, esaurire la
documentazione»
Le
testimonianze sono spesso frammenti di discorso, dal quale emergono
modalità distinte che sono tuttavia riconducibili a due
modelli: il primo contrassegnato dal racconto, che non si traduce mai
in comunicazione urgente della propria esperienza individuale e
collettiva; il secondo risponde alle modalità di una
‘fruizione allargata’ della propria esperienza,
contraddistinta dalla consapevolezza di un percorso comune – ma
non identico - e dal riconoscimento reciproco attraverso esperienze
condivise e l’identificazione di comuni obiettivi. Questa
seconda modalità è caratteristica delle donne che hanno
condiviso il pensiero della differenza come comune matrice teorica, e
che quindi sottolineano con forza l’aspetto del riconoscimento,
dell’affidamento, dell’autorevolezza.
Le
interviste sono veri e propri spezzoni di biografie singole e
collettive, che ricostruiscono le amicizie, i conflitti, le
rivendicazioni, le festosità e le ombre, i progetti creativi
del movimento. Si può riconoscere, in molte interviste, un
filo conduttore, spesso rappresentato da un racconto autoesplorativo,
(soprattutto da parte delle donne che hanno vissuto l’esperienza
dei gruppi di autocoscienza) al quale si intreccia un racconto di
ricerca, che risponde ad un’esigenza conoscitiva, - legata ad
una descrizione per quanto possibile fedele del contesto – alla
necessità di continuare a formulare ipotesi, fare verifiche,
documentare e ‘spiegare’ (soprattutto ad una giovane
ricercatrice che non ha vissuto anagraficamente un particolare
momento storico). Poco presente appare, invece, un racconto di tipo
ideologico, che corrisponde all’esigenza del fare politica, sia
diffondendo la consapevolezza di un percorso, sia indicando un
itinerario politico. Il racconto raramente assume le forme della
mobilitazione e della ‘propaganda – anche del proprio
gruppo -, ma è intimamente legato alla rielaborazione della
memoria, alla necessità di comunicare per ricordare, per
allontanare la minaccia dell’oblio. In tutti i racconti prevale
l’ “ansia di lasciare traccia” (Rossi- Doria,
2005), il desiderio di (ri)tessere le trame di un discorso che non
vuole rimanere incompiuto, ma che, attraverso la suggestione
dell’esperienza biografica e collettiva, costruisca conoscenza
storica, spazi di ricerca ulteriori, continuità fra le
generazioni, perché «la memoria del femminismo, che pure
ha sedimentato ingenti patrimoni documentari in una straordinaria
vocazione conservativa, è tuttavia fragile ed è grande
il rischio di perdita, di cancellazione» (Bertilotti e
Scattigno, 2005).
In
che forme in cui si può trasmettere questa storia? Esiste una
trasmissione tra donne, anche di diverse generazioni, di esperienze e
di uno specifico sapere e pratica femminile?. Cosa lega dal punto di
vista dell’esperienza femminista la donna adulta alla donna
giovane, la madre alla figlia, le insegnanti alle allieve?
Le
difficoltà della trasmissione generazionale sono condizionate,
e allo stesso tempo producono, il silenzio. Un silenzio che a volte
diventa reticenza. Scrive Lea Melandri: «Ma se è calata
sul primo femminismo una dimenticanza così tenace è
perché la scrittura e la memoria del singolo […] hanno
incontrato da subito le spinte opposte di una “generalizzazione”
che subordinava a criteri di “universalità” e
“appartenenza” la materia concreta di cui è fatta
ogni vita» (1997: 8). E ancora Maria Luisa Boccia: «Abbiamo
desiderato, amato, detestato, subito e agito attraversando
ambivalenze e ricchezza di uno scambio tra individuale e collettivo
che ha costituito la cifra peculiare di un vissuto denso di politica.
È difficile, per non dire impossibile, tradurre questa densità
in un bilancio trasparente e lineare; molto più semplice è
congedarsi, come si addice al tempo della giovinezza»(2003:
253):
Io
non ho un rapporto con le ventenni, non so come si collocano;
naturalmente hanno una vita molto diversa da quella che abbiamo
vissuto noi, in cui noi abbiamo lavorato e operato. Tuttavia continuo
a pensare che c'è una subalternità ai maschi molto
forte; non so se se ne accorgono, se ne sono consapevoli. Non vedo il
delinearsi di un'organizzazione propria della donna, cioè,
vedo una sciatteria delle donne, magari disposte a utilizzare gli
uomini, che però non lavorano sull'accrescimento della propria
dignità, della propria autonomia, della propria consapevolezza
di soggetto compiuto, completo, capace di misurarsi ad alto livello
(Annamaria Longo)
Quello
che posso dirti di Lamezia, ma posso parlare a livello personale, è
che ho molto il dispiacere del silenzio in cui siamo oggi come
movimento, come donne. Per altri versi credo che anche nella realtà
lametina siano esperienze passate all'interno della società,
perché sono state molto visibili. Se tu parli con le persone
(magari non quelle giovanissime), sono state esperienze molto
visibili, soprattutto l'UDI e il Centro Lilith, mentre il gruppo
femminista è stata una cosa molto fra le pareti domestiche,
non ha avuto un grande impatto all'esterno. Hanno inciso, è
avvenuto qualcosa sicuramente. C'è anche una nostalgia...se
incontro le persone di allora c'è proprio una nostalgia dei
momenti dello stare insieme; c'è quasi una domanda, un
chiedersi perché non facciamo qualche altra cosa insieme.
Questo è quello che percepisco e comunque la mia riflessione
adesso è sul silenzio, che non so fino a che punto sia giusto
che rimanga così, perché è un silenzio che forse
dovrebbe essere rotto, perché bisogna sempre tenerla viva
l'attenzione, perché altrimenti corriamo il rischio come
società di regredire, non solo come donne. Quello che abbiamo
conquistato non è reversibile: sono cose acquisite e spero
anche le generazioni delle nostre figlie, che adesso hanno venti
anni. Però il silenzio potrebbe essere rotto, a partire da sé,
individualmente, non so bene come, però sento che sarebbe
opportuno ricominciare a parlare (Loredana Rubino).
Un’ulteriore
difficoltà deriva dalla difficile collocazione, per molte
donne, nei ruoli contemporanei di testimoni e narratrici: la
difficoltà, quindi, di separare il soggetto dall’oggetto
della ricerca (Passerini, 1988). Ci sono donne che non vogliono
essere rappresentate dal femminismo, e donne che, se nel femminismo
riconoscono una teoria e prassi ineludibile, si discostano da
narrazioni e teorizzazioni onnicomprensive e totalizzanti. Le
narrazioni difficilmente mettono a tema il significato
soggettivamente attribuito al termine ‘femminismo’.
Argomento cruciale ma sottaciuto, probabilmente per la difficoltà
di distanziarsi soggettivamente dalla propria esperienza concreta.
Una difficoltà sicuramente alimentata dalla evidenza di un
pensiero femminista plurale ed eterogeneo, contrassegnato da
discontinuità e temporalità diverse, variamente
interpretato se considerato nel contesto dei movimenti collettivi o
letto sul filo della dimensione e iniziativa pubblica delle donne.
Ma
fra i silenzi e le difficoltà di descrivere, nelle narrazioni
emergono in maniera evidente le parole:
parole che esprimono e descrivono un mondo nuovo che le donne
scoprono e cambiano, modalità innovative ed esaltanti che si
realizzavano nel quotidiano, nella concreta attuazione del “personale
è politico”, la scoperta del sé che
miracolosamente convive con la costruzione di un soggetto collettivo.
E’ «l’innamoramento collettivo di cui parlano tante
testimonianze» (Passerini, 1991: 146).
Quali
sono quindi le diversità e le somiglianze fra i gruppi dagli
anni ’60 fino ad oggi? Quali sono i rapporti, gli intrecci, le
distanze esistenti tra i vari gruppi? Quali gli obiettivi e le
strategie in questi anni?
Desiderio
e scelta: i luoghi delle donne
Quello
che io mi ricordo, assolutamente, è questa presenza diffusa
nei paesi di donne che comunque erano state coinvolte...piccoli
gruppi che si trovavano, discutevano, perché poi spesso
arrivavano a Catanzaro persone... perché il femminismo in
Calabria, sicuramente negli anni Ottanta, è stato diffusissimo
ovunque, gruppi di donne che facevano qualcosa c'erano ovunque, una
quantità 'industriale' di gruppi di donne! (Donatella
Barazzetti)
Diversamente
da altre parti d’Italia, dove le donne provenienti dai gruppi
della sinistra (tradizionale ed extraparlamentare) rappresentano una
seconda generazione di femministe, che sbilanciano il movimento verso
l’intervento sociale e politico e le manifestazioni in piazza
(Calabrò e Grasso, 1985), in Calabria sono le donne della
sinistra che raccolgono le idee e le suggestioni teoriche provenienti
da altri luoghi d’Italia per ritrovare in esse contraddizioni
con le loro pratiche politiche tradizionali e la loro stessa
collocazione nel mondo. La parabola dell’UDI, come vedremo, è
significativa a questo proposito. Con la metà degli anni
Settanta si realizza anche in provincia di Catanzaro un’evidente
espansione del movimento delle donne: un’affermazione pubblica
di massa e, allo stesso tempo, lo sviluppo di un grande impegno
teorico e culturale. Le donne intervistate, nel periodo a cavallo fra
gli anni Sessanta e Settanta, hanno un’età media che si
aggira intorno ai trent’anni, sono nella maggior parte dei casi
insegnanti, professioniste, studentesse, un livello culturale
medio-alto, provengono da esperienze di militanza politica
nell’ambito della sinistra tradizionale o extra-parlamentare.
Le
idee e le pratiche che i gruppi territoriali vivono e mettono in atto
sono simili a quelle che si muovono sul terreno nazionale: la critica
del confine fra pubblico e privato; la scoperta del proprio corpo e
della propria sessualità, la messa in discussione delle
istituzioni tradizionali; la consapevolezza della differenza (e delle
differenze) di genere, che prende il sopravvento sull’appartenenza
di classe. Emerge un nuovo linguaggio, pragmatico e personale allo
stesso tempo, che coinvolge ogni singola biografia femminile in un
contesto sociale più ampio.
Anche
fra le intervistate è possibile rileggere le differenti
modalità di pensiero e pratiche che attraversano i gruppi
nazionali: il pensiero moderato ed emancipazionista, che non mette in
discussione la divisione dei ruoli e l’assetto economico, ma
attribuisce l’esclusione delle donne a un pensiero dominante,
culturale, sul quale agire per permettere l’ingresso femminile
nel contesto produttivo e politico; il pensiero marxista, che vede
nella rivoluzione di classe la possibilità per tutti, donne e
uomini, di liberarsi dallo sfruttamento del sistema economico:
Sentivo
molto forte il richiamo delle idee socialiste e comuniste,
l’aspirazione alla giustizia sociale; credevo moltissimo in
questo, nel fatto che le persone dovessero avere dignità
attraverso il proprio lavoro, tutto il discorso sui diritti per
uomini e per donne, e all’interno di tutto questo ho sempre
pensato che il fatto che ci fossero le donne, con la loro
soggettività, avrebbe aiutato anche il processo di
trasformazione. Ho sempre ragionato legando insieme le due cose, pur
sapendo, non solo per acquisizione personale, ma anche da studi,
dalle relazioni che avevo in quel periodo, che non vi era automatismo
fra socialismo e liberazione delle donne. Ero comunque convinta
allora (ma ne sono convinta anche ora) che le idee di sinistra
(socialiste e libertarie) fossero più confacenti ad un
discorso di liberazione delle donne, contro un sistema patriarcale
che comunque vedevo molto legato all’organizzazione
capitalistica, anche se probabilmente non era soltanto questo (Rosa
Tavella)
Il
desiderio, il progetto, la possibilità della scelta, compaiono
sempre in primo piano nella narrazione delle intervistate. E’
il rapporto con la maternità, il nuovo rapporto con se stesse
e con l’uomo che diventa oggetto di analisi e discussione; è
la necessità urgente di affermare la possibilità della
donna di scegliere che fare del proprio corpo; l’autodeterminazione
e la scoperta di nuovi scenari. I rapporti fra donne vengono
ripensati nell’ottica di un coinvolgimento immediato e
personale, mentre la politica tradizionale è stravolta da
modalità nuove di partecipazione.
Quello
che motiva in modo significativo la costituzione di un movimento
femminista, e che coinvolge tutti i gruppi di donne che transitano da
una prospettiva emancipazionista alla dimensione della liberazione, è
la prospettiva di una redifinizione completa di alcuni concetti: la
famiglia (soprattutto il rapporto tra l’uomo e la donna), il
corpo (la richiesta di una maggiore emancipazione e il diritto alla
contraccezione), la messa in discussione del modo di fare politica:
L'idea
che posso desiderare qualcosa di diverso, o comunque sostenere questo
desiderio... Io avevo una fragilità di desiderio, o perlomeno
facevo una distinzione fra quello che potevo e che non potevo, quello
che mi era consentito e quello che no. E quindi spesso mollavo,
perché in fondo – anche se non era stato questo
l'insegnamento di mia madre – però l'idea era quella
sociale, era quella che come donna era più facile cedere, che
per me era scritto che dovessi cedere. Quindi questa idea del
desiderio per me era un grosso problema, che non sapevo nemmeno che
fosse un problema. Poi mi sono accorta a quante cose avessi
rinunciato; e l'idea che altre potessero sostenermi, anche non
essendo d'accordo – perché alcune non erano
d'accordo...quando sono d'accordo è più facile. Quando
non erano d'accordo, il tipo di sostegno che ho avuto è stato
quello di dire: “Questo non è il mio desiderio, però
mi pare bello per te”. Questa considerazione è stata
importantissima (Fulvia
Geracioti)
Eravamo
tutte, madri e non, giovani e meno giovani completamente impreparate
ad affrontare il tema della sessualità perché il
nostro corpo ci era sconosciuto e così la nostra sessualità.
Tutto ci avevano insegnato e tutto avevamo imparato, e, tra le cose
che ci avevano insegnato, c’era quella che il nostro corpo era
vergogna e offesa per la collettività; era quindi da
nascondere e i suoi istinti (emozioni diremmo oggi) da reprimere
(Assunta Di Cunzolo)
Nei
movimenti e nelle organizzazioni molte donne hanno trovato maggiori
possibilità di esprimersi, ma anche di sperimentare in prima
persona le asimmetrie di potere, i conflitti, la persistente
dimensione del patriarcato. Il movimento femminista in senso stretto
rappresenta solo una delle forme e delle articolazioni del movimento
delle donne, che vive in un reticolo diffuso di centri, librerie,
case delle donne, riviste. Ne nasce una periodizzazione che porta la
vicenda del femminismo contemporaneo oltre il passaggio degli anni
Settanta, nel cuore degli anni Ottanta e del “femminismo
diffuso” e che legge il movimento delle donne come espressione
sul piano politico della soggettività femminile (Calabrò
e Grasso, 1985).
Nei
decenni precedenti gli anni Settanta, l’Italia presentava due
organizzazioni femminili di massa, l’UDI e il CIF, che erano
diffuse su tutto il territorio nazionale ed agivano come cerniera fra
la partecipazione alla politica istituzionale dei partiti (PCI e
Democrazia Cristiana) e l’attività sociale,
privilegiando quest’ultima, in particolare, rispetto alla presa
di coscienza individuale. Alla fine degli anni Settanta, i due grandi
partiti di massa del secondo dopoguerra, sono accomunati dal comune
spiazzamento nei confronti di un soggetto politico emergente, dalla
sorpresa di fronte alle battaglie referendarie e al loro esito, dalla
visione tradizionale dei ruoli di genere. Nell’esperienza dei
partiti di massa, in questi anni, l’accento è posto
sulla società, sede della subordinazione femminile: è
in questo terreno (e non in quello del rapporto fra i sessi) che
devono avvenire i cambiamenti economici, sociali, culturali. La forte
affermazione dell’importanza della presenza delle donne in
altri ambiti politici e ideologici, malgrado una persistente
difficoltà legata all’assenza nei luoghi della
decisione, caratterizza, ad esempio, la narrazione di un’intervistata
che legge in un’ottica di genere la sua esperienza all’interno
della Democrazia Cristiana, concentrandosi sulla relazione politica
fra una oligarchia politica maschile e una pressione femminile sempre
più determinata e consapevole:
Quindi
iniziò questo lavoro di aggregazione, di chiamata, e cominciò
a costituirsi questo movimento femminile di donne della Democrazia
Cristiana, secondo me di qualità, per la presenza di alcune.
Era, in un certo senso, un movimento elitario, perché nella
DC, come del resto nel PCI, c'erano molti iscritti, ma poche
militanti. Le iscritte erano quelle che servivano per i congressi;
allora le donne iscritte erano – come si diceva all'epoca –
le mogli, le figlie, le nipoti, tutte la donne di casa, perché
poi nei congressi quelli che rappresentavano questi pacchetti
naturalmente avevano grandi opportunità per la lotta interna,
che non era roba di poco conto. (Clara Sanginiti)
Anche
sul versante più tradizionale dei gruppi appare forte
l’attenzione verso la questione dell’uguaglianza
femminile, soprattutto rispetto ai problemi in ambito lavorativo.
Quello che non viene recuperato è il terreno della libertà
personale:
Bisogna
riandare alla fondatrice [della FIDAPA], Lena Madesin Phillips,
un'americana che si inserisce nel movimento del femminismo. Lei era
un'avvocato in America che, invece di fare la suffragetta e
partecipare a quelle che furono le manifestazioni – a mio
parere – scomposte...anche qui in Calabria alcune
con le ragazze giravano sventolando – forse lei non se lo
ricorda – il reggiseno, facevano gesti poco eleganti per una
donna, per una signora (non in senso di ceto, ma di animo). Questo
avvocato in America si assunse il compito di approntare, di
costituire questa associazione per affrontare, sostenere
l'inserimento delle donne.[…] La Fidapa ha sempre interpretato
il suo Statuto in modo pacato; certo non è un'associazione con
gli occhi bendati e conservatrici, perché è stata
istituita dal movimento delle femministe, ma con una impostazione del
tutto diversa da quella delle suffragette. La Federazione non ha
spirito di parte, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di
razza, lingua e religione. Si propone di sostenere le iniziative
delle donne, elevando il livello della cultura e della qualificazione
delle donne, risvegliando il senso della loro responsabilità
verso il proprio paese e verso la società. Si adopera per
rimuovere le discriminazioni che ancora sussistono a sfavore delle
donne, sia nell'ambito della famiglia che lavorativo. (Teresa
Barbieri???forse è Maddalena Barbieri)
Anche
l’UDI, pur nella difficoltà di affermare la propria
autonomia, cerca una propria elaborazione indipendente dai partiti di
riferimento, pur se la ‘questione femminile’ rimane in
secondo piano rispetto al problema centrale
della classe operaia???.
Nonostante questo approccio, l’UDI diventa un riferimento per
quanto riguarda i temi del diritto al lavoro delle donne e della
maternità. Gli anni Cinquanta e Sessanta sono gli anni
dell’impegno verso le donne della campagna (la ‘Tabella
Serpieri’) e l’abolizione del licenziamento delle donne
in caso di matrimonio, la vertenza degli asili nido e della scuola
materna, motivata dall’esigenza di permettere alle donne
lavoratrici di conciliare il lavoro con la famiglia:
La
battaglia più grossa noi l'abbiamo fatta nel 1951, quando c'è
stata l'alluvione e hanno cominciato a fare una strada che collega
Badolato con le Serre, e allora gli operai tagliavano gli alberi nei
terreni dei più ricchi, e la polizia veniva a bloccare questo.
Noi da ragazzi...le donne più grandi occupavano le strade, noi
più piccole andavamo in cerca di qualcosa da mangiare per gli
operai nel paese. Ti sentivi partecipe alla lotta. poi il momento
cruciale per me personalmente è stato...perché allora
c'era la Legge Gullo, che portava il miglioramento nella mezzadria.
Le raccoglitrici di olive si sentivano più protette, anche i
contadini – che prima non prendevano niente dai terreni –
cominciavano ad avere il loro frutto, la loro partecipazione, la loro
parte degli ulivi; la misura che prima veniva piena del frumento che
loro raccoglievano e dovevano pagare al padrone...hanno fatto un
legno che dava la misura giusta, e quindi ogni dieci misure gliene
veniva una fuori. Vedevano queste cose qua […] Io mi ricordo
che facevamo le battaglie per l'asilo, per la scuola materna. Siamo
andate alla Regione e mi dicevano: “Guardate, sono venuti i
vostri compagni di Modena, di Reggio Emilia e di Bologna per
espandere e migliorare i loro asili. Noi non abbiamo soldi, a noi non
ci mandano soldi per fare gli asili qua”; “E voi che voce
avete quando andate a Roma, se non vi imponete per quello che
dobbiamo fare? Se voi vi date da fare...”. Allora sono cambiate
delle cose, perché la scuola a tempo pieno a Badolato è
stata fatta la seconda dopo...prima si è fatta a San Giovanni
in Fiore. Io, personalmente, quando mio marito era sindaco, mi sono
bisticciata con lui, perché sono andata a prendere i documenti
a Cosenza e a San Giovanni; li ho portati qua e li ho costretti con
la forza a far approvare, nel Consiglio comunale, l'apertura della
scuola a tempo pieno. Dicevano: “Con i tempi forse non ci
riusciamo”, ma se mai cominciamo! E allora era la seconda in
Calabria, dopo Badolato l'hanno fatto dappertutto. Perché?
Perché erano le donne che si interessavano a fare queste cose,
e grazie ad Annamaria [Longo] – perché lei, essendo
professoressa, recepiva di più, preparava documenti e noi
andavamo...Loro davano l'intellettualità e noi eravamo la
forza. E' stato molto importante questo, perché le
intellettuali dei paesi si sentivano più grandi e non
contribuivano alle nostre lotte. Non hanno mai contribuito,
pochissime sono state quelle che hanno appoggiato le lotte che
abbiamo fatto, perché ci trovavamo di fronte...Poi, dopo
fatte, tutti accettavano. [Le battaglia più importanti sono
state] sull'emancipazione, il diritto di essere donna. Perché
di qua tu riesci a scatenare tutto quello che intorno puoi
capovolgere. E soprattutto la cultura, perché se non c'è
cultura non c'è niente; perché la cultura ti fa
confrontare con gli altri. Perciò ho combattuto di più
per le scuole, per il diritto allo studio (Rina Trovato)
In
questi anni l’UDI e il CIF si muovono quindi sul terreno della
vita pubblica, con la conseguenza di sottovalutare i segni del
malessere femminile, che si annidavano soprattutto nel privato. Gli
anni Settanta impongono una netta cesura con il passato: nelle
politiche dei movimenti tradizionali vi è un’equiparazione
completa della donna all’uomo (e quindi la richiesta di leggi
per la parità), il femminismo che si afferma in questi anni
sostiene l’alterità fra uomo e donna, nega la neutralità
del sesso maschile come parametro cui adeguarsi, afferma l’esistenza
di due generi distinti, ognuno con una propria identità:
Eravamo
un gruppo di donne abbastanza attente a quello che succedeva nel
sociale, e quindi avvicinarsi all'UDI è stata una cosa
naturale, perché l'UDI a Catanzaro è stata fondata poco
prima che io entrassi, quasi in contemporanea (nel 1970 o 1972, non
ricordo bene), e quindi avere un luogo in cui alcune donne si
potevano incontrare, che non fosse di carattere politico-partitico,
ma di carattere politico-sociale, per noi è stata una
conquista; un luogo in cui potere esprimere ciò che pensavamo
e soprattutto allora c'era una sorta di delirio di onnipotenza,
pensavamo di poter cambiare il mondo, anche soltanto enunciando la
cosa. Poi ci siamo accorte che non era così nel corso degli
anni; comunque, la nostra parte l'abbiamo fatta lo stesso, e siamo
state iperattive in tutte le battaglie sui diritti civili che
riguardavano le donne, dal divorzio all'aborto; qui a Catanzaro poi
sugli asili nido, le scuole materne, i consultori, tutto quello che
era l'orizzonte delle donne. […] Io sono prima entrata
nell’UDI e poi nel partito: ho fatto il percorso contrario. E
quindi noi abbiamo sviluppato tutta una serie di iniziative, di
lavori, soprattutto dal punto di vista culturale; io credo che noi
abbiamo lavorato, oltre a tutto quello che riguardava i diritti
civili, e anche le conquiste che riguardavano le donne dal punto di
vista istituzionale, noi abbiamo fatto un’operazione proprio di
carattere culturale in quegli anni, promuovendo una serie di
convegni, soprattutto su quelle che sono state le femminista ante
litteram, anche se allora nessuno sapeva che potessero essere
connotate così, tipo Rosa Luxemburg, ecc.; abbiamo fatto
seminari e ogni volta che facevamo queste iniziative, oltre alle
nostre associate, che comunque erano assidue frequentatrici della
nostra sede, avevamo proprio tutta la città che veniva a
prendere parte (Adriana Papaleo)
Io
ho cominciato a guardare qualche opuscoletto di campagna elettorale,
del PCI probabilmente, perché circolava in classe, e quindi
ero comunque attenta. Stavo un po’ stretta nel ruolo della
brava ragazza, della brava studentessa, ero pronta in qualche
modo...queste cose le avverti. Poi il mio ragazzo mi disse che c'era
questa donna, questa architetta, che organizzava una riunione con
delle donne. Andai alla prima riunione addirittura. Mi piacque subito
il discorso. Comunque c'era materiale, c'erano cose da guardare, da
leggere. Poi l'UDI a Lamezia ha avuto un'organizzazione e un impulso
straordinari, perché sostanzialmente si sono organizzati dei
circoli, c'era proprio una rete organizzativa. Questo è stato
importante, ma è stato molto importante lo stare insieme tra
donne di generazioni diverse, di estrazione sociale diverse. Tu
immagina: la studentessa con la bracciante del quartiere popolare, e
insieme a leggere Noi Donne, che è stata una rivista
importantissima, di rottura all'epoca. Io diffondevo le copie di Noi
Donne a scuola, abbiamo fatto un sacco di incontri, molti con questo
taglio sociale, dei quartieri popolari nuovi che venivano costruiti a
Lamezia, e lì la battaglia per la luce, per i servizi
pubblici, quindi c'era molto questo taglio sociale. Però,
accanto a questo, c'era anche la riflessione sull'essere donna.
Organizzammo una mostra, delle diapositive, in cui si evidenziava
l'immagine femminile sulla stampa; e poi c'erano le immagini che
uscivano fuori dalle riviste patinate, quelle dell'epoca, raffrontate
con l'immagine delle donne nostre, calabresi. Quindi tutto un lavoro
di controinformazione non indifferente. Poi erano gli anni della
battaglia sull'aborto e sul divorzio, quindi tematiche scottanti,
fortissime, però devo dire che le donne rispondevano in massa,
nel senso che si faceva un lavoro all'epoca che oggi nessuno più
si mette a fare. Io il pomeriggio, alle due e mezzo, partivo da casa
mia e me ne andavo in questi quartieri, anche un po’ distanti,
e con le ragazze del quartiere andavo a fare caseggiato; il lavoro
proprio porta a porta, entrando nelle case, parlando con le donne
dell'aborto, di quello che significava, della propria libertà,
dei mariti, dei figli; per arrivare poi a organizzare l'assemblea nel
magazzino, nel quartiere, quindi tutta una rete di rapporti. E' stata
un'esperienza importantissima, anche se è da collocare molto
in quel periodo storico, perché ancora il pensiero sulle
tematiche femminili era quello: era un discorso paritario,
emancipatorio, organizzativo, sul modello delle organizzazioni
politiche, del sindacato, del partito. (Loredana Rubino)
Nel
Partito io vivevo questo tipo di disagio, che vivevano tantissime
persone, un senso di inadeguatezza totale, di incapacità di
cogliere il linguaggio dei partiti, della politica, quegli incontri
politici che duravano delle ore interminabili, in cui tutti avevano
tantissime cose da dire e non dicevano niente. Partivano tutti con:
“Condivido il discorso del relatore…” e si partiva
dalla Cina, si arrivava alla Russia, si passava da tutto il mondo,
però poi i bisogni quotidiani della gente, le necessità,
le difficoltà…nessuno ne parlava mai. Era una cosa
incredibile. Per cui ti sentivi inadeguata perché se tu non
riuscivi ad entrare nel meccanismo di quel linguaggio lì, non
riuscivi mai a prendere la parola. Io pensavo che i miei problemi
quotidiani, quelli che avevo sul lavoro, il disagio dei malati, il
sovraffollamento dell’ospedale (spesso dovevamo legare due
panche perché non c’erano letti, ci mancavano molte
volte le lenzuola), queste cose qui…non riguardavano la
politica, ma riguardavano il quotidiano che non interessava a questa
grande politica. Io credo di essere arrivata al femminismo tramite la
conoscenza di Donatella. Credo che lei sia stata la persona che ci ha
coinvolto in qualche modo, perché non riesco a trovare il
momento in cui ho incontrato questo gruppo di donne, tutte più
giovani, io ero la più grande…Donatella, Amelia, Isa,
Paola Garofano,
Annamaria Casalinuovo, Licia ecc….le ho trovate, ci siamo
trovate, ed è come se ci fossimo conosciute da sempre. Mi
sembra che abbiano sempre fatto parte un pochino della mia vita qui a
Catanzaro, forse perché le vedevo alle riunioni, agli
incontri, alle feste dell’Unità […] Quindi mi
sono trovata in mezzo e mi ricordo che fu una cosa straordinaria,
come per tante altre donne, la scoperta…Guarda, io non so
quale fu la cosa più importante, perché ce ne sono
state tante che quegli incontri ci hanno dato…la scoperta
della nostra sessualità, la scoperta del confronto con le
donne, anche con quello che hanno vissuto le nostre madri, come
avevano vissuto la sessualità, condizionata da tanti fattori
(la Chiesa, il peccato), e anche quando noi abbiamo cercato la
libertà la vivevamo sempre con un senso di colpa. E poi il
confronto, il piacere di stare insieme alle donne, raccontare le
nostre vite e le nostre storie e di trovare dei punti di confronto
interessantissimi; e poi questa unione di donne che venivano da ceti
sociali completamente diversi. C’era il gruppo di persone che
venivano da ceti privilegiati, ragazze delle famiglie bene della
città, e anche ragazze che venivano dai quartieri più
lontani. E allora c’era proprio questa sorellanza che ci univa
e poi questa consapevolezza, oserei dire, che è stata
illuminante, che anche le cose…la quotidianità aveva un
valore enorme. Questo credere in te stessa, lasciare alle spalle quei
complessi d’inferiorità che molte volte ti avevano
tenuta lontana perché non avevi niente da dire. Invece, la
scoperta che tante cose ci riguardavano, ed avevano un valore
immenso, ed erano proprio le cose del quotidiano, le difficoltà,
i disagi ecc. Quindi è stata una scoperta di tante cose che
abbiamo messo insieme (Lorenza Rozzi)
Cosa
accade nella provincia di Catanzaro in questi anni? Si struttura la
pratica del piccolo gruppo di autocoscienza, si configura la ‘doppia
militanza’ di molte donne impegnate nella sinistra
istituzionale, si raggiungono strati della popolazione femminile che
fino a quel momento erano rimasti estranei, si consolidano i rapporti
politici fra le donne, pur attraverso duri contrasti fra gruppi, si
aprono luoghi autonomi di socialità femminile, si dà
vita al confronto con le istituzioni sui temi del diritto di
famiglia, del controllo delle nascite, dell’aborto, della
violenza. I gruppi del femminismo radicale si affermano in un momento
successivo, in particolare quando si chiude l’esperienza della
doppia militanza, per dare vita a forme organizzate autonome
politicamente. Convegni, incontri, manifestazioni. Dibattiti sulle
nuove leggi: legalizzazione dell’aborto, costituzione dei
consultori, la legge sulla violenza sessuale. Argomenti che
coinvolgono in modo concreto e immediato tantissime donne, dando loro
la sensazione di poter realmente agire per cambiare la loro vita e la
società in cui vivono. Mentre si intensifica la riflessione
teorica, si sviluppa il confronto con le istituzioni e l’impegno
sul fronte legislativo. La mappa dei gruppi si moltiplica, emergono
esperienze non riconducibili alle pratiche del femminismo storico, si
formano gruppi che si orientano verso i temi del lavoro e delle pari
opportunità, altri che svolgono attività legate alla
diffusione dei saperi femminili, ancora altri gruppi di sole donne
che svolgono prevalentemente lavoro su se stesse. Il rapporto con le
istituzioni, pur nella diversità delle esperienze e dei
momenti storici, emerge sempre come contraddittorio. Da una parte
l’analisi femminista pone al centro del discorso la
consapevolezza di sé, la soggettività, la relazione con
le altre donne; dall’altra le istituzioni sono caratterizzate
da una resistenza nei confronti del mutamento e da un approccio
‘universalistico’ che deve essere perseguito con apposite
strategie e modalità preordinate. E’ un incessante ‘fare
i conti’ con la lingua degli uomini (Ergas, 1977). Nel rapporto
con le istituzioni si ottengono visibilità e risultati, che
tuttavia, sembrano mettere in crisi i gruppi, provocando divisioni e
conflitti.
Le
narrazioni delle intervistate ci accompagnano lungo questo percorso.
Nei
capitoli precedenti è stato possibile rievocare il periodo nel
quale un gruppo di giovani donne di Catanzaro ha fondato il
“Collettivo di Via Case Arse” aprendo il primo ed unico
consultorio autogestito della città. Lorenza Rozzi, Graziosa
Costa, Isolina Mantelli, Maria Antonietta Carrozza, Amelia Morica,
Anna Maria Casalinuovo, Elisa Scarfone, Rosanna Marafioti, Donatella
Barazzetti sono solo una rappresentanza delle decine e decine di
donne che in quegli anni hanno lavorato, discusso, o anche solo
sostato nella sede del collettivo. Incontri, discussioni, soprattutto
sedute di autocoscienza. Nel Collettivo, e soprattutto nelle
discussioni per il consultorio e sul consultorio emerge il problema
della gestione della salute e della sessualità, e compare
immediata l’esigenza di cominciare a parlare di sé. Si
formano gruppi di autocoscienza (un testo di riferimento per le
questioni della sessualità diventa Noi
ed il nostro corpo), si
passa all’esperienza
dell’autovisita, si rendono evidenti due anime che iniziano a
prendere direzioni diverse: l’intervento all’esterno e la
linea che aveva individuato nell’autoanalisi,
nell’autocoscienza, un punto fondamentale per iniziare un
processo di cambiamento. Nei gruppi di autocoscienza le donne possono
tradurre in parola le loro esperienze, le loro emozioni, la loro
soggettività e confrontare tutto questo con quello che altre
donne stavano sentendo e vivendo, comprendendo «la natura
politica di ciò che è sempre stato definito personale»
(Koedt, Levine e Rapone, 1973: 8). Il raccontarsi, il parlare di sé,
il parlare della propria sessualità, della contraccezione,
delle relazioni con il partner (non come problema generale o teorico,
ma attraverso il racconto della nostra vita reale) scatena
contraddizioni e disagio. Il raccontarsi funziona come
rispecchiamento, consente la coscienza di sé, rappresenta
l’impressione di (ri)nascere e scatena conflitti. Questa
oralità, descritta a volte come “analisi selvaggia”,
è presto riconosciuta come una pratica dal forte potere
eversivo, capace di dare senso alla storia ma difficile da gestire.
Nei gruppi si parla, spesso si urla, si piange, si litiga, ogni tanto
qualcuna sbatte la porta. Tutte rivelano una grande rabbia interiore.
Raccontandosi rivelano un’intima insoddisfazione, toccano il
dolore delle altre e il proprio in modo talmente intenso da essere
costrette a scegliere: andare avanti o fermarsi.
Come
Collettivo abbiamo fatto dei tentativi di piccolo gruppo, mi ricordo
dei devastanti tentativi, in cui si discuteva fra di noi di tutta una
serie di cose, però ci siamo anche avventurate su terreni che,
non controllandoli, hanno prodotto dei disastri. La gente raccontava
di sé, e andava in tilt, perché il problema era che non
avevi gli strumenti, mentre finalmente tiravi fuori tutto quello che
era...sulla sessualità per esempio...questo più a Roma
però...il problema però era di scoprire che, non so,
essere frigide, avere certi problemi, non era un problema singolo, ma
era un problema collettivo, che poteva esserci una sessualità
diversa da quella che avevamo sempre conosciuto, perché
scoprire che quella sessualità non era quella tua (Carla
Lonzi, donna vaginale e donna clitoridea, per intenderci), scoprire
che ci potevano essere delle modalità diverse, cosa che
secondo me poi nessuno è riuscito a teorizzare veramente fino
in fondo, però era l'idea di essere state, in qualche modo,
prese in giro dalla storia. E scoprire che certe cose, che tu pensavi
fossero i tuoi limiti, erano invece certe cose che appartenevano a
tutte le altre, questo è stato straordinario. Però il
problema era che era difficile dare una risposta, al di là del
raccontarsi, anche perché poi su questo raccontarsi le
persone...generano anche delle reazioni di resistenza nelle altre
persone, se non ci sono strumenti, conflitti forti...che poi abbiamo
anche lasciato perdere, quando ci siamo rese conto che per qualcuno
poteva essere troppo devastante, fare una sorta di analisi senza che
poi qualcuno riuscisse a restituirti un equilibrio. Però
sicuramente l'idea che c'era una differenza, l'idea che
nell'organizzazione noi avessimo subito per anni tutta una serie di
cose...non solo per essere secondarie rispetto alle strutture
dell'organizzazione, ma proprio come considerazione, è stato
qualcosa di molto violento, molto coinvolgente. Poi noi ci siamo
soprattutto orientate al fare, più che al pensare, anche se
anche al nostro interno c'era questa separazione, come c'è
stata in tutto il movimento femminista, tra le donne che ritenevano
che il vero problema era riflettere su di sé e quelle che
dicevano che il vero problema era trasformare il mondo, questo del
dentro/fuori è stato uno dei nodi cruciali di conflitto
(Donatella Barazzetti)
Cominciavano
ad accendersi conflitti tra quelle che volevano l’impegno sui
servizi e quelle, in genere le più giovani, che volevano
riunirsi in gruppi di autocoscienza; alcune avevano concluso gli
studi all’Università e tornavano definitivamente a casa
e probabilmente avevano già fatto parte di qualche gruppo
fuori dalla Calabria. Alcune sperimentarono per qualche tempo questa
forma di relazione ma io e altre ci sottraemmo. La battaglia per il
consultorio, per gli argomenti che comportava e per i divieti
condivisi che dissolveva con la condivisione di tutte noi, funzionò
per me come autorizzazione alla conoscenza del mio corpo che, prima,
anche dopo la maternità, non avevo mai intenzionalmente
osservato… non ci si specchiava nude, non si conosceva
l’anatomia del sesso, era un non detto su tutto quello che
riguardava corpo e sessualità: di tutto questo, mai parlato
con nessuno, mai neanche con l’amica del cuore ed era tutto
rimasto chiuso dentro, inespresso con vergogna e sofferenza. No, non
potevo partecipare a queste riunioni, non sarei stata capace di
sopportarne la sofferenza, ancora più se condivisa (Assunta Di
Cunzolo)
Di
quelle riunioni ho un ricordo più visivo, di voci, che non dei
contenuti. C'era un grande protagonismo, ma anche forse una grande
confusione. Non vi era forte ancora una consapevolezza di un
pensiero; c'erano questi corpi, queste vite che si incontravano, si
parlavano, ma che ancora non avevano un'elaborazione (non dico
compiuta, perché compiuta non si ha mai) però definita
(Rosa Tavella)
La pratica dell’autocoscienza
trasforma la stessa casa, simbolo della tradizionale oppressione e
isolamento femminile, in uno spazio politico e di elaborazione della
propria soggettività. Risulta
tuttavia difficile, anche a distanza di anni, comunicare il senso e
la sostanza dell’autocoscienza, che diventa anche disagio,
incomprensione, solitudine. Soprattutto, è intraducibile
dalla sua stessa pratica.
Il percorso del Collettivo
evidenzia la grande contraddizione tra lavoro esterno e interno, tra
autocoscienza e pratiche indotte fuori. I due poli della
contraddizione si potrebbero definire la ricerca di sé, la
ricerca di una nuova identità femminile - individuale e
collettiva - altra rispetto alle definizioni della donna da parte
della cultura maschile, e l’affermazione dell’esistenza
sociale delle donne. E in seguito, è proprio la differenza fra
donne che non si riesce a gestire, soprattutto quando non si
caratterizzano come fertili diversità, ma come vere e proprie
disuguaglianze (ad esempio il possesso di strumenti culturali, che
l’appartenenza al gruppo non può facilmente eliminare):
Sai,
poi tra le donne c'è stata tantissimo questa dimensione del
problema del potere: siamo tutte uguali, siamo tutte dello stesso
gruppo, siamo tutte donne, poi il problema di chi parla meglio, di
chi è più intellettuale...i gruppi si sono spaccati per
questo...Da noi è successo questo (Donatella Barazzzetti)
Il
rapporto fra l’UDI e il Collettivo risalta nella sua
ambivalenza attraverso il ricordo delle protagoniste. Da un lato
descrizioni che, da entrambe le parti, sottolineano le difficoltà
di comunicazione, gli approcci diversi, se non l’ostilità
che hanno accompagnato i due gruppi:
Qui
c'era qualche gruppetto femminista; abbiamo cercato di avere qualche
incontro, ma c'era uno sbilanciamento, perché erano gruppetti
che non avevano una maturazione politica; erano gruppetti costruiti
su slogan, senza approfondimenti, con atteggiamenti non di apertura,
di riflessione di aggregazione, ma un po’ arroganti, poveri dal
punto di vista dell'elaborazione. Al contrario dell'UDI non c'era
stata in questi gruppetti, un'elaborazione culturale. Erano gruppetti
minimi comunque; noi tentammo di avere qualche rapporto, ma non era
stato felice l'incontro, restavano delle riserve. Anche perché,
su alcuni di questi gruppetti, c'erano elementi che non erano
elementi prettamente femministi; erano collegati ad altri gruppi
politici come Lotta Continua, Potere Operaio, e tentavano di
utilizzare questi gruppi femministi. Il discorso è molto
complicato: erano sedi dove c'erano state delle infiltrazioni, ed io
avvertivo questo, avevo colto questo elemento e quindi ero un po'
guardinga, nel senso che non ero disponibile (Annamaria Longo)
I
primi mesi del '74, in rotta di collisione con l'UDI, che era forte a
Catanzaro, Annamaria Longo, che era ancora su posizioni totalmente
legate alla questione femminile, il Partito Comunista, ci
consideravano...però noi eravamo un gruppo...eravamo militanti
politiche che avevano scoperto il femminismo, almeno in quelle che
erano le linee...cioè non avevamo niente a che vedere con le
femministe di origine radicale, con le femministe del tipo Tatafiore,
oppure con Carla Lonzi per intenderci, che avevano più un
problema di definire il femminile rispetto al maschile, e di dare un
fondamento teorico al problema della differenza [...] C'erano
stati rapporti, ma di conflitto, al limite del picchiarci quasi.
Perché loro comunque erano delle persone che ragionavano in
termini partitici. Prima veniva comunque una lealtà. Il
problema si poneva anche per noi, però era molto più
sfumato: il nostro non era un problema tanto di appartenenza a un
gruppo, ma di strategie di trasformazione del mondo. Bisogna fare o
pensare? Mentre, nel caso dell'UDI, il problema era di una doppia
lealtà, di un'appartenenza specifica che era quella partitica.
E se il partito dava certe indicazioni sull'aborto, su questo o
quell'altro, non c'era modo di schiodarle. Era proprio questa idea
che loro fossero in qualche modo subordinate a una dimensione...loro
ci odiavano, le femministe borghesi erano sostanzialmente contro la
lotta di classe, il soggetto della trasformazione non sono le donne.
[…] L'UDI si scioglie, e decide di riorganizzarsi
autoconvocandosi come movimento, che poi c'è tutto questo
passaggio nella seconda metà degli anni '80 di una parte molto
rilevante di intellettuali dell'UDI e del Partito Comunista al
pensiero della differenza (Reti, per esempio, Boccia, tutte queste
qui, non solo dell'UDI, ma tutto questo fermento del Partito
Comunista) e che tenta di rovesciare all'interno del partito la
visione del mondo, introducendo il punto di vista della differenza di
genere. L'UDI secondo me fa un percorso un po’ diverso; le
militanti del partito tentano di fare questo, l'UDI come struttura
solo di donne si scioglie e, secondo me, si riorganizza da un punto
di vista di movimento, quindi produce una rottura nei confronti dei
partiti, considerati espressione del maschile. […]L’UDI,
rompendo in questo modo, trasla, anima e corpo, nelle fila del più
sfegatato femminismo, perché in fondo loro scoprono, a loro
volta, in quegli anni, che cosa significa essere delle donne;
paradossalmente, scoprono la diversità femminile. Quindi, in
parte può essere stato strumentale, ma in parte, secondo me,
loro hanno fatto un percorso, per così dire, posticipato, di
quello che noi abbiamo fatto negli anni '70
(Donatella Barazzetti)
D’altro
lato, e simultaneamente, la ricerca di percorsi che si incrociano e
si separano, hanno difficoltà nel comunicare ma non sono
irrimediabilmente ostili:
I
rapporti con gli altri gruppi...Mi ricordo solo un 8 marzo che
abbiamo fatto insieme alle ragazze del Collettivo. Mi ricordo che una
persona mi chiese cosa ne pensavo ed io dissi quanto mi sembrasse
giusto. Io non sono per la frattura del movimento, non lo sono mai
stata. Anche nella politica rappresentativa, se non andiamo compatti,
insieme, (anche discutendo, bisticciando) non approdiamo a nulla.. mi
rendo conto che ci sono dei punti fermi, ma ci sono delle cose che
sono più importanti.
E
come è andato questo 8 marzo?
Benissimo.
Ci siamo divertite tutte. Abbiamo ballato, mangiato i dolci che
avevamo preparato.. ricordo questo, non ricordo altro. L'abbiamo
fatto in piazza...oltretutto, invece di essere le solite donne di una
certa età (perché eravamo giovani, ma non giovanissime)
avevamo tante giovani, che non erano soltanto le 'figlie di', ma
anche persone che erano del Collettivo. Io lo ricordo con piacere
quell'8 marzo, questa festa con tante giovani donne (Delia Fabrizi)
Nel
Collettivo, visitandolo, c’era sicuramente un altro clima, più
giovanile e spigliato, però mi era sembrato che i problemi
fossero affrontati in quanto calibrati si di sé, sulla propria
appartenenza generazionale, sulle proprie vicende affettive, ecc. E,
paradossalmente, pur essendo giovane, mi sembrava insufficiente
questo discorso; io avevo bisogno di una realtà in cui
incontrare donne di altre età, di altre formazioni, di altre
provenienze, anche di altre classi sociali. Perché pensavo –
e sono tornata su questa posizione oggi – che solamente
collocandoti in uno scenario ampio, strutturato, con una grande
progettualità collettiva, tu puoi anche (seppure in forma
mediata, indiretta) trovare delle risposte per te, e anche una tua
progettualità. Laddove invece misurarsi troppo su di sé
è un piano che ti apre prospettive nuove, ti dà pure
più forza e più coraggio lì per lì, però
tutto diventa…come dire…funzionale e subalterno alla
temperatura relazionale e affettiva del gruppo; ecco, questa è
una cosa che non volevo mettere in conto come possibilità;
dovevo trovare un’istituzione (allora non la chiamavo così),
un’organizzazione che ci sia anche indipendentemente da me e
dal tipo di apporto e coinvolgimento che posso dare […] Col
Collettivo [i rapporti] devo dirti che sono stati, per quello che io
ricordo, nel complesso buoni perché c’era la questione
dell’aborto…non è che non ci fossero delle
occasioni di confronto. Sicuramente poi, come è successo anche
altrove, tu notavi…non dico la diffidenza, ma la difficoltà
di queste donne a rapportarsi con quello che sentivano una struttura,
un’organizzazione, un’istituzione. E quindi c’era
questa riserva mentale, forse più da parte loro che da parte
nostra, perché da parte nostra c’era pure una curiosità
nei confronti del femminismo, anzi l’XI Congresso, quello che
destruttura l’UDI, è stato proprio perché
riteneva che il femminismo avesse delle proposte, delle modalità
di relazione che fossero così promettenti, così
feconde, da far pensare alla necessità di farsi trovare non
irrigidite in strutture gerarchiche ormai consolidate. Quindi c’era
una grossa aspettativa, apertura di credito. Forse quello che noi
trovavamo era, di fatto, che poi il Collettivo si dovesse misurare di
volta in volta su problemi che non avevano questo respiro…che
non potevano riguardare persone che invece noi avevamo sotto gli
occhi […]loro ti davano questi strumenti facendo sapere
che…lavoravo anche in altri contesti, ma lì tu eri
padrona di ricevere, di acquisire gli stessi strumenti e di usarli,
di gestirli, per quello che volevi fare tu, che volevi essere tu.
Un’Altrove ipotetico, che non era magari nemmeno prefigurato,
però tu sapevi che avevi la possibilità di aggancio con
una realtà politica, con un’etica collettiva, con una
dimensione collettiva che la tua dimensione invece, tutto sommato di
studentessa e giovane insegnante borghese, non ti avrebbe concesso in
nessun altro modo, se non attraverso la mediazione…che però
a quel punto era un po’ troppo, come dire…esigente, di
un partito, che ti avrebbe cambiato totalmente la tua fisionomia,
però non ti lasciava nemmeno la possibilità di decidere
in che modo volevi stare dentro la politica. Ecco, questa è
stata la cosa che secondo me ha creato questo impatto fortissimo
dell’UDI in generale nella realtà italiana, e in
particolare qui a Catanzaro; perché era un modo per avvicinare
donne di varia estrazione e di varia provenienza attraverso una
progettualità, era un luogo mediato, era un luogo in cui tu
dovevi affrontare dei problemi. Non ci si rapportava senza diaframmi,
ma questi diaframmi costituivano anche il legame con cui tu potevi
realmente rapportarti a tu per tu con donne che non avresti mai
incrociato se non attraverso relazioni che magari non appartenevano
al disegno che volevi dare alla tua vita. (Annalisa Marino)
Noi
ci sentivamo più avanti...eravamo, rispetto alle donne
dell'UDI, più giovani, più radicali, perché come
collettivo femminista facevamo l'esperienza della nuova sinistra,
quindi legavamo insieme le due cose. Eravamo, tra virgolette, più
'estremiste', rispetto alle donne dell'UDI che consideravamo
emancipazioniste, perché soprattuto in una prima fase è
stato così, poi l'UDI è stata molto toccata dal
pensiero della differenza, e quindi c'è stata un'altra fase,
però la prima fase...Diciamo che ora, rivedendola con gli
occhi di oggi, penso che da parte di nostra c'era una sorta di
ribellione a quelle che erano state le madri, quindi il rifiuto di
quella libertà femminile che era soprattutto libertà di
movimento, di reddito, di lavoro, ma non di pensiero, di
organizzazione della vita. Però c'era anche un po' di
ingratitudine, perché in fondo, invece, loro ci avevano aperto
una grande strada, e forse le donne dell'UDI, in quella prima parte,
non seppero molto parlare con i Collettivi. Però non ci fu la
stessa distanza, la stessa dicotomia, che ci fu per esempio tra
Partito Comunista e gruppi della nuova sinistra, fra cui ci fu una
cesura radicale. Invece, nonostante si ripetevano anche nelle
generazioni e nelle appartenenze politiche più o meno lo
stesso tipo di divisioni, però in qualche modo c'era più
comunicazione, più trasversalità (Rosa.Tavella.)
Esistono
anche esempio
di collaborazione: nel caso del consultorio autogestito è
proprio l’incontro sul territorio, e la contaminazione fra
esperienze diverse, a gestire un luogo comune di aggregazione e
organizzazione. Collaborazioni in netta contrapposizione con il
passato, che caratterizzano, su particolari temi, questo momento
storico:
In
quegli anni [anni Sessanta] c'era una competitività e una
chiusura...non si riusciva nemmeno a capire che poi, in fondo, si
lavorava per un obiettivo che era comune, che era questa liberazione
delle donne. Era prevalente l'aspetto ideologico, era prevalente
l'appartenenza. […] [Negli anni Settanta] fu il fiorire
dell'associazionismo, che ebbe un aspetto importante, perché
consentì alle donne di stare insieme. E solo stando insieme,
ribadendo, discutendo…Tante volte sembrava che questi
movimenti fossero lontani dalla politica. Io non sono di questo
parere, perché secondo me interrogarsi sui problemi del mondo,
della società più vicina, dei problemi che ci
riguardano, questo è già fare politica (Clara
Sanginiti)
Negli
anni Ottanta compare, evidente, una discontinuità con il
passato. Mutano le pratiche politiche, ma cambiano anche le pratiche
dei referenti esterni. L’UDI si trasforma e si avvicina al
femminismo della differenza; nuovi gruppi nascono e si collocano in
una dimensione classicamente istituzionale; d’altra parte, la
crisi dei movimenti e della nuova sinistra produce un riavvicinamento
fra gruppi di donne e forze politiche tradizionali, mediato
dall’ingresso nel discorso pubblico della dimensione delle pari
opportunità. La vicenda dell’UDI (l’abbandono
della struttura organizzata) è coerente con la direzione di
ricerca teorica assunta dalle sue militanti. La consapevolezza
dell’inadeguatezza della struttura, come si era storicamente
organizzata, innesca una dinamica trasformatrice che diviene
irreversibile e che, tuttavia, proprio a partire dalla ricchezza di
questa esperienza,
si esprime nella volontà di continuare a lavorare intorno al
senso e alla forma della politica delle donne: «Si può
pensare che nell’associazione sia venuta in crisi, a partire da
un contatto tra donne che ha suscitato un rinnovarsi delle molteplici
identità, e dall’approccio diverso alle forme della
politica che si è registrato nei confronti del femminismo, una
forma in sé del fare politica che ne ha compromesso l’identità
complessiva, investendo la stessa organizzazione formale, e la ha
«compromessa» ad un livello tale che il confronto tra le
molteplicità delle identità delle donne ha spazzato lo
stesso retroterra consolidato degli elementi fondamentali
l’organizzazione, ne ha frantumato il principio di autorità
e legittimizzazione, aprendo, nella maggioranza delle aderenti,
interrogativi sullo stesso rapporto tra forma organizzativa
storicamente consolidata, fini perseguiti e livelli di solidarietà
espressi» (Rauty, 1988: 79).
Sono
questi gli anni di massima visibilità sulla scena pubblica, e
contemporaneamente dei conflitti più aspri fra gruppi, delle
crisi e degli allontanamenti, dell’emergere di conflitti e
tensioni fra donne che danno vita a nuovi gruppi, differenti
aggregazioni che coinvolgono un numero sempre maggiore di donne. In
questo scenario, alcune battaglie comuni, come l’abolizione del
reato d’aborto, la libera scelta delle donne rispetto al
proprio corpo e all’essere madri, la temuta nuova
regolamentazione del corpo femminile. Questioni che uniscono nella
riflessione, ma che rivelano inevitabili contraddizioni nella pratica
e nelle scelte di campo.
La
parabola dell’UDI presenta, nel ricordo delle protagoniste,
caratteri ambivalenti. Una svolta per alcuni versi inattesa, per
altri coerente con il percorso intellettuale e militante
dell’organizzazione (Cfr. Cap. ???).
Un’altra
modalità dell’UDI di Catanzaro, subito il coinvolgimento
in funzioni di responsabilità direttive, quindi nel consiglio
direttivo, e mi ricordo anche nella Segreteria provinciale dell’UDI:
E quindi da lì io ho avuto modo di impegnarmi di più,
di lavorare di più, e quindi anche la responsabilità di
seguire…ecco, un’altra modalità di lavoro, perché
veramente imparavi tutto…il discorso politico, lo stile di un
volantino, il manifesto, le parole usate, l’ordine dei temi,
l’agenda, tutto costituiva oggetto di attenzione e, a volte, di
discussione; persino il colore, per esempio, di un manifesto. E
quindi diventava una sorta di laboratorio di politica, in cui tutto
convergeva a far arrivare delle motivazioni, delle letture, delle
chiavi di interpretazione della realtà, in maniera
assolutamente puntuale. E poi avevamo uno scenario di donne, le più
svariate. C’era questa abitudine a fare volantinaggio nei
caseggiati, quindi tu vedevi…andavi nei quartieri, ovviamente
di periferia, vedevi degli alveari, delle donne da sole, che a volte
erano proprio contente di poter parlare con qualcuno, di farle
entrare, quasi mai erano diffidenti. Era una modalità di
viversi i problemi più profondi senza poterli nominare,
laddove invece adesso è il contrario, si può dire: il
poterli nominare a volte non è stato accompagnato dal poterli
riempire di contenuti più problematici; e poi c’è
stata una cultura, un’informazione, che ha un po’
snaturato tante di queste chiavi di lettura. (Annalisa Marino)
I
conflitti con il movimento femminista sono legati alla
contrapposizione fra emancipazione e liberazione, che solo alla fine
degli anni Settanta sono pensati come intrecciati dalle donne
dell’UDI. L’aspetto che tutte le intervistate
sottolineano è l’organizzazione gerarchica e
verticistica che, coerente in un contesto di stretto rapporto con il
PCI, diventa una trappola nel confronto con una realtà in
evoluzione. Il rapporto che si riconfigura con il Partito Comunista è
fortemente critico: sono messe in discussione tanto la struttura
politico-organizzativa quanto il centralismo democratico e le
pratiche gerarchiche. L’insofferenza per l’aspetto
istituzionale culmina con l’avvicinamento di molte aderenti al
pensiero femminista e si concretizza con l’XI Congresso del
1982, che aveva come titolo “La nostra politica e la
liberazione”: «L’identità,l’autodeterminazione,
il separatismo, la comunicazione fondano il nostro potere, che
innanzitutto significa poter essere; poter realizzare cioè i
nostri bisogni, i nostri desideri, i nostri progetti; esprimere la
nostra politicità che non può prescindere da uno spazio
e da un tempo costruito da noi e per noi» (Michetti, Repetto e
Viviani, 1984: 467).
Nel
ricordo delle intervistate aderenti all’UDI, tuttavia, questo
processo viene ricostruito non in maniera meccanica e consequenziale,
ma assume le caratteristiche di un percorso coerente con le
specificità dell’UDI di Catanzaro e delle sezioni della
provincia (Badolato, Lamezia, Soverato): una specificità che
assume i tratti di un’indipendenza intellettuale,
un’effervescenza che anticipa molti tratti della svolta
successiva:
[Con
il partito Comunista] è' stato un rapporto molto conflittuale
perché questo movimento cresceva molto, e crescendo così
tanto portava dentro elementi di autonomia forte. Quindi lo
sforzo...faccio un esempio: noi avevamo il sindacato a Catanzaro, il
sindacato scuola, ma anche lì – quando aprimmo la
battaglia per queste maestre – ci rendemmo conto che c'erano
canali privilegiato, canali non trasparanti. E quindi ecco lo scontro
forte. Soprattutto la mia persona era diventata un personaggio
d'attacco. Io ho vissuto la doppia militanza con grande sofferenza e
scontro, soprattutto. Perché lo scontro, il conflitto, c'era.
Ne avevo consapevolezza. Man mano che questo percorso andava avanti,
io sentivo le donne molto pronte, e ancora di più vedevo
questa organizzazione del partito maschilista, questo trincerarsi,
questa paura del nuovo. Era proprio paura del nuovo, di questo
scardinamento che il movimento portava […]Il conflitto c'era
ancora, e non era solo qui. Era nazionale. L'UDI era nata come fatto
spontaneo, ma collaborava col partito, prendeva fondi dal PCI. E
allora noi andammo sempre di più, come impostazione nazionale,
a liberarci da questa schiavitù dei fondi, quindi
l'autofinanziamento, proprio per poter camminare con le nostre gambe.
Su questo percorso forse siamo state un po’ troppo veloci,
perché...l'aborto è stato nell'81, nell'82 noi
decidemmo di sciogliere l'UDI. Avevamo teorizzato...e questo è
stato a distanza di anni non un errore, perché il discorso era
serio...Avevamo teorizzato che questa associazione, che aveva mutuato
la sua organizzazione dal partito, dai partiti, era un'organizzazione
piramidale e che non c'era nulla da fare: in questa organizzazione
piramidale le donne copiavano il modello maschile, per cui bisognava
cambiarla completamente, lasciare che i gruppi spontanei si
organizzassero. Accadde questo, infatti a Catanzaro negli anni
'83-'84 si fecero delle cose splendide, però poi non ha retto
(Annamaria Longo)
C’era
una specificità anche, in generale, rispetto al Sud, e alla
Calabria in particolare. Perché nelle altre realtà si
andava soprattutto per temi, molto organizzate ecc. Nella nostra
realtà c’era, grazie ripeto a questa figura
straordinaria che è stata Annamaria Longo, la volontà
di calare tutto sulla libertà delle donne. Io ricordo che ho
rasentato anche la questione dei consultori e degli asili nido, e mi
ricordo che…come venivano affrontate queste cose? C’erano
riunioni in cui la dirigente istruiva la questione, dava i termini
della questione e mi è rimasta impressa questa cosa:
attenzione – diceva – gli asili nido è chiaro che
si fanno per i bambini, perché creino delle condizioni di
socialità, d sicurezza di crescita, però ricordate che
noi dobbiamo lottare per le donne, perché le donne hanno
bisogno di liberare il loro tempo; anche per essere buone madri, in
condizioni migliori, di maggiore fiducia e libertà rispetto al
loto tempo. Quindi era tutto un lavorare per calibrare…non per
dire “ci adeguiamo all’agenda del momento”, che
spesso non era scelta da noi, era pure un discorso al quale a volte
eravamo obbligate, laddove invece la grande questione che ci
interessava era la relazione con la società maschile, la
sessualità femminile, il progetto di sé, come le varie
fasi della vita di una donna si potessero rileggere; era tutto un
altro discorso. Quindi c’era questa forza dell’UDI di
Catanzaro, che era anche numerica, ma anche di straordinaria capacità
organizzativa, di straordinario impatto, c’era proprio il
coinvolgimento di tantissime donne e tutte messe a lavorare con vari
ruoli, con varie competenze, ma per creare una sorta di…non
solo di impatto politico, ma anche di riferimento nella città.
E non a caso questo funzionava, perché eravamo conosciute e
riconosciute proprio dappertutto, c’era una apertura di credito
straordinaria, e anche una grande possibilità di conoscere
donne di altre formazioni – penso al CIF – con cui ti
misuravi.[…] Le
donne che erano già molto addentro nell’UDI, quasi tutte
appartenevano ad altri partiti, soprattutto il PCI, e poi il Partito
Socialista. Ovviamente non dissimulavano, ma né protestavano,
esibivano, la loro appartenenza al Partito. Si sapeva che
esercitavano la “doppia militanza”, così si
chiamava, però avevano questa modalità nei confronti di
chi veniva via via…mostravano come si fa politica in un luogo
di donne, quali sono gli strumenti di cui dotarsi per fare politica e
quale era la loro modalità di rapporto nei confronti del
Partito. Spesso era critica, senza per questo giudicare la loro
appartenenza, la loro voglia di misurarsi su altre cose. Quindi, io
perlomeno mi ricordo, avevo questa netta sensazione che intanto mi
facevano vedere come si lavorava, come si impostava un problema, e
per me è stata un’esperienza importante perché,
in fondo, ancora oggi, se ho una grande passione politica, non è
perché sono passata dal Partito, ma è attraverso la
mediazione dell’UDI; laddove invece, quando ho rasentato
contesti più connotati politicamente, se non proprio di
partito, spesso ho vissuto…non dico con disagio perché
non è vero, ci sono stati sempre momenti di confronto, ma con
una sorta di pigrizia, di stanchezza, sentivi che mancava qualcosa
che fosse calibrato su di te, e non c’era neppure la
progettualità che perlomeno un partito dovrebbe possedere.
Ecco, loro ti davano questi strumenti facendo sapere che…lavoravo
anche in altri contesti, ma lì tu eri padrona di ricevere, di
acquisire gli stessi strumenti e di usarli, di gestirli, per quello
che volevi fare tu, che volevi essere tu. Un’Altrove ipotetico,
che non era magari nemmeno prefigurato, però tu sapevi che
avevi la possibilità di aggancio con una realtà
politica, con un’etica collettiva, con una dimensione
collettiva che la tua dimensione invece, tutto sommato di studentessa
e giovane insegnante borghese, non ti avrebbe concesso in nessun
altro modo, se non attraverso la mediazione…che però a
quel punto era un po’ troppo, come dire…esigente, di un
partito, che ti avrebbe cambiato totalmente la tua fisionomia, però
non ti lasciava nemmeno la possibilità di decidere in che modo
volevi stare dentro la politica. Ecco, questa è stata la cosa
che secondo me ha creato questo impatto fortissimo dell’UDI in
generale nella realtà italiana, e in particolare qui a
Catanzaro; perché era un modo per avvicinare donne di varia
estrazione e di varia provenienza attraverso una progettualità,
era un luogo mediato, era un luogo in cui tu dovevi affrontare dei
problemi. Non ci si rapportava senza diaframmi, ma questi diaframmi
costituivano anche il legame con cui tu potevi realmente rapportarti
a tu per tu con donne che non avresti mai incrociato se non
attraverso relazioni che magari non appartenevano al disegno che
volevi dare alla tua vita (Annalisa Marino)
La
‘doppia militanza’, il disagio di far convivere
l’esperienza politica (la ricerca dell’uguaglianza’)
con le tematiche della differenza, emerge come situazione dolorosa e
carica di contraddizioni. Una contraddizione che sembra sciogliersi
quando l’UDI decide di eliminare il verticismo, scegliendo la
strada dell’autoconvocazione, lasciando la libertà a
riunirsi alle donne che desideravano continuare un percorso su alcune
tematiche specifiche. Una contraddizione che tuttavia appare
speculare a quella che affrontano le donne che decidono di perseguire
la strada dell’emancipazione, e che per questo tralasciano la
dimensione della soggettività. Il conflitto è nella
stessa teorizzazione politica dei femminismi, fra la visione
egalitaria e rifiuto del modello emancipativo per la ricerca di
un’autenticità fondata in se stesse e nel rapporto con
le proprie simili. Un conflitto risolvibile, nelle parole di Maria
Rivera Garretas: «Da
una parte il femminismo dell’uguaglianza e dall’altra il
femminismo della differenza. In realtà esse si contrappongono
a torto perché il contrario di uguaglianza è
diseguaglianza, non differenza. [...] Entrambe le proposte teoriche e
politiche, quella dell’uguaglianza e quella della differenza,
hanno come obiettivo la libertà delle donne. Una intende
questa libertà in termini di liberazione della donna nella
eterorealtà della persona umana, del regime dell’uno,
l’altra cerca la libertà femminile in un mondo che operi
nel regime del due [...] Sono due opzioni politiche e simboliche che
nascono in luoghi diversi e desiderano arrivare a luoghi diversi»
(Rivera
Garretas, 1998: 56; 132-133).
Io
ho vissuto la doppia militanza con grande sofferenza e scontro,
soprattutto. Perché lo scontro, il conflitto, c'era. Ne avevo
consapevolezza. Man mano che questo percorso andava avanti, io
sentivo le donne molto pronte, e ancora di più vedevo questa
organizzazione del partito maschilista, questo trincerarsi, questa
paura del nuovo. Era proprio paura del nuovo, di questo scardinamento
che il movimento portava. Poi nel '72 ci sono state le alluvioni in
Calabria, e lì l'UDI entrò nel vivo di un rapporto con
tutte le persone che erano state alluvionate. Organizzammo a Valle
Fiorita una distribuzione di pacchi...fu una parentesi un po' più
assistenzialista, per l'emergenza, e che tuttavia servì
all'UDI per estendere i suoi rapporti, i suoi collegamenti. Il
profilo era sempre quello di quale aiuto dare alle donne, rapportarsi
a loro e alle loro esperienze. Intanto crescevano gli impegni, temi
più innovativi, il periodo '72- '73, i consultori. Lì
ci fu la svolta vera, delle tematiche...perché per la prima
volta, con i consultori, si parlò per la prima volta non solo
della conquista dei servizi primari, ma si cominciò a
discutere di tutta la tematica della sessualità (Annamaria
Longo)
L’UDI
sceglie di percorrere la strada della differenza, riannodando le
trame di quello che, negli anni Settanta, era stato un duro conflitto
generazionale. Molte intervistate, in particolare, sottolineano il
carattere innovativo di alcuni temi affrontati in questo periodo, in
particolare, l’attenzione verso un tema divenuto in seguito
caro al movimento delle donne: il seminario “Perché la
madre: ipotesi del “rapporto madre e figlia”, tuttavia, è
l’ultimo lavoro dell’UDI di Catanzaro:
Già
negli anni settanta noi a Catanzaro facevamo delle cose che erano al
di là della “politica UDI”; in parte diverse dai
temi che si stavano trattando a livello nazionale. Sono state cose
sempre più interessanti. Non ricordo gli anni precisi, però
la Libreria delle Donne di Milano, con il primo Sottosopra, quello
sulla psicoanalisi..sembrava dire il fallimento – nella
testimonianza di alcune di loro – del femminismo che
conoscevamo.. Ricordo un seminario in cui intervenne Renate Siebert,
sul femminismo e l'autocoscienza e su questo fallimento. [L’UDI
di Catanzaro] non era una “cinta di trasmissione del PCI”,
detto come va detto e come era invece in altre parti d’Italia.
Poi è chiaro..eravamo di sinistra. Per questo ad un certo
punto forse c'è stato anche facile l'XI Congresso, tante di
noi lo avevamo già dentro (Delia Fabrizi)
Avevamo
partecipato intensamente al X° e all’XI° Congresso
Nazionale dell’UDI, il femminismo ci aveva contaminate tutte,
dai vertici alla base, e la struttura era ormai inadeguata: da
movimento di emancipazione per
le donne eravamo diventate movimento di liberazione delle
donne. Non più deleghe nè rappresentanza, ognuna
rappresentava solo se stessa e al massimo, autoproponendosi, si
assumeva la responsabilità della gestione di un’organizzazione
storica che dalle partigiane fondatrici aveva per oltre trent’anni
aggregato donne di ogni estrazione sociale (Assunta Di Cunzolo)
Paradossale,
per alcune intervistate, appare lo sfaldamento dell’UDI di
Catanzaro appena qualche anno dopo, quando diventa un’organizzazione
politica delle
donne, anziché per
le donne, come se “le parole per dirlo”, nel momento in
cui diventano rumorose, lascino lo spazio al silenzio. Parole che,
senza dubbio, non lasciano una traccia fisica. Alcune risposte
rispetto all’assenza di tracce scritte suggeriscono una
riflessione più generale sulla trasmissione della storia del
femminismo: non si dava valore alle cose che si facevano; non si
volevano lasciare segni (verbalizzare, archiviare, mettere tutto in
ordine) come si procedeva nelle organizzazioni maschili; il rifiuto
di pensare la storia in generale, quando l’interesse era sulle
storie individuali. Sicuramente la ‘fatica’, e il
disagio, di rinchiudere e limitare, in un solo racconto o in una sola
definizione e interpretazione un’esperienza così
intimamente connessa alle esistenze individuali:
Dopo
l'XI Congresso abbiamo realizzato una serie di iniziative..(.l'XI
Congresso è quello che ha destrutturato il verticismo
nell’UDI) e abbiamo fatto corsi e percorsi molto interessanti,
di cui purtroppo, con la superficialità con cui troppe volte
noi donne consideriamo i lavori che facciamo, non abbiamo pubblicato
gli atti. E questo lavoro era su Virginia Woolf, su Adrienne Rich, su
Edith Warton e poi, in seguito, il gruppo rimasto ha lavorato per
realizzare l'ultima parte del progetto, che abbiamo intitolato
“Perché la madre?” Ipotesi sul rapporto
madre-figlia.” Era uscito il sottosopra verde con il documento
(della Libreria delle donne di Milano) sull'affidamento, su cui
abbiamo molto discusso a Catanzaro. Quando io sento parlare di
autorità e affidamento sto male, ma questo è un mio
problema personale. Però ricordo anche che discutevamo di
separatismo, l’emancipazione era un discorso noto tutto
sommato, perché la maggior parte di noi eravamo o insegnanti,
o professioniste, eravamo già 'emancipate', si diceva
all'epoca, quindi il tema della “liberazione” poteva
prenderci un po’ di più – anche se poi, abitando a
Catanzaro, era molto più complicato il tutto! Ed era più
complicato vederlo dentro noi stesse. Ritengo che è uno dei
motivi per cui poi noi abbiamo lasciato perdere...Il seminario sul
rapporto madre-figlia aveva aperto una falla in ognuna di noi;
eravamo nell'85, in epoche molto 'primitive'! […] Secondo me
noi eravamo già nella destrutturazione. E' chiaro che non lo
sapevamo. Cosa significava esattamente destrutturazione? Però
anche forse chi teneva il potere non ha saputo capire certe cose.
Secondo me c'è stata proprio una debacle relazionale. Finiti i
ruoli è come se...fossimo scoppiate. Io l'ho provato sulla mia
pelle, ricordo di aver avuto da ridire, in maniera anche piuttosto
pesante...Non una questione solo di rapporti, perché i
rapporti c'erano, ma sulla valutazione delle scelte, che avevo fatto
da sola, senza influenze o giudizi che potevano venire dall'esterno
(Delia Fabrizi)
Ai
congressi avevamo anche noi votato per demolire l’UDI come
struttura verticistica -lo slogan era ‘meno organizzazione, più
movimento’- ma, dopo il XII° congresso (fu la prima
autoconvocazione?), che io sappia, non ci riunimmo più nel
circolo di Soverato. Forse la lettura del Sottosopra Verde, forse la
convinzione che tutto appartenesse ormai al passato senza prospettive
e senza speranza, forse la stanchezza, forse non reggevamo più
il conflitto all’esterno ma soprattutto all’interno. Non
ricordo con precisione…ma, se avevamo bene imparato ad
attivare antagonismi e mediazioni all’esterno, non eravamo
ancora pronte o, meglio, non avevamo gli strumenti per imparare a
gestire i conflitti tra noi; sapevamo solo soffrirne oppure godere
dell’attacco all’altra oppure sottrarci andando via. E,
alla fine, non tutte insieme ma ognuna andò via. Dopo qualche
anno anche l’UDI di Catanzaro interruppe ogni attività,
tra le ultime ricordo il convegno su “Cambia il modo di vivere
perché cambia il modo di lavorare” concluso con una
pubblicazione e un seminario su Virginia Wolf. Probabilmente era il
1984/’85 (Assunta Di Cunzolo)
Molti
in seguito, negli anni successivi, hanno pensato che l’UDI si
fosse sciolta; ancora adesso qualcuno sostiene che nell’82
l’UDI si è sciolta. No, l’UDI si è
destrutturata, ha fatto un enorme gesto che molti hanno considerato
come anticipatore; ha completamento reciso i suoi legami di
dipendenza economica con il PCI; riceveva infatti un finanziamento
dell’ordine di circa 80 milioni l’anno, ha rinunciato, e
ha
questa decisione hanno partecipato, hanno detto sì, donne che
vivevano…erano funzionarie dell’UDI, con stipendi che
venivano pagati anche grazie a questo finanziamento del PCI. Hanno
votato per lo scioglimento, e quindi per la loro disoccupazione.
Quindi è stato un atto di coraggio straordinario, proprio come
ultimo segnale di un processo di autonomia nei confronti del partito
che era iniziato molti anni prima, e che con la questione del
divorzio e dell’aborto si era reso manifesto, perché tu
sai benissimo che all’interno del PCI, sia nei confronti del
divorzio prima, che dell’aborto, c’erano delle freddezze,
delle diffidenze, riserve mentali (Annalisa Marino)
Si
scioglie perché....Qui ci sarebbe da approfondire...forse non
l'ho mai voluto approfondire. Il problema è questo: non c'è
più il riferimento romano, siamo sole. Ma non era questo,
perché qui c'era proprio una vivacità culturale molto
avanzata, molto all'avanguardia. Questa vivacità culturale
aveva questo limite, che è un limite anche mio, personale: io
ho precorso i tempi, ed era difficile trascinarsi dietro le altre.
Questa corsa avanzata è stata una caratteristica fino all'84.
E' un limite mio, credo di essermelo portato sempre dietro: un
precorrere i tempi, con intuizioni politiche giuste, non sbagliate,
che tuttavia deve aspettare la maturazione degli altri, altrimenti
vai avanti da sola, e non hai gli altri che ti seguono, ed è
difficile portarsele tutte. Era stata una fatica grossa, però
c'era la gratificazione di arrivare...Io invece nell'84 vedo che il
gruppo dirigente mi mette sotto accusa; la mia sensazione è
stata questa, come l'ho vissuta io. Mette sotto accusa non l'elemento
che andava avanti, ma l'elemento che poteva bloccare le iniziative
delle altre […] Questo gruppo grosso, vasto – ognuna
aveva delle capacità, delle qualità, insieme si faceva
sistema, si produceva un impatto...Secondo me ci fu...oppure il
percorso era già consumato. Alcune pensavano di poter
raggiungere posizioni di potere. Conclusione invece è stata
che io, di punto in bianco, mi alzai, sbattei la porta e andai via,
lasciando tutto là. Passarono forse due mesi, tre mesi, e non
furono capaci di andare avanti. Questa è la lettura che io dò.
Io non ho voluto neanche liquidare...altre – non so neanche chi
- fecero la liquidazione. Forse (non lo so), probabilmente avrò
sbagliato anche io; però mi ero stancata. Evidentemente sono
stata investita da questa velleità – perché erano
velleitarie queste ambizioni – e ne capivo il velleitarismo, ma
non ho avuto la forza di resistere, di mediare, di farli maturare.
Ero stanca, e quindi lasciai (Annamaria Longo)
Manca
completamente esperienza UDI Soverato: consultorio (il primo ad
essere istituito in Calabria con gestione al femminile e per
affermare il concetto di autodeterminazione della donna a partire
dalla sessualità, ancora oggi indigeribile dal patriarcato) e
centro legale, credo il 1° in Calabria aperto nel 1982 e
completamente autogestito (senza finanziamenti pubblici e con
rapporti con Lagostena Bassi, quella dei delitti del Circeo, di cui
si è recentemente riparlato a proposito di Izzo e i suoi nuovi
misfatti; puoi trovare il materiale che ti serve nel mio racconto
oppure nei documenti che ho dato a Maria Marino). Pensa che martedì
scorso (7 marzo), in un incontro a Lamezia, organizzato da Rosa
Tavella e con la presenza di Lo Moro e i suoi dirigenti sanità,
è stato riconosciuto pubblicamente il ruolo dell’UDI
alla fine degli anni ‘70 nel territorio del soveratese
dall’attuale direttore generale, dal momento che –detto
testualmente- è l’unico comprensorio della provincia
dimensionato per numero di consultori esistenti: 4 (a Soverato,
Badolato, Chiaravalle, Girifalco) su una popolazione di meno di
80.000 abitanti, attribuendo il dato alla positiva conflittualità
del movimento con le Istituzioni.
Al
di là dell’esperienza dell’UDI di Catanzaro, è
necessario sottolineare l’importanza e il significato politico
e simbolico di un gesto destinato a ripetersi. Dalla condivisione di
spazi neutri, si passa alla creazione e alla scelta di spazi
femminili autonomi. Da un lato quindi i gruppi di presa di coscienza,
dall’altro le migliaia di donne che scendevano nelle strade,
mettendo in discussione le relazioni di genere esistenti, i
tradizionali ruoli nella famiglia e nella società.
L’esperienza personale viene legittimata come fonte di
conoscenza, mentre crolla definitivamente la divisione fra sfera
pubblica e privata. Non è più in questione l’estensione
della cittadinanza alle donne, ma la costruzione di nuovi luoghi che
assumano rilevanza collettiva.
Il
“Centro Donna Lilith” nasce nel 1988 per creare, a
Lamezia Terme un luogo privilegiato di relazioni tra donne. E’
una sinergia fra elaborazione teorica segnata dal pensiero della
differenza e istituzioni locali: a seguito del finanziamento concesso
dalla Regione Calabria (Progetto Donna), infatti, viene aperto
l’ufficio di consulenza e assistenza legale, che comprende la
costituzione di parte civile nei processi penali ed altre iniziative
a tutela dei diritti e degli interessi delle donne. Il Centro Donna
Lilith si propone di “creare, potenziare e diffondere una
cultura basata sul rispetto della persona e della dignità
umana per una migliore qualità della vita e per favorire lo
sviluppo culturale sociale e politico della realtà donna”,
attraverso una vasta comunicazione tra donne che rafforzi la
consapevolezza del proprio portato culturale e che favorisca la
trasmissione nella società dei valori della cultura femminile.
L’attività del Centro infatti si svolge anche sul piano
culturale, oltre all’assistenza legale:
Teresa
Barberio è stata la fondatrice del centro Lilith a Lamezia,
che nasce con un fortissimo impulso organizzativo. Stiamo parlando
della fine degli anni '80. E' stato importantissimo, perché al
di là del discorso dello stare insieme, noi abbiamo dato vita
ad un ufficio gratuito di assistenza legale alle donne, e per la
prima volta, secondo me, si è cominciato a parlare di
solidarietà femminile e non in termini di solidarietà,
di carità, nell'ambito di quelle iniziative che comunque
vengono svolte anche da enti religiosi, oppure come discorso
emancipatorio, ma proprio come discorso di solidarietà, di
condivisione con altre donne. Se vuoi, ci siamo anche molto lanciate
in un discorso di questo genere, ci mettevamo anche a rispondere al
Telefono Rosa – che avevamo inventato noi – nel senso
che, senza neanche competenze specifiche, però stavamo a
raccogliere le denunce che ci venivano dalle donne; e poi abbiamo
contattato le avvocatesse – cercavamo soprattutto delle donne –
che potessero dare assistenza legale in modo gratuito, e siamo
riuscite a tirare fuori un paio di donne. Poi abbiamo fatto anche dei
dibattiti, abbiamo invitato Renate Siebert fra le altre,
sull'episodio di Rosetta Cerminara, quindi ci sono state delle
iniziative pubbliche. E poi è stato importantissimo il Centro
Lilith perché, in quell'ambito lì, abbiamo scoperto il
pensiero della differenza sessuale. Tieni conto che io, lavorando in
banca – erano gli anni che avevamo i figli piccoli, e ce li
portavamo dietro alle riunioni – a me capitò di andare
ad un corso organizzato dal sindacato dei bancari e rivolto alle
donne a Bologna, e lì ho avuto una fortuna pazzesca perché
c'era Luisa Muraro. Quindi quando sono tornata ho portato tutto il
materiale, e lì per me si è spalancato tutto un
orizzonte nuovo come impostazione, e praticamente la sera, dopo cena,
ci vedevamo nella sede del centro Lilith e leggevamo gli interventi
di Luisa Muraro. Per poi leggere tutti i libri, rileggerli e
commentarli. Questo è stato un passaggio decisivo e
importantissimo per quanto mi riguarda (Loredana Rubino)
Il
Centro Lilith aveva al suo interno donne molto diverse; donne che
venivano dall'esperienza dei partiti, alcune con esperienza del
femminismo degli anni '70, altre invece digiune completamente, che
facevano nel Centro la loro prima esperienza politica. Questo
naturalmente poteva essere anche un fatto positivo, però
questa enorme diversità non è riuscita poi a costruire
un gruppo che in qualche modo avesse una solidità di pensiero,
di pratica politica. C'è stata tutta una prima fase, guidata
molto da Teresa Barberio – che ne era la presidente – di
grande entusiasmo, anche di grande aggregazione – perché
poi era rimasta l'unica aggregazione politica fuori dai partiti che
riuniva donne. Questa esperienza dell'ufficio legale è stata
molto interessante, perché ha fatto venire le donne del Centro
in contatto con esperienze anche abbastanza dure di violenza
domestica, di violenza sessuale, di separazioni, di conflitti anche
drammatici. E, tramite questa esperienza, anche la comunicazione con
altri gruppi, tipo il Centro Lanzino, che si occupava più o
meno delle stesse cose, anche se con un taglio un po' diverso.
Finisce, io penso, perché c'era molta eterogeneità
senza che ci sia stata la capacità di costruire gruppo. Poi
c'è stata anche la difficoltà economica: non ci sono
stati più i finanziamenti del Progetto Donna, quindi –
siccome era tutto intorno all'ufficio legale – nel momento in
cui i finanziamenti non sono più continuati, c'è stata
questa difficoltà. Quindi, difficoltà politiche e
difficoltà concrete...poi forse di storie personali,
esaurimento di risorse... Teresa è andata via, non c'è
stato un ricambio abbastanza autorevole, tanto da portare avanti
questo tipo di esperienza (Rosa Tavella)
Dell’esperienza
dei gruppi di donne precedenti, negli anni Novanta, sono via via
scomparsi i caratteri principali: una sede, un luogo, uno spazio
pubblico dove le parole diventano materia per capire sé stessi
e per agire, dove discutere è costruire idee e progettare un
futuro diverso. Poche le eccezioni, costruite attraverso esperienze
che, da percorsi lontani e apparentemente incompatibili (le donne di
Kore e della FIDAPA che si incontrano nell’esperienza della
Biblioteca delle Donne di Soverato) si confrontano e danno vita a
luoghi fisici e simbolici altri:
Non
è stato facile. Da parte nostra...loro [della FIDAPA] non
sappiamo cosa hanno pensato, perché non hanno l'abitudine al
conflitto. Noi sì. Molte di noi hanno pensato che erano troppo
borghesi, troppo perbeniste o altro, invece è stata un'ottima
cosa. Abbiamo visto che erano delle donne intelligenti, capaci, che
avevano voglia di....poi ci vedevano come se noi sapessimo tutto! Ci
hanno riconosciuto un sapere. E' stato molto bello, senza invidia,
sono state delle donne limpide. Adesso non
mi più di parlare
di “quelle di Fidapa”, per me sono le donne della
Biblioteca. Non ha più senso questa distinzione. La Biblioteca
nasce da questa idea che solo il sapere può affrancare;
nemmeno affrancare, ma rendere liberi (Fulvia Geracioti)
Se
parlare della propria storia non è facile, altrettanto
difficile è descrivere il presente, soprattutto quando
presenta caratteristiche ambivalenti e problematiche:
Le
occasioni mancate forse sono tante. Per quello che mi riguarda, a un
certo punto della mia esperienza politica – non so se è
stato soltanto un limite soggettivo ma un limite anche del partito
nel quale continuo a lavorare – non sono riuscita a ricostruire
(io insieme ad altre) un collegamento fra le varie esperienze di
donne, sia di quelle che lavorano in maniera singola, o all'interno
di formazioni miste, sia quelle che mantengono dei gruppi di donne,
come quelle della Biblioteca di Soverato, le donne dell'Università,
il Lanzino; un collegamento che riuscisse in qualche modo a tenere in
piedi – su tematiche o semplicemente sulla politica –
l'esperienze che ciascuna di noi aveva vissuto. Questa è una
cosa che ci penso sempre, mi dico: “Perché questa cosa
non sono riuscita a farla?” Perché non riusciamo più
a comunicare, a trovare dei momenti collettivi, come è
successo...magari partendo da un tema specifico, o da uno generale,
insomma una cosa qualsiasi (Rosa Tavella)
I
fili delle parole, per molte intervistate, si riannodano negli
anni Novanta (avviene alla fine anni ’80, quando è stato
pubblicato Non
credere di
avere
dei diritti),
quando nasce il gruppo Kore. Kore cerca di ritessere un percorso che
aveva visto le protagoniste vicine e lontane, assenti e
contemporaneamente presenti nella vita delle altre. Un percorso che
ha segnato, ferito, ha mostrato le difficoltà della
trasmissione, la difficoltà del rapporto madre-figlia, ma
anche l’importanza del partire da sé, dell’imparare
a raccontarsi, del riconoscersi l’autorità per farlo,
del trovare delle parole per dirsi l’importanza della
soggettività. Nel gruppo Kore si inizia a leggere i libri di
Diotima, si dedica un intero anno a L’Ordine
simbolico della madre
di
Luisa Muraro: il libro viene letto, discusso, provoca conflitti.
Ognuna delle partecipanti, negli incontri periodici, apre per sé
e per il gruppo nuovi orizzonti in cui il desiderio di fare, di
agire, diventa sempre più impellente:
Adriana
Papaleo mi consigliò di leggere “Non credere di avere
dei diritti”, appena prodotto dalla Libreria delle Donne di
Milano. L’ho letto d’un fiato, era anche la mia storia,
ed era tutta lì in quelle pagine e c’era anche altro,
c’era quello che mi serviva per andare avanti. Così è
nata l’idea di formare un gruppo per approfondire la storia del
femminismo e per capire cos’era questa differenza, la disparità
tra donne, la relazione, la mediazione possibile, il riconoscimento e
la gratitudine, la relazione con la madre. Per prima ho consultato
Maria Grazia e Delia, le antiche amiche udine. Si apriva così
un’altra pagina, era una svolta. Finalmente cominciavo a capire
qualcosa, a decodificare, decostruire e progettare. Insieme alle
amiche del gruppo che si era formato, insieme a quelle che erano
rimaste perché alcune sono presto andate via, abbiamo iniziato
un nuovo percorso, ma forse era solo la continuazione. Dopo aver
letto “Il pensiero della differenza” di Diotima nella sua
prima edizione del 1987, abbiamo deciso di nominare il gruppo con il
nome Kore. Alla fine, le donne rimaste per scelta erano quelle che si
erano scelte; perciò, malgrado i conflitti che costantemente
si accendevano, Kore continuò il percorso di riflessione e
pratica fino alla realizzazione della Biblioteca delle Donne. Secondo
me abbiamo scelto il nome Kore perché ci sentivamo già
nella tensione di figlie in cerca di un percorso che consentisse a
ciascuna una riconciliazione con la propria madre. In ogni caso per
me è stato così. In una riunione del gruppo ho
recuperato l’immagine dell’incontro domenicale di mia
madre con la madre e le sue sorelle. Prima non ci avevo mai pensato,
eppure erano causa di discussioni interminabili tra mia madre che non
vi rinunciava e mio padre che non tollerava di esserne escluso
(Assunta Di Cunzolo)
Il
percorso di formazione e lo stare dentro Kore mi hanno permesso di
rileggere l’esperienza passata alla luce di come io mi andavo
trasformando; mi sono resa conto in realtà di come ero stata
lontana da me come donna, nel senso che il mio essere donna, lo stare
dentro un corpo sessuato, il pensiero che il mondo è fatto di
generi, di uomini e di donne, questo nel mio orizzonte, fino a quel
momento non l’ho avevo contemplato; e ho guardato tutto il mio
percorso all’interno della politica, fino
a quel momento, come una persona senza sesso o, comunque, consegnata
a piene mani all’idea di questo partito-padre, con tutta la
mentalità e le pratiche che c’erano dietro, e con poca
coscienza di genere da parte mia. Abbiamo fatto un grosso lavoro
dentro Kore; perché poi Kore è stato un laboratorio di
idee, oltre che di pratiche […] La
differenza generazionale non è mai pesata e poi non è
neanche così grande. Forse avrebbe anche potuto esserci se
quello che ci univa era magari rappresentato da altri interessi, però
quello che ci ha unite è stato l'interesse attorno a questo
dato fondamentale e fondante, che è il nostro essere e
riconoscersi soggetto sessuato, col desiderio di costruire un luogo
di pratiche e di pensiero a partire dalla nostra identità, per
cambiare lo sguardo su noi stesse e sulla realtà che ci
circonda. Allora, probabilmente, proprio perché l’interesse
era questo, la differenza generazionale non è mai stata un
dato rilevante nei nostri rapporti. Ricordo la passione dei primi
anni, la passione della lettura – perché noi facevamo
proprio questo; intanto eravamo un piccolo gruppo che era stato
scelto da una donna, Assunta, sulla base di un progetto, di un
desiderio, che avevamo condiviso. Il lavoro che facevamo, almeno nei
primi anni, era quello di incontrarci quasi settimanalmente, di
leggere, di discutere sulle letture fatte, e la cosa ci tirava
talmente dentro, sia intellettualmente che come messa in gioco delle
proprie vite personali, che probabilmente non c’era spazio per
questo discorso della differenza generazionale. Perché
comunque eravamo tutte figlie, infatti uno degli argomenti forti che
abbiamo discusso è stato quello del rapporto madre-figlia, e
lì eravamo tutte figlie. Intorno a questo rapporto c'è
stata una grossa discussione all’interno di Kore, con una
grande vivacità ed anche una non univocità di pensiero
perché, pur riconoscendoci e avendo approfondito quelle che
erano le teorizzazioni del pensiero della differenza a partire dai
testi del gruppo Diotima e della Libreria delle Donne di Milano, che
alcune condividevamo in pieno ( e io mi riconosco fra queste), altre
tra noi, pur partendo e riconoscendosi in questo pensiero, ponevano
delle accentuazioni e delle pratiche anche diverse. Rispetto a questo
ci sono state delle discussioni intense, anche accese, nelle quali ho
cercato di avere un ruolo di mediazione (politica, di relazione e
anche di pensiero). E quel documento che c’è in Tempo di
Marea, il documento di Kore, riassume quest’opera di
mediazione, e cerca di costruire un percorso, un pensiero
comune,rispetto a quelle che erano le nostre diverse posizioni,
soprattutto rispetto alla discussione, che per un anno abbiamo fatto,
sul libro di Luisa Muraro, “L’ordine simbolico della
madre”. […] Di questi anni, ho il ricordo di un gruppo
molto vivace, che poi a un certo punto ha fatto lo spostamento dal
pensare fra noi all’apertura anche all’esterno. C’erano
delle richieste che venivano da parte di altre donne esterne al
gruppo che ci sentivano punto di riferimento, allora abbiamo
organizzato una serie di seminari. (Maria Procopio)
L’esperienza
ormai consolidata del rapporto fra donne porta al desiderio di
moltiplicare i momenti di condivisione di vita e di lavoro, gli spazi
dove incontrarsi, discutere, riflettere e vivere il patrimonio di
riflessioni maturato negli anni precedenti: prende forma «una
genealogia di donne, ossia un venire al mondo di donne legittimate
dal riferimento alla loro origine femminile» (Libreria delle
donne: 1987: 9). Alcuni desideri sono solo di un gruppo (ad esempio
il desiderio della rivista, che ha visto alcune di Kore impegnate in
Mediterranea
e poi, in un secondo momento, in Tempo
di Marea).
Un gruppo descritto anche come conflittuale, in cui il conflitto
arricchisce, fa crescere, trasforma:
In
Kore, tra Delia e Fulvia si accendevano costantemente conflitti che
allora mi sembravano guerre perché io ne uscivo distrutta;
oggi so che sono l’esempio di come ci si può
contrapporre con le idee senza offendere e senza distruggere ma
crescendo insieme a dispetto delle reciproche e -forse o non forse
apparenti- incompatibilità. Fulvia è sempre stata un
vulcano di iniziative e una ‘scopritrice di talenti’.
Patrizia Greto e Fulciniti, e Giovanna Veneziano, che ha portato in
Kore, hanno avuto da lei ascolto, attenzione e incitamento a
realizzare sogni, speranze, aspirazioni. Io credo che attraverso Kore
– attraverso le altre di Kore- ciascuna di noi sia riuscita a
trovare il modo per rendere possibile qualcosa per sé
importante (Assunta Di Cunzolo)
E’
stata una grande palestra di gioia. Io ho imparato a portare avanti
le mie idee, anche in contrasto con un’altra, ad ammirarle
profondamente, a vederlo quasi come un gesto di stima il dissenso.
Questo a me ha fatto crescere tantissimo, mi ha fatto passare la
paura del dissenso, sempre però a motivarlo, a rispettare
l’altro […]L'esperienza di Kore è molto bella, di
orgoglio anche. Noi veniamo
avvertite dalla popolazione...dicevano: quelle di Kore. Noi quattro
gatte eravamo! Ma ne parlavano come se noi fossimo state un esercito.
L'autorevolezza conta tantissimo. Ovviamente ne potevano parlare nel
bene e nel male, però c'era sempre questa idea. Noi dicevamo:
“noi di Kore...” e abbiamo sempre usato questo plurale in
un modo bello, di assunzione. Oggi siamo tutte quante nella
Biblioteca (Fulvia Geracioti)
La
parola
assume sempre più centralità, attraverso la pratica
della lettura e della scrittura, che fa parlare il silenzio e assume
carattere generativo:
Noi
abbiamo letto di tutto e commentato tutto. Questa apertura è
anche un segno della differenza, e anche questo è un segno
della Grande Madre. Noi abbiamo preso sul serio le donne della
Puglia, di Verona, di Roma (Luisa
Boccia è venuta un
paio di volte(forse non era
Boccia???), noi le abbiamo
prese sul serio. Le abbiamo riprese, le abbiamo portate da noi, le
abbiamo ospitate, cosa c'è di più specifico di questo?
Io lo vedo in questa capacità di accogliere pensieri diversi,
di dargli ascolto, di elaborare i propri - a volte prendendo, perché
no?, quando un pensiero ti convince diventa tuo -, in questo io vedo
la nostra ricchezza. C'è ovviamente un altro pericolo, che
diventiamo suddite...in che senso...ma forse adesso non più...Si
diventa suddite di un pensiero pensato altrove. Le specificità,
quando le vai a sviscerare, le vedi là dove nascono, diventano
universalità. Non nel senso maschile, diventano 'larghe',
diventano Madre, diventano Tempo di Marea [..] Adesso, guardando
indietro, io noto che avevo un pensiero così lucido, così
articolato, che avrei potuto fare…qualsiasi cosa al mondo.
Trascinavamo noi la gente qui, non eravamo meno di nessuno […]
Mi viene in mente Tempo di marea perché è un momento in
cui sto leggendo Mary Daly, “le donne di marea come
uccelli...”, che noi scriviamo all'inzio della rivista; e mi
piace questa idea del tempo di marea perché mi riporta a
questo respiro della terra, un'idea panica. E' stato un parto molto
rapido, ci incontriamo 3 giorni da Assunta a San Vito e vengono donne
della Puglia, tutte queste donne di cui mi ero circondata in questi
viaggi...le invito e decidiamo di fondare Tempo di Marea. Ci sono
delle differenze tra di noi. La mia scommessa è sempre quella
di tenere insieme le differenze; con alcune ci riesco, con altre no.
Alcune vengono da gruppi più strutturati che temono...non so
se la confusione o altro. E comunque facciamo la rivista; cominciamo
con un editoriale che sono gli editoriali, nel senso che riconosciamo
che ognuna possa dire...lasciamo le pagine autogestite, lasciamo che
ognuna si esprima per sé. A me è sembrata un'idea
bellissima quella di utilizzare il nome delle madri, negletto.
Siccome il cognome era comunque il cognome paterno, che fossero vive
o morte noi diciamo il nome delle madri...io sono Fulvia Geracioti di
Iolanda (Fulvia Geracioti)
Oltre
alle parole, anche momenti e dimensioni di vita in comune che pongono
la socialità e le emozioni al centro della scena. Si
sperimentano attività e momenti di vita in comune,
condivisione di vacanze e tempo libero:
Allora
facciamo la prima settimana...il primo plenilunio tra luglio e agosto
– molti mariti che sono divenuti amici vanno a fare trekking,
mancano due-tre giorni – chiamiamo le altre...c'è la
luna, ci mettiamo la Norma, un classico! Ci mettiamo la preghiera
alla luna, beviamo...E' un momento di estrema felicità. Sono
amiche di tutta Italia, vengono in particolar modo da Catania, da
Firenze, da Roma, da Milano, a volte anche da Torino. Tra noi diciamo
che da tempo vogliamo avere...non un'associazione, noi ragioniamo
sempre in termini di gruppo, io ragiono sempre in termini di 3-4
persone (Fulvia Geracioti)
La
scomparsa del movimento delle donne dalle piazze non coincide quindi
con la sua fine, ma con una profonda trasformazione. Si riafferma
attraverso lo studio, la riflessione, un diverso modo di rapportarsi
alle istituzioni. Il desiderio di riprendere a fare politica si
esprime, nei primi anni Novanta, con il progetto della Biblioteca
delle Donne che diventa luogo politico innovativo, nel quale
concretizzare l’esperienza della pratica dei rapporti tra donne
in spazi collettivi in cui i tempi della politica, del quotidiano e
dell’elaborazione teorica potessero intrecciarsi in un progetto
comune. La Biblioteca nasce dall’esigenza di creare una rete
tra saperi femminili, nella consapevolezza che non si costruisce
conoscenza vera se non partendo da sé come corpi concreti, nel
cercare anche tra percorsi individuali lontani fra loro per approccio
intellettuale, esperienza storica e individuale, un filo comune che
possa indicare una storia ed una collaborazione collettiva:
Qui,
in questa specie di laboratorio politico, è stato possibile
concretizzare l’idea Biblioteca delle Donne di Soverato, che
nasce in Kore e viene realizzata in collaborazione con un numeroso
gruppo di amiche della FIDAPA di Soverato. Era il 1992, Marisa
Rotiroti da allora ne è la coordinatrice perché più
di tutte ne aveva desiderato la realizzazione e la Biblioteca è
alloggiata nel Palazzo di Città. La collaborazione tra le due
associazioni così diverse tra loro sembrava una scommessa,
eppure ancora continua e oggi per me Eva, Francesca, Anna, Lilly,
Rosalba, Vanna, Tina e Paola non sono più le amiche Fidapa ma
sono le amiche della Biblioteca con le quali condivido un percorso di
oltre dieci anni insieme alle vecchie amiche di Kore; grazie al loro
costante sostegno ho potuto affrontare con sufficiente serenità
l’esperienza in contemporanea nel governo della Città
(Assunta Di Cunzolo)
L’occasione
è stata fornita da un dibattito pubblico sulle figure di
Antigone e Ismene, che Lilly Rosso, Vanna Peronace, Francesca
Lovecchio, Emanuela Pennacchi ed io (il direttivo di quegli anni)
avevamo organizzato per l’apertura dell’anno sociale, con
la condivisione di tutte le socie Fidapa. L’idea è nata
dal seminario di Delia Fabrizi “Clitennestra e le altre”.
Delia, ispiratrice del seminario – dibattito è stata,
naturalmente, relatrice sulle figure di Antigone e Ismene e ci ha
raccontato il suo incontro simbolico con queste due donne. E’
stata un’esperienza molto bella: gli interventi delle fidapine
e korine hanno evidenziato un comune sentire, pur nella diversità
dei percorsi individuali e politici. Il dibattito fervido e
appassionato di quell’incontro e di quelli successivi, anche
all’interno dell’associazione, mi hanno dato la
sensazione che la nostra Fidapa fosse diversa dalle altre, anche un
po’ anomala; un esempio: in Fidapa si discuteva di “Donne
e Potere” nel movimento delle donne si discuteva di “Potere
e Autorità femminile”. Le donne della Fidapa di Soverato
discutevamo, ci interrogavamo e riflettevamo attraverso dei seminari
tenuti da donne (era stata una nostra precisa scelta per valorizzare
i saperi femminili: Renate Siebert – Lina Santoro –
Fulvia Geracioti – Noemi Saggioli - Rosa Tavella – Maria
Procopio- M. Caterina Iacobelli- Nadia Alecci) e sugli articoli della
rivista “Tempo di Marea”. In un incontro aperto al
pubblico “La donna e la città” (con Assunta Di
Cunzolo – vice sindaco, Marika Caruselli, Fidapa, prima
presidente della Provincia donna, Carmela Apollaro del Consiglio
delle Donne di Firenze, Marisa Gigliotti, urbanista, si è
discusso del giusto senso della politica intesa come possibilità
di….e non come dominio – controllo (erano gli anni di
Tangentopoli e c’era una grande voglia di cambiamento, che a
Soverato si era verificato con il governo del Movimento “Pedalando
Volare” guidato dal Sindaco Gianni Calabretta e Assunta vice -
sindaco.). In quell’occasione feci la proposta, accolta, che
nello Statuto del comune di Soverato venisse inserito il Consiglio
delle donne. Era, in definitiva, una Fidapa aperta al pensiero della
differenza, lo accettava e cercava di comprenderlo. Era già
iniziato il nostro percorso insieme con le donne di Kore (Assunta Di
Cunzolo, Fulvia Geracioti, M. Grazia Riveruzzi, Viviana Santoro,
Delia Fabrizi, Maria Procopio, Teresa Ciaccio, Patrizia Greto) con le
quali avevamo fatto il progetto Biblioteca e con le quali noi, le
dieci donne della Fidapa che ci eravamo autoproposte per la gestione
della Biblioteca (Lilly Rosso, Rosalba Aversa, Eva Winser, Angiola
Alferazzi, Tina Alvaro, Vanna Peronace, Paola Nucciarelli, Anna Sia,
Francesca Lo vecchio ed io, che facevo parte di entrambe le
associazioni) ci riunivamo a discutere di temi che di volta in volta
sceglievamo (potere e autorità – riconoscimento tra
donne, – invidia e gratitudine – tema tratto dalla
lettura del testo di Melanie Klein). Questa pratica di discussione
tra di noi è stato il contributo che le donne di Kore hanno
portato nella Biblioteca, mentre tutta l’organizzazione interna
ed esterna della Biblioteca è stato il contributo portato
dalle donne della Fidapa. Sono stati anni ricchi e fecondi di
riflessioni e di incontri tra le donne delle due associazioni e con
le donne delle istituzioni (Marisa Rotiroti)
Ho
avuto rapporti abbastanza superficiali con varie associazioni
femminili, ma il rapporto più intenso è stato, ed è,
col gruppo Kore, perché insieme abbiamo costituito la
Biblioteca delle Donne. Il nostro rapporto, piuttosto continuo, mi ha
dato la possibilità di scoprirmi per assumere consapevolmente
il mio ruolo tra loro e mi ha permesso di focalizzare l’inesauribile
ricchezza dell’incontro/scontro, di evidenziare il profondo
valore sia di una scelta critica, che della discussione su alcuni
problemi per proiettarci insieme nel futuro, su orizzonti più
vasti. Io penso che le due associazioni finora, Kore e Fidapa,
abbiano lavorato bene, e in sinergia. C’è stato fra di
noi, come all’interno della Fidapa, uno scambio continuo di
idee, e, nella nostra eterogeneità, abbiamo saputo trovare una
certa univocità, combattendo ogni individualismo per la parità
dei diritti di ciascuna di noi. La cosa più bella e più
proficua consiste che io non faccio nessuna differenza fra l’amica
della Fidapa, fondata da me, e scelta nel gruppo molte volte da me, e
l’amica del gruppo Kore, che mi sono ritrovata così per
caso. Tutto questo grazie alla nostra comune intelligenza che ci fa
superare, comprendere, e anche apprezzare l’amica che la pensa
in modo diverso ma che, in un certo senso, ci invita a riflettere sul
proprio pensiero e modo di essere e alla fine ci influenza in
positivo. Il gruppo ha influito positivamente sul mio Io, perché
mi ha dato quello che io non avevo o che non vedevo in me; mi ha
invitato ad un’analisi più attenta e più profonda
di me stessa (Francesca Lovecchio)
Cosa
si ricorda degli anni precedenti? Sicuramente una profonda amicizia
tra molte delle protagoniste; un’amicizia senza troppe
indulgenze ma forte, un ‘sentimento’ più che una
relazione, perché le esperienze quotidiane non vedono le
intervistate (almeno non tutte) insieme:
Le
nostre vite, a un certo punto, hanno portato ognuna di noi per una
strada diversa, un percorso proprio, alla ricerca di un percorso
proprio. Mantenendo, però, con la maggior parte, un rapporto
affettivo, un legame affettivo, anche se non più una
frequentazione; però il legame sì (Delia Fabrizi)
Molti
successivi percorsi politici sono stato
intrapresi nel proprio lavoro, nella propria quotidianità, in
contesti a volte sorprendenti. I presupposti dei primi anni del
movimento vengono a cadere (la mobilitazione collettiva, le relazioni
con altri gruppi), ma rimane un punto di riferimento teorico e
pratico all’esperienza vissuta, sia esso declinato nella vita
professionale e politica, sia privata e sociale, come senso di
appartenenza ad un patrimonio comune di impegno e di produzione
intellettuale:
Adesso,
insieme a Teresa, stiamo seguendo la rivista “Ore 11”. E'
una rivista di spiritualità e antropologia, soprattutto è
un percorso di consapevolezza di sé, c'è un discorso
comune che riguarda la persona, dell'appropriarsi di se stessi. E' un
percorso che è iniziato da 4-5 anni, il rapporto con le suore
dell'Oasi Bartolomea di Lamezia Ho un po' di difficoltà a
parlare di questo perché probabilmente non riesco...è
talmente una cosa originale e nuova che mi sembra di non riuscire a
trovare le parole per dirlo, perché c'è una laicità
e un'apertura...Io sono non credente, almeno per ora, io e Gabriella
siamo in un orizzonte assolutamente laico. Trovarci in questo ambito
così straordinario per i temi che affronta - dal discorso
politico sullo sviluppo sostenibile, al discorso sugli stili di vita
- ci sorprende; anche perché poi là vai a trovare anche
le cose dalle quali sei partita. Quando si parla di stili di vita
diversi, e si parla di tempi lenti, e dei valori della cura, sono
tutti temi che riguardano noi donne. Quindi io sono molto immersa in
questo percorso. Questo gruppo che si forma presso l'Oasi Bartolomea
è un gruppo tutto di donne, ma non è che è nato
tutto di donne; era nato come gruppo misto e adesso sono rimaste le
donne a parlare e a pensare e a prendere il passo del Vangelo e a
commentarlo. Abbiamo avuto una teologa che ci ha dato moltissimo,
senza parlare mai di Dio, ma parlando a partire da sé, quindi
tutto quello che è la presa di coscienza su di sé, i
limiti e la propria fragilità in relazione con gli altri.
Questi sono solo dei frammenti che ti sto dando, perché è
un'esperienza tuttora in corso. Non so dove andremo e comunque siamo
su questa strada (Loredana Rubino).
Quando
sei sopraffatta da esigenze di lavoro in un settore così
delicato come quello dell’ospedale, è difficile avere
una relazione di comprensione anche con le donne. L’esempio
concreto: quando le donne si assentavano perché qui c’era
una realtà economica particolare; le infermiere che venivano
qui a lavorare avevano alle spalle una tradizione che non era quella
del nord o di altre realtà…qui c’era il pomodoro
da fare d’estate, la sardella da fare non so quando, il maiale
a dicembre…ti sembrerà incredibile, ma le assenze di
questo tipo cozzavano terribilmente con la mia mentalità e la
mia concezione del lavoro. Vai quindi a conciliare la comprensione
dell’altro con la necessità di mandare avanti il lavoro
dei reparti e di assistere i malati... Allora io sono scoppiata,
perché sono diventata ipertesa, perché ero immersa in
questo problema, e non riuscivo…Molte giovani donne, appena si
sposavano rimanevano incinte, e si assentavano dal lavoro, ma non
erano sostituite. Io mi ricordo che uscivo con il mio motorino,
andavo nelle strade di Catanzaro, a cercare le infermiere a
implorarle di venire a coprire gli orari di lavoro. Una realtà
quotidiana, per cui diventavano quasi tue nemiche. Tu dovevi mandare
avanti il lavoro…tanto che nell’87, disperata, per
questa situazione legata non a me, ma all’organizzazione del
lavoro, politiche che venivano fatte….io mi sentivo incapace
di uscirne, perché non ero capace di gestire questa cosa…e
nell’87 sono venuta via. Avevo già 30 anni di lavoro
alle spalle e sono venuta via con il pensiero di aver subito uno
scacco enorme. Il femminismo non mi ha aiutato in questa esperienza
dura del lavoro; mi ha aiutato in un secondo momento, quando ormai
ero venuta via. Ci fu un giornale, elaborato dalla Libreria delle
Donne di Milano, che parlava dello scacco delle donne, della
sconfitta delle donne, e che questa sconfitta era perché
vivevamo molto in questa dimensione maschile, dove il modello di
lavoro è il modello maschile, per cui noi eravamo
disorientate, ma non era mai uno scacco individuale…io invece
l’ho vissuto come scacco personale, per cui mi sono sentita
sconfitta. Quando sono andata via dall’ospedale, dopo breve
tempo, mi sono guardata intorno…il femminismo era passato,
ognuna di noi era tornata nel proprio guscio…e allora per
alcune fu un dolore terribile – questo rientro nella normalità
e nel chiuso – pensa il femminismo cosa poteva significare
quando noi uscivamo di notte per riappropriarci della città,
uscivamo tutte insieme a cantare per la città…Mi sono
guardata intorno e ho cominciato a vedere delle donne che andavano
nei nostri vicoli, tutte le mattine, e mi chiedevo cosa andassero a
fare; ho chiamato una di loro un giorno e ho chiesto cosa facessero,
mi hanno risposto che andavano a fare volontariato nel quartiere. E
allora mi sono accostata anch’io. Nello stesso tempo, mi è
stata data l’opportunità di fare questo corso su azioni
positive e pari opportunità organizzato dalle Acli in
Calabria, con un gruppo di donne straordinarie di Arcavacata (Renate
Siebert, Donatella Barazzetti ecc.), forse sarà stato l’89/90,
è stato interessantissimo, perché è stata la
critica di un percorso, anche di anni di grande dolore. E qui ci
siamo riallacciate alle tematiche del femminismo, in una maniera
diversa; allora le pari opportunità ci parevano cose
importanti da fare…le varie discriminazioni che esistevano sui
luoghi di lavoro ecc.. Ma quello che è stato importante è
stata l’opportunità di aver lavorato per tre mesi
intensi per ritrovarci con dei gruppi di donne. Erano donne tutte più
giovani di me (insegnanti, architette ecc.), persone che venivano da
esperienze diverse, e alla fine di questo corso eravamo talmente
cariche di entusiasmo che siamo andate a costituire Le Lune. Con
questo gruppo abbiamo fatto delle cose importanti, dei seminari con
Anna Rossi Doria, Dacia Maraini…per dir la verità non
abbiamo mai fatto nulla sulle azioni positive e le pari opportunità,
forse l’unica è stata Anna Scalzo, a Villa Betania; lei
era sindacalista e lavorava ancora…per me le azioni
positive…io ero già fuori dal mondo del lavoro e mi era
molto difficile mettere in atto quello che avevo imparato! E’
servito più che altro, quel corso, a ritrovarci per stare
insieme, per entusiasmarci rispetto a delle cose che potevamo fare
insieme. Quel corso è stato importante per l’incontro
con queste donne straordinarie di Arcavacata e per gli incontri
stimolanti che abbiamo avuto, ma poi, per quanto personalmente mi
riguarda, al di là di questi seminari non ho potuto utilizzare
quel sapere che ci avevano dato perché io ero fuori dal mondo
del lavoro. E invece sono entrata a pieno ritmo nel mondo del
volontariato; il quartiere è stata una scoperta
interessantissima, entrare nelle case del quartiere, conoscere le
donne e gli anziani, diventare loro amica; conoscere la storia delle
persone, con i loro dolori, le loro gioie...tutte le porte si
aprivano...abbiamo vissuto dei momenti esaltanti. Questa del
volontariato è stata un'esperienza forte, poi sono andata al
Centro di solidarietà, dove ho fatto praticamente
l'infermiera, per un anno e mezzo ho fatto tutte le mattine i
prelievi ai ragazzi, alla comunità di tossicodipendenti, li
accompagnavo in ospedale, mi occupavo di loro completamente; e poi il
direttore della Caritas mi ha chiesto se volevo occuparmi del
volontariato in carcere, e lì sono rimasta 10 anni; da due
mesi ho interrotto per un problema al ginocchio. Sono stati impegni
che mi hanno arricchito di altre esperienze, di altri aspetti della
società (Lorenza Rozzi)
La
difficoltà che traspare è l’impossibilità
di ricomporre i diversi mondi che si abitano in una visione unitaria;
la difficoltà di declinare una politica che traduca la
complessità in un discorso comprensibile ed unificante. Quello
che i gruppi di donne hanno sicuramente prodotto (disperso?
trasmesso?) è un’idea della politica al plurale, dove il
confronto avveniva sulle discussioni e sulle realizzazioni, dove ci
si sentiva più soggetti che rappresentanti, capaci di
(ri)mettersi in discussione e sempre capaci di forti passioni e
reciproca consapevolezza. I percorsi dell’oggi sono vari: c’è
chi si occupa della famiglia, chi lavora negli uffici, chi dirige o
insegna nelle scuole, chi cura i malati, chi si occupa di
volontariato. Il filo rosso che unisce queste esperienze è
l’intensa pratica nel/del quotidiano: gli anni Settanta dei
movimenti, che sottopongono a critica radicale la contrapposizione
fra pubblico e privato, tra personale e politico (l’organizzazione
della vita materiale, l’oppressione del lavoro domestico e
delle relazioni familiari); gli anni Ottanta della svolta verso una
ricerca identitaria di una differenza femminile irriducibile, con una
propria cultura, un proprio linguaggio e una propria genealogia; gli
anni Novanta, infine, con i percorsi frammentati della politica delle
donne, ma anche con le relazioni fra culture differenti in un
movimento sempre meno legato alle appartenenze, e fra soggetti fino a
quel momento rimasti estranei all’esperienza dei gruppi
storici.
I
nessi fra le esperienze personali e collettive di donne diverse fra
loro emergono continuamente nei racconti delle intervistate: un
legame (fra donne fortemente politicizzate, estranee al femminismo
storico, generazioni che si susseguono) che sembra ritrovarsi nella
comune persistenza delle asimmetrie di potere fra i sessi. Altro
tratto comune sembra essere la continua ricerca di luoghi delle
donne. Dalla casa privata, al consultorio, alla libreria, ai
convegni, alla Biblioteca, tutto concorre a dare riconoscimento e
visibilità ai corpi, alle pratiche, ai saperi delle donne, fra
tradizione politica e percorsi di vita individuali. Percorsi che
spesso ritornano su se stessi, per continuare a capire il presente, e
progettare il futuro, attraverso la memoria delle esperienze passate:
L’UDI
si è ricreata, come struttura, una responsabile di sede
nazionale – che poi è anche la sede dell’archivio
centrale dell’UDI – e si è creato un coordinamento
nazionale di 10 persone, di cui io faccio parte che dovrebbero
raccogliere le istanze, individuare degli accordi, delle
problematiche che poi creino una sorta di base per una discussione
collettiva. Una sorta di raccordo…non possiamo dire che siamo
quelle che diamo la linea, che siamo un comitato direttivo come era
una volta, però sicuramente siamo un punto di riferimento
cruciale, di una politica che si vuole, non dico nazionale, ma
perlomeno collettiva, riconoscibile a Milano come a Palermo; pur
nella consapevolezza che Palermo, per dire, avrà sempre la
necessità di commisurare la questione delle donne, della
società femminile, con i problemi reali. E Milano pure. Quindi
il tentativo è quello, di ridare questo respiro univoco, e
costituire questo punto di riferimento interpellando le donne delle
varie realtà locali su come loro pensano di calibrare queste
necessità, queste grandi questioni che ci riguardano tutte,
questo scenario che si prospetta, nella loro realtà, con i
problemi che devono concretamente affrontare. Quindi la scommessa è
questa, provare ad accumulare le domande, le chiavi di lettura per
questo nuovo scenario che si prospetta, in cui le donne, se ci fai
caso continuano…anzi, hanno cominciato ad essere, la posta in
gioco di uno scontro…non vogliamo dire di civiltà, ma
sicuramente uno scontro economico, di interessi che usa come pretesto
il corpo femminile, paradossalmente. Il corpo femminile, velato o
svelato, è il campo di battaglia nuovo. Allora, se noi non
siamo in condizione, attraverso quello che abbiamo imparato, appreso,
discusso, riflettuto, ragionato fra noi, di provare a mettere a
disposizione, e nello stesso tempo confrontare queste chiavi di
lettura, questi strumenti, con queste donne che entrano in Italia,
con le loro tradizioni, con la loro formazione, con i loro progetti
di vita, allora è una politica che….si capisce perché
molti dicano che non serva più; perché se il femminismo
è politica dei tuoi diritti, e tu li hai ottenuti, o al
massimo ti devi preoccupare di massimizzarli, il discorso si chiude.
Quando invece ti accorgi che adesso veramente è di nuovo su
uno scenario collettivo che ti devi misurare, non devi pensare solo
alle nuove generazioni, ma a che cosa tu puoi determinare sul piano
culturale, rispetto agli stereotipi che stanno tornando (Annalisa
Marino)
Altri
percorsi scelgono il silenzio pubblico, che amplifica, nelle
intenzioni, il discorso interiore e rifugge la gerarchia e la fissità
delle organizzazioni formali:
Io
ricordo bene, positivamente, quelle esperienze, ma anche con un certo
malessere, le ansie da organizzazione. A me il pensiero della
differenza mi ha fatto capire molto questo, e io l'ho molto
interiorizzato. Ritengo che comunque basta anche esistere, e
trasmettere uno stile di vita diverso, per incidere e trasformare. Io
ho abbandonato totalmente l'ottica direttiva, pedagogica, fare
qualcosa per le donne, per la città, per l'ufficio. Sono
entrata in un'ottica di idee diversa, che è quello del prima
di tutto “per me”. Io l'ho detto e lo dirò ancora
a chi mi sta vicino e può essere interessato. Ma può
essere interessato nel senso che magari mi domanda: “Dove sei
stata in questi giorni?”; e allora la mia assenza, se stimola
qualcosa, allora se vuole venire viene. Io però ho perso
totalmente questo discorso organizzativo, non mi corrisponde. Credo
che derivi molto dall'interiorizzazione del pensiero della differenza
e da questo percorso. Questo non significa che non si possa “fare”,
ma è un fare in modo diverso. Ognuno di noi ha un piccolo
potere nella nostra persona, e io quel potere piccolo che posso agire
lo agisco, però sempre senza parlare in nome di altre donne,
mentre invece nel passato abbiamo fatto molto questo. Ma naturalmente
era quello il momento storico, non si poteva fare diversamente.
Questa cosa qui è stata messa in discussione, perché
nessuno può parlare a nome delle altre donne, ognuno parla per
sé (Loredana Rubino)
Cosa
rimane negli anni Novanta e oltre? Se i gruppi di donne, negli anni
precedenti, hanno seguito la via della rivendicazione di diritti e
dell’antagonismo e della critica nei confronti dello status
quo, oggi
emergono nuove strategie per il cambiamento, in ambiti spesso
diversificati. Mutati i codici culturali tradizionali, il movimento
delle donne ha messo in atto un processo di istituzionalizzazione
che, tuttavia, può essere letto con l’immagine
dell’outsider
within,
tipico della metodologia femminista (Hill Collins, 1986): confronto
con le istituzioni, non riducibilità ad esse.
Relazioni
e conflitti
Il conflitto si situa sin
dall’inizio all’interno dei movimenti: le organizzazioni
della sinistra extraparlamentare vengono attraversate in maniera
dirompente dalla nascita del femminismo, vivendo una serie di
contraddizioni legate alle logiche di potere, tipicamente maschili,
utilizzate nell’organizzazione. Di fronte alla prospettiva
della rivoluzione, le donne scoprono che la loro condizione era
immutabile, che il potere maschile si ricomponeva di fronte all’altro
sesso, che la sessualità liberata si configura spesso come
violenza, che la gravidanza significa solitudine, «ciò
che rientrava nella sfera sessuale continuava ad essere «un
problema di donne», mentre i maschi, seppure «rivoluzionari»,
non se ne facevano carico, ritenendosi esonerati dall’assunzione
di responsabilità, non diversamente dai loro padri e nonni»
(Ribero, 1999: 95-96). Dal 1976 in avanti, con lo scioglimento di
quasi tutte le formazioni della sinistra extraparlamentare, emerge
per le donne di questi gruppi l’esigenza di dare un significato
politico al conflitto con i propri compagni: «si erano occupate
per anni della subordinazione dei proletari o dei popoli oppressi di
tutto il mondo, ora iniziavano a concentrarsi sulla propria»
(Ribero, 1999: 170).
Il
Congresso di Lotta Continua [nel 1976] è stato un momento
decisivo. E' stata una cosa così...nel senso che c'era il
solito gruppo dei dirigenti, che si trovavano nei corridoi, dietro le
quinte, per manovrare le cose, fare e disfare, per il primo giorno e
poi le donne ci siamo trovate, tutte quelle che eravamo lì,
tranne forse due o tre che facevano parte della dirigenza, e non
erano considerate donne ma spie; e lì è cominciato un
processo sconvolgente, che io mi ricordo come enorme, ma in realtà
è durato pochissimo, di crescita pazzesca, perché
abbiamo cominciato a dire: “e però, dobbiamo prendere la
parola”, “io vorrei dire questo” e un'altra diceva
“e io vorrei dire questo”, allora andiamo a dirlo! Si
chiedeva la parola e si cominciava un discorso anche molto...è
stato proprio un trasformarsi, nel senso che all'inizio era un dire
“non è possibile, cari compagni, non tenere presente che
c'è una differenza nello stare al mondo delle donne e degli
uomini […] C'è stato proprio un crescendo pazzesco di
persone che man mano sono andate a raccontare la loro sofferenza
nell'organizzazione. Comunque ci sono gli atti, anche se non
esprimono a fondo questa cosa. I maschi non hanno più preso la
parola, un silenzio assoluto in sala, gente che piangeva, anche
maschi che piangevano, è stata una sorta di...emersione, di
che cosa ha significato, dentro l'organizzazione, l'oppressione delle
donne. E questo è stato straordinario per tutte, secondo me,
perché ha proprio fatto venire fuori proprio “il
personale è politico”, lì si è toccato con
mano che cosa volesse dire questo, perché nelle relazioni
personali, nelle tue aspettative individuali (di fare un figlio, di
non farlo) […] Sono venute fuori tutte queste dimensioni,
anche di oppressione sessuale, che hanno fatto esplodere la
situazione a un punto che a un certo punto gli operai di Torino si
sono alzati in piedi e sono venuti verso il palco per picchiarci. E
lì c'è stato uno sbarramento di altri che si sono messi
in mezzo e glielo hanno impedito, ma era una tensione pazzesca […]
Insomma, era proprio una rivisitazione di un percorso politico
attraverso il fatto che quel percorso lottava per trasformare il
mondo e contemporaneamente era una dimensione di dominio totale su
una parte del movimento stesso (Donatella Barazzetti)
Il
contrasto tra chi voleva un collegamento immediato con la lotta di
classe, le relazioni familiari e di coppia che implodono, si
accompagnano ai contrasti teorici legati alla dimensione
emancipazione/liberazione, alla teorizzazione della differenza
sessuale e del rapporto con le altre differenze. Nella provincia di
Catanzaro, la teoria della differenza sessuale assume una centralità
sempre maggiore, diventando oggetto di dibattito serrato, e ponendosi
in netto antagonismo rispetto ai discorsi emancipazionisti degli anni
Settanta. A questo si aggiunge il problema delle relazioni tra donne
femministe, ma appartenenti alle organizzazioni extra-parlamentari, e
le donne del femminismo radicale, con le quali le divergenze si
esprimono nel rapporto con la politica, con la militanza, con la
necessità di privilegiare aspetti personali o tematiche
sociali. Ed ancora, la difficile scelta delle donne impegnate
all’interno dei partiti che ne avvertono i limiti e le
resistenze, ma che rimangono legate all’organizzazione, a volte
rinunciando ad un percorso individuale. Alcune scelgono la doppia
militanza come l’unico modo di «garantire l’autonomia
delle compagne e quelle del movimento dal pericolo di ricreare da un
lato la commissione femminile, il ghetto delle donne, dall’altro
l’avanguardia esterna che va nel movimento a portare la linea
del partito» (Fraire, 2002: 125-126); altre definiscono la
doppia militanza come un falso problema a livello personale, ma
vissuto come contraddittorio dall’esterno, da un contesto che
non riesce a comprendere la potenzialità dell’equilibrio
dentro-fuori:
Quelli
sono stati anche gli anni di esplosione delle critiche alla doppia
militanza nei confronti di chi, come me, era attiva nel movimento e
nel partito. Non mi fu difficile rispondere che io ero sempre la
stessa in qualunque luogo, scuola famiglia partito movimento, e che
ammorbavo i compagni di sezione con continui interventi sulla
ingiusta condizione di noi donne e su quali politiche il partito si
dovesse di conseguenza attivare. Non mi era difficile rispondere e
però le altre non mi volevano credere, forse confermate nella
loro convinzione dal fatto che avevo accettato di essere segretario
della sezione del PCI di Soverato, anche se solo per un anno […]
Ancora oggi Maria Grazia mi rimprovera quella scelta, di aver
lasciato il circolo anche solo per un anno per provare a fare
politica nel luogo misto. Un vizietto, o una presunzione, che mi
corromperà anche dopo, molti anni dopo […] Avevo deciso
di sperimentare nei luoghi istituzionali, i luoghi del potere per
eccellenza, quello che avevo imparato nei luoghi separati del
movimento delle donne. Volevo vedere se lì poteva funzionare,
se era possibile indurre un cambiamento agendo direttamente dentro
l’istituzione e contemporaneamente continuando a frequentare il
luogo separato per non perdere la bussola (Assunta Di Cunzolo)
Il nodo cruciale, più
che la collocazione ‘spaziale’ e organizzativa, è
la categoria stessa di politica, la critica esercitata nei confronti
della sua concezione tradizionale, lo spostamento dei confini tra
politico e personale, privato e pubblicocce si traduce nella
necessità di nuove categorie interpretative, anche della
stessa idea di militanza.
Per
quanto riguarda il femminismo radicale, l’inconscio, il
rapporto ambivalente con la madre, costituiscono la nuova frontiera
da superare, dalla quale si snodano fili diversi di teorizzazioni e
pratiche. In parallelo a questo percorso, conflitti e tensioni
interne ai gruppi, ma anche riconoscimento del rapporto tra donne, il
posizionarsi entro comuni esperienze, «è un modo di
formare la soggettività femminile in primo luogo, con un atto
di sottrazione alla dipendenza mentale dall’uomo, un pensarsi
non più tramite la coscienza storica maschile, ma pensarsi
attraverso quella posizione che si è assunta: donna, da donna
a donna» (Boccia, 1990: 18)
I
nuovi luoghi di parola, la modificazione di sé e del mondo in
cui si vive sono certo momenti di aggregazione e presa di coscienza,
ma anche luoghi imprevisti di pratiche e soggettività che
possono divergere e opporsi. Sono relazioni spesso incandescenti che
si intrecciano: relazioni di singole, relazioni collettive, relazioni
a volte attraversate dalla dimensione del conflitto e del potere.
Cesure e lutti difficili da elaborare, spesso ancora iscritti nelle
esperienze presenti, che tuttavia non ostacolano il lavoro della
conoscenza, ma si riflettono nella lucidità dell’analisi.
Intanto
mi rendevo conto di una cosa: che quando parlavo con un'altra avevo
una lucidità di pensiero sicuramente maggiore di quando
pensavo da sola. E quindi già ho capito che, a livello
energetico, uno più uno fa tre, e che poi inizia una spirale.
E' la Dea in qualche modo che parla, ma non si tratta certo di una
nuova religione...parlo di energia, di spirito....ma vedi non abbiamo
le parole giuste per definirlo per non farla sembrare una religione!
E' l'energia delle altre, perché a me quello che mi viene con
le altre, quella risonanza che sento, non mi viene da sola. Io
capisco che queste relazioni, che comunque c'erano, le colloco in un
certo modo; anche quella con mia madre, con le altre persone, hanno
un senso diverso. Sono spendibili, non fanno più parte solo
del mio patrimonio personale, ma sono un modello che posso ritrovare.
In fondo si tratta di mettere a posto delle cose e poi di darne un
idea insieme alle altre. Solo col popolo delle donne io posso fare
gruppo, e questa idea allora di uscire fuori dal cerchio e di passare
in una relazione più alta più politica. Questo mi dà
l'idea della differenza, e questa è la felicità: quando
tu esci dal tuo e sai che sei inserita in un fenomeno più
grande, che sai che stai facendo mondo, che stai facendo futuro, quel
momento bellissimo, a-temporale, in cui sei passato, presente e
futuro e in cui rompi questa barriera a cui ci ha abituato questo
pensiero logico. E allora lì è stata la felicità.
Penso ora di essere una donna serena, e di non preoccuparmi degli
anni che passano (Fulvia Geracioti)
nell’essere
tutte piene di passione, nel senso di qualcosa che ti prende e ti
coinvolge, in queste discussioni qui – così come nelle
relazioni politiche, nel discorso dell’autorità, che nel
pensiero della differenza parte dal riconoscimento dell’autorità
materna, nel riconoscere l’autorità di una donna; quanto
questo è importante, perché comunque riconoscere
l’autorità di una donna ti mette in una relazione
dispari, perché comunque l’autorità di una donna
è quella donna che ha un di più, e quindi ti svincoli
dall’invidia, se sei capace, perché l’invidia
distrugge i rapporti tra donne; tutto questo, che detto a parole
sembra molto bello…mettere in pratica tutto questo, nei
rapporti vicini, non nei rapporti lontani, crea un fermento molto
vivo. Quindi io di questi anni qui ho proprio questo ricordo, di un
gruppo molto vivo, che poi a un certo punto ha fatto lo spostamento
dal pensare a noi e alle relazioni politiche fra noi – anche
perché c’erano richieste che venivano dall’esterno
di autorizzarci e sentirci punto di riferimento per altre donne…e
quindi l’apertura anche all’esterno, con tutta una serie
di seminari che abbiamo fatto. E poi anche le trasformazioni che
abbiamo cercato di portare nei luoghi in cui ognuna di noi operava. E
quindi…perché quello che è importante del
pensiero della differenza sessuale è che ti costringe ad
ancorarti al luogo in cui sei, alla persona che sei, al momento in
cui vivi…ti devi ancorare alla realtà. Il mondo non lo
trasformi perché c’è un mondo fuori…no.
Come il partito…ci sono gli altri partiti, c’è il
governo, c’è sempre qualcun altro che deve fare
qualcosa. Tu sei qui, e allora c’è sempre qualcuno con
cui te la prendi, con cui discuti, qualcuno che deve fare; invece ci
sei tu, e le trasformazioni partono da te. Sei tu che, nella realtà
in cui operi, devi essere capace…attraverso le relazioni che
riesci a stabilire, la relazione politica con altre donne, a
trasformare il luogo e le relazioni in cui sei. Quindi, non hai
bisogno che a Roma il governo faccia qualcosa, ma nei luoghi in cui
tu vivi e operi, nelle relazioni in cui sei, puoi produrre
trasformazione e cambiamento, se solo trovi un’altra donna con
cui formi una relazione politica, in cui ti dai reciprocamente
libertà (Maria Procopio)
Allo
stesso tempo diventano chiari alcuni problemi, alcuni nodi cruciali
del rapporto tra donne: il problema dell’essere rappresentata
da un’altra, il problema dell’autorità tra donne,
del potere, delle differenze, chi parla e chi rimane in silenzio:
La
Minghetti ci ha fatto leggere “Note sulla femminilità e
le sue incarnazioni” di una psicanalista francese Piera
Aulagnier Spairanì, che ho ancora a casa. C'era un’idea
molto importante: lei sosteneva che se l'invidia diventa un'invidia
positiva, cioè la capacità non di imitare per
distruggere l’altra, ma di vedere quello che fa l'altra, e
farlo nella propria misura, non per scalzare l'altra o per sminuire
l'altra, ma per 'darsi valore' (oggi dico 'darsi valore', allora non
l'avrei adoperato, non era ancora il linguaggio) noi stesse
cresciamo. Ricordo questa cosa...io per anni ho ricordato questa
cosa, che, se vuoi, era quello che poteva essere la sorellanza del
movimento femminista, ma era anche qualcosa di più. Io ritengo
che queste cose, in un gruppo che comunque aveva anche dei problemi
relazionali (diciamolo; perché c'era chi voleva essere leader)
avesse la sua importanza a
dava e ciascuna la possibilità di prendere le distanze (Delia
Fabrizi)
Rifiuto a priori delle
istituzioni patriarcali, del potere istituzionale, di regole
standardizzate, caratteristiche di un’impostazione e un modo di
fare politica descritto come “maschile”. La donna, in
questa prospettiva, non deve concorrere alla spartizione del potere,
ma rifiutare lo stesso concetto, che storicamente si è
affermato come legge maschile del più forte. Non accettare
compromessi con le tradizionali modalità gerarchiche del
potere significa non accettare formalmente che figure leader si
impongano alle altre. In concreto, tuttavia, le figure predominanti
esistono, determinando spesso una situazione di crisi. Se da un lato
la destrutturazione dei gruppi permette il recupero
dell’individualità al loro interno, dall’altro
favorisce nei fatti l’affermarsi di leadership di tipo
carismatico, legate alle capacità personali di seduzione
intellettuale. Seduzione che a volte è criticata in termini
politici, a volte è guardata con sospetto. La perfetta
identificazione con le altre donne si rivela a volte un’illusione,
che svanisce all’emergere delle singole individualità:
[Nel
Centro Lilith] anche lì, naturalmente, tensioni e non
riconoscimenti fra donne. Tutto questo, purtroppo, è stato
segnato anche da conflitti e da relazioni anche dolorose. Questo
senza togliere niente ad alcune delle donne che ha dato comunque il
loro contributo, però le abbiamo avute le tensioni, anche
forti. C'è stato un momento in cui si teorizzava molto questo
discorso della relazione fra donne, di riconoscimento in qualche modo
della madre simbolica. Questo è stato durissimo, nel senso che
si è cadute anche in atteggiamenti un po’ troppo
cerebrali, un po’ troppo teorici, non calati realmente.
difficili da vivere fino in fondo; non liberi, tutto sommato. Quindi
il Centro ha un po’ sofferto di tensioni di questo genere,
sempre le problematiche di mancanza di riconoscimenti reciproci,
questo è stato reale; una difficoltà grande,
soprattutto tra le personalità più forti, a
riconoscersi. E poi una difficoltà a dare continuità, a
dare costanza, a capire un po' che tipo di destino dovesse avere il
Centro, dopo il primo impulso, perché ognuna di noi, presa
anche dalle proprie vite personali, probabilmente ha avuto difficoltà
a mantenere un impegno all'esterno. (Loredana Rubino)
La
cosa che mi è sembrata interessantissima è stata la
lettura di “Crinali” di Paola Melchiorri, perché,
in un certo senso, mi ha aperto gli occhi su quello che ci era
successo a Catanzaro, sul perché questo discorso l'avevamo
portato avanti, ma ci aveva poi completamente tirato fuori. Credo che
questo fatto derivi dalla poca capacità di relazionarci
veramente l'una con l'altra...Affettivamente sì, ma la paura
del giudizio...che tante volte c'era ed era pesante; la paura di non
essere all'altezza (Delia Fabrizi)
Il
Collettivo [di Lamezia Terme]...non ti so dire fino in fondo perché
poi non ha fatto più politica: è morto quasi di morte
naturale. Un po' le persone sono andate via, hanno preso altre
strade, c'è chi si è messa in politica in maniera più
diretta, ci sono stati i conflitti naturalmente (perché
c'erano anche dei conflitti molto forti). Poi, tra l'altro, era anche
facile sconfinare...il privato era politico, però questo
privato che diventava politico...a volte si scambiava la critica dei
meccanismi che oprano nel privato (che è anche una critica
politica) con delle modalità di relazione che poi influivano
nella vita stessa del Collettivo. Anche questo è stato fonte
di crisi (Rosa Tavella)
C’è
invidia tra donne; c’è l’invidia che è il
retaggio di quando dovevamo scannarci perché qualcuno ci
mantenesse. Poi c’è un’invidia che fa parte
proprio dell’animo umano, una è sociale, l’altra e
personale, non è che tutte le donne sono perfette, non è
quello. Però se avessi avuto il sostegno del mio gruppo, noi
saremmo andate ben oltre, e non l’ho avuto. Anche se mi
riconoscono molte cose, diversamente non sarei restata lì se
non fossi stata accettata, però adesso io non ho interesse a
fare le cose. A me manca, e questo me l’hanno tagliata
precocemente… l’ambizione. Quando io vedo una persona
ambiziosa devo superare una piccola invidia, e superandola mi allargo
il cuore, e in qualche modo sublimo (Fulvia Geracioti)
Si
rompono alcuni equilibri: all’interno delle famiglie, dei
rapporti di coppia. Non solo nodi dei rapporti interpersonali, ma
anche la difficoltà del rapporto con le istituzioni, con la
‘Politica’, con il potere, con l’informazione, con
il difficile rifiuto dell’ ‘eredità paterna’.
Un
conflitto fatto di frequentazioni quotidiane, di scontri violenti, di
prese di posizione differenti, di avvicinamenti e allontanamenti:
E'
un problema storico. Si capisce perché: sono stati gli uomini
a crearlo, ad alimentarlo ecc., e poi tutte le espressioni della
miseria femminile. Le donne non hanno potere in nessun posto e
quindi, naturalmente, su quei poteri interpersonali (o di natura
affettiva-sessuale) hanno lottato contro le altre donne. E'
fortissimo questo. E' stato in tutta la mia storia, in tutta la mia
vita. Puoi immaginare quante ne ho incontrate...tuttavia però,
siccome il percorso che io ho fatto è stato un percorso vero,
non un percorso di potere o strumentale, ma prima di tutto culturale
e politico....Io ho questo forte legame con la politica, è nel
mio DNA evidentemente. Quando hai un percorso così alto, non
ti scalfiscono gli starli che continuano a mandarti. Io adesso so di
essere usata perché la testa politica ce l'ho. Ma,
contemporaneamente, il fatto di avere 74 anni, rassicura molto,
perché non sono un ostacolo. Allora questa rassicurazione a me
va bene, perché vivo tranquilla, non ho ambizioni personali;
ho voglia di fare politica per il gusto di farla. In questo senso,
tutto è a mio favore. Ho un distacco umano di comprensione. La
rivalità è sempre un problema di miseria femminile,
quindi sta a me aiutarle. Non posso pretendere da loro (Annamaria
Longo).
Politicamente
noi non abbiamo avuto difficoltà, i problemi sono sorti sul
piano interpersonale, nel momento in cui abbiamo cominciato a scavare
sulle nostre identità, lì sorse il problema; perché
fino a quando ci fu la struttura andava tutto come una macchina, e
poi appena abbiamo cominciato a vedere chi eravamo, cosa volevamo,
quali erano le cose che avevamo accumulato, che non mi garbavano ma
che avevo fatto lo stesso per un senso di disciplina, di appartenenza
e quant’altro, e poi lì…la bolla di sapone. Il
problema era la visone gerarchica del gruppo (Adriana Papaleo)
Ogni
tappa della presa di coscienza genera contraddizioni e sofferenze.
Quando non si riesce a mediare, e la riflessione impone decisioni,
queste investono in primo luogo il rapporto con i mariti, i
fidanzati, i compagni. La riscoperta della soggettività
femminile significa necessariamente la messa in discussione dei
tradizionali valori maschili. E’ proprio nel privato che si
evidenziano i nodi della subordinazione che si formano nel pubblico.
Le donne iniziano guardare se stesse in maniera differente, dando
vita ad un nuovo e differente movimento rispetto a quello del ’68:
è il “problema senza nome” che si vuole risolvere,
il desiderio di qualcosa di più e diverso dal marito, di
figli, dalla casa (Friedan, 1964).
Nel
1976 ho fatto parte dell'UDI. Mi sono avvicinata alle donne dell'UDI
in modo più ideologico che operativo. Condividevo il loro
pensiero, le loro idee e le ammiravo molto perché riuscivano,
in un contesto sociale alquanto chiuso e maschilista (io allora
facevo il confronto con Monza dove prima insegnavo perché mi
ero trasferita da poco tempo, e allora era opprimente...ne sono
passati di anni...le cose sono cambiate) riuscivano ad operare e fare
tanto per appoggiare le donne nella rivendicazione dei propri
diritti. Con loro nasce a Soverato il consultorio, gli asili
nido...Partecipavo con interesse alle loro riunioni, facevo di tutto
per esserci ma, avendo una figlia di pochi mesi, non sempre lo potevo
fare, anche perché dovevo ricorrere alla baby sitter non
avendo qui alcun parente. Ricordo quel periodo in cui ero totalmente
oberata di lavoro, tra casa, scuola, figlie per cui mi autoescludevo
da tante attività che avrei voluto fare, ero imprigionata dai
ruoli di moglie, madre, casalinga, insegnante. Troppe cose insieme.
Ho cercato di gestire il tutto con un certo equilibrio, ma con tanta
fatica. L'UDI rappresentava per me molto, confidavo molto in queste
associazioni di donne che cercavano di sradicare certi pregiudizi
maschilisti e che si sforzavano di rendere ad ogni donna il lavoro
dignitoso e meno arduo. Con loro spiccavo il volo dalla realtà
che vivevo e ne uscivo fuori rincuorata e convinta che un giorno le
cose per le donne sarebbero cambiate (Francesca Lovecchio)
La partecipazione richiede un
investimento complessivo, perché attraversa tutta la vita, sia
pubblica, sia privata; mette in crisi le sicurezze dell’identità
femminile tradizionale. Si impongono quindi i temi del rapporto di
coppia, della divisione dei ruoli, della famiglia:
Ho
avuto delle lenti in più, degli strumenti in più, per
analizzare la realtà e non sentirmi schiacciata, perché
nell'ambito domestico – per quanto riguarda me, ma penso possa
riguardare anche le donne della mia generazione – si sono
pagati dei prezzi abbastanza pesanti, abbastanza duri, nel senso che,
per quanto mi riguarda, io ho vissuto nell'ambiguità di essere
la donna nuova, libera, quindi capace di assumersi delle
responsabilità lavorative e di famiglia però, nello
stesso tempo, di avere anche i vantaggi della donna tradizionale che
ha il marito che è lì. Quindi un po' un'ambiguità,
nel senso che questi rapporti poi sono stati inficiati di vecchio e
di nuovo, e quindi ti sei ritrovata tante volte con un compagno che è
cambiato soltanto quando è stato costretto a cambiare, perché,
altrimenti, tranquillamente condivideva tutto, ma continuava a fare
la sua vita di sempre; anche perché c'è una donna
efficiente, una donna che organizza, che gestisce, che mette tutto
insieme, gestisce le relazioni dei figli col mondo esterno...Su
questo ci sarebbe da riflettere molto, perché soltanto grazie
ad una tenacia ed una volontà, mia e di altre donne, siamo
riuscite a non soccombere in un discorso di isolamento, di
solitudine, perché il rischio è che ti ritrovi –
fra sfacchinate e tutto – senza costruirti delle relazioni
umane e sociali, perché cominci a buttarti sul discorso del
lavoro e della famiglia, e non ci sono altri spazi. Questo aspetto
qui è stato particolarmente impegnativo, e però il
pensiero della differenza mi ha dato la possibilità sempre di
capire. Poi magari non sono sempre riuscita ad essere tranquilla e
serena, evitare il conflitto – perché tante volte il
conflitto c'è stato – però mi ha dato gli
elementi per dire, magari anche forzandomi - “Loredana, dopo
sera esci, vai ad incontrarti con le altre donne; lascia, stacca,
impuntati”. Un sottrarsi anche agli impegni tradizionali, di
moglie; ci sono degli spazi diversi che possono essere anche...che
so, vedere la telenovela, perché lo decido io, perché è
una cosa che riguarda me, preferisco così. E' stato
significativo poter dare valore a ciò che tu riconosci per te
come valore, uscendo totalmente fuori dai parametri. (Loredana
Rubino)
Nel
'78 mi sono laureata, sono ritornata a Lamezia, mi sono sposata un
mese dopo; ho fatto tutto...ho chiuso il conto, come si suol dire. Io
ho sempre tenuto dentro tradizione e innovazione, non so se chiamarla
così. Ho avuto un rapporto con il mio attuale e unico marito
da quando avevo 17 anni, quindi storia classica. Nove anni siamo
stati fidanzati, poi ci siamo sposati ed è stata anche
un'educazione sentimentale e politica, perché insieme abbiamo
fatto anche il percorso politico. Ne abbiamo vissuto di tutti i
colori, nel bene e nel male, perché era inevitabile che fosse
così. C'è stata una grossa crisi, perché
all'inizio – anche se non c'era una grande differenza di età
fra noi (4 anni), noi ci siamo messi insieme che io avevo 17 anni e
lui 21, lui era già all'università, io facevo il liceo,
quindi pendevo dalle sue labbra. Per tutta una prima fase io sono
stata una sorta di discepola, perché lui aveva fatto il '68,
era stato in carcere con il movimento dei giovani della nuova
sinistra di Firenze, tutta una storia molto affascinante che mi aveva
preso; imparavo molto perché a Firenze lui andava a teatro,
c'era questa educazione intellettuale, questo trasferimento in questo
vaso che ero io. Poi sono andata all'università e ho
cominciato le mie prime esperienze, anche se la politica l'avevo
iniziata a Lamezia, e col femminismo nel '75 c'è stata una
sorta di capovolgimento della situazione, e anche una crisi del
rapporto, una crisi di crescita, perché io non ero più
la persona che imparava, ma in qualche modo rivendicavo una mia
autonomia, una mia soggettività. Quindi il rapporto diventava
differente anche insieme alla crescita politica (Rosa Tavella)
Con
il mio compagno eravamo cresciuti insieme all’Università
e poi professionalmente nella scuola - entrambi insegnanti di
matematica- e contemporaneamente nel PCI. Con lui condividevo tutto:
figli, professione, ideali e anche il lavoro in casa. Non era il
maschio che si spacciava per femminista, rispettava le mie
scelte/esigenze di spazi politici separati e, forse, ne aveva anche
compreso razionalmente la necessità. Insomma una famiglia
tranquilla come tante, con l’unico problema della mia
insoddisfazione nel vivere in questo mondo com’era e come è
e la mia caparbietà a volerlo cambiare per rendermelo più
accettabile.(Assunta Di Cunzolo)
All'interno
delle organizzazioni io vedevo una sudditanza sottile nei confronti
dei compagni, nelle scelte, o comunque nel desiderio di approvazione,
nel raccontare loro quello che facevano...Io devo dire che non ho mai
raccontato niente a mio marito, non mi ha mai chiesto niente, ma
perché io non mi mettevo proprio nelle condizioni di dovergli
spiegare...lui lo vedeva che non era contro di lui, si percepisce
questo. Quindi capisci che a me non piaceva questa radicalizzazione
di uno scontro che...allo stesso modo del maschile, secondo me, che
poi alla fine ci fosse un vincitore e un vinto (Fulvia Geracioti).
Emerge
il problema che accomuna l’esperienza calabrese a quella
nazionale: la difficoltà di gestire le differenze all’interno
dei gruppi. Riemerge con forza, inoltre, il problema del potere:
se
la ricerca di una differenza femminile
si
traduce nella ricerca di un linguaggio, di una cultura, di una
genealogia proprie, il rischio della perdita di tensione politica, di
rifugio nel privato, l’accettazione dei rapporti sociali
esistenti (e quindi delle logiche di potere tradizionali) è
sempre dietro l’angolo.
Lle
teorie poi vanno a confrontarsi con quelli che sono i fatti
personali, le relazioni anche emotive. E allora, non per tutte questo
discorso è stato facile, il fatto cioè che
l’autorizzazione alla libertà, la mediazione col mondo,
te la dà tua madre e che puoi avere relazioni con altre donne,
ed essere in un ordine simbolico femminile, perché comunque
riconosci l’autorità che è in primo luogo della
madre. Non era facile per nessuna di noi calarlo nella propria vita e
nel rapporto con la propria madre, e quindi qualcuna diceva: sì,
è vero, nostra madre è la prima che ci ha messe al
mondo anche in senso simbolico, però, riferendosi al discorso
delle madri simboliche, sottolineavano che l’autorizzazione
alla libertà, nelle genealogia femminile, la dà la
madre simbolica. Quindi c’è stato un grande fermento,
una grande passione nel discutere e nel riportare il pensiero alle
pratiche. Perché affermare che il riconoscere l’autorità
di una donna parte dal riconoscimento dell’autorità
materna, e che la relazione politica con un'altra donna ti pone in
una relazione dispari, perché comunque riconoscere l’autorità
di una donna significa riconoscerle un di più, e per farlo
bisogna essere capaci di svincolarsi dall’invidia, perché
l’invidia distrugge i rapporti tra donne, a parole sembra molto
bello ma metterlo in pratica, nei rapporti vicini non nei rapporti
lontani, crea un fermento molto vivo. Normalmente le donne erano per
me amiche, persone con cui condividere esperienze, quello che succede
normalmente nelle relazioni di amicizia. Però con le donne di
Kore abbiamo avviato un cammino che è stato di tipo diverso
del semplice stare tra donne e che ci ha portato ad un grande
riconoscimento di valore; l’importanza che dai a quello che una
donna dice senza squalificarlo e porre attenzione a ciò che
dice ( per me questa cosa è diventata automatica in qualche
modo). Non sto parlando di buonismo, anzi, però hai la
possibilità di diventare più consapevole dei meccanismi
che stanno alla base delle relazioni, di quei meccanismi che hanno a
che fare con l’invidia, con la rivalità, non solo con
sentimenti buoni. Sei un po’ più consapevole, e per
quanto è possibile cerchi di fare in modo che i sentimenti non
siano distruttivi. Quindi il dar valore a quello che una donna dice e
fa, il metterti in relazione non distruttiva, permette di muovere dei
passi nel mondo, di operare delle trasformazioni perché ci
sono delle relazioni che ti danno la forza e l’autorità.
E la tua forza non viene dall’alleanza che crei col mondo
maschile, ma viene anche dalla capacità che hai di creare
relazioni col mondo delle donne, è da lì che prendi
forza; perché comunque rimani dentro la tua differenza
sessuale, e da lì incontri il mondo maschile. Sono esperienza
di vita che sei costretta a dire con delle parole così, che
sembrano solo teorizzazioni e però nella vita possono
diventare pratiche reali. Non voglio dire che questo ti mette al
riparo dall’invidia, anche come sentimento che tu provi verso
altre donne, però ti dà gli strumenti di consapevolezza
e di chiavi di lettura, per cui è possibile agire in un modo
piuttosto che in un altro, anche se, torno a sottolineare, senza il
mio percorso di formazione personale, non so quanto sarei riuscita a
comprendere ed a fare esperienza di queste teorie (Maria
Procopio).
Ci
vedevamo nella sede del centro Lilith e leggevamo gli interventi di
Luisa Muraro. Per poi leggere tutti i libri, rileggerli e
commentarli. Questo è stato un passaggio decisivo e
importantissimo per quanto mi riguarda. Anche lì,
naturalmente, tensioni e non riconoscimenti fra donne. Tutto questo,
purtroppo, è stato segnato anche da conflitti e da relazioni
anche dolorose. Questo senza togliere niente ad alcune delle donne
che ha dato
comunque il suo
contributo, però le abbiamo avute le tensioni, anche forti.
C'è stato un momento in cui si teorizzava molto questo
discorso della relazione fra donne, di riconoscimento in qualche modo
della madre simbolica. Questo è stato durissimo, nel senso che
si è cadute anche in atteggiamenti un po’ troppo
cerebrali, un po’ troppo teorici, non calati
realmente....difficili da vivere fino in fondo; non liberi, tutto
sommato. Quindi il centro ha un po’ sofferto di tensioni di
questo genere, sempre le problematiche di mancanza di riconoscimenti
reciproci, questo è stato reale; una difficoltà grande,
soprattutto tra le personalità più forti, a
riconoscersi. E poi una difficoltà a dare continuità, a
dare costanza, a capire un po' che tipo di destino dovesse avere il
Centro, dopo il primo impulso, perché ognuna di noi, presa
anche dalle proprie vite personali, probabilmente ha avuto difficoltà
a mantenere un impegno all'esterno […] Secondo me il conflitto
nasce anche da un bisogno personale di ogni donna di esserci, dal
problema dell'invisibilità. Molti conflitti nascono dalle
insicurezze di ognuna che, nell'ambito della relazione, deve comunque
essere vista per forza. Il problema nostro è stato sempre
quello di essere escluse, dal maschile, dal mondo. Il conflitto nasce
se io ho paura di non essere vista, di non essere abbastanza
importante, essere considerata, come se riconoscere quello che ha da
dire quell'altra mi togliesse qualcosa. Io nella mia esperienza ho
visto questa fragilità alla base del conflitto; quindi le
personalità più forti che dovevano, in qualche
modo...dovevamo, ci mettiamo tutte, perché non è che
sono cose che hanno riguardato una singola persona, forse hanno
riguardato tutte. Di volta in volta bisognava forse conquistare
credibilità e autorevolezza nei confronti delle altre. E poi
una difficoltà a bilanciare il concetto della parità
con il concetto del riconoscimento di quel di più. Giustamente
non siamo tutte uguali, però era necessario inventarsi un modo
diverso del riconoscimento dell'autorità, che non deve essere
il potere, la gerarchia. E poi, comunque, non siamo abituate...è
qualcosa di ancora molto nuovo, quello del riconoscersi, del valore,
non sentirsi minacciate da un'altra donna. Credo non ci sia la
sicurezza; non siamo state abbastanza forti all'epoca, non eravamo
padrone di noi stesse tanto da poter dire: “va bene, io mi
sottraggo su questa cosa, non dico niente perché un'altra ne
sa più di me”. Forse non eravamo abbastanza forti,
abbastanza sicure. Io vedo la fragilità dietro i conflitti, e
poi molta rabbia, molta frustrazione, molti bisogni che non
c'entravano niente: il bisogno affettivo, tutto un miscuglio di
sentimenti, di cose....E poi il desiderio di metterle in ordine –
il discorso dell'ordine simbolico della madre; cose un po' forzate,
perché questi sono rapporti che devono venire fuori nella
libertà, nella naturalezza più assoluta, nella scelta,
ma senza neppure codificarle queste cose. Invece c'è stato un
momento in cui si sono anche codificate queste cose (Loredana
Rubino).
Uno spostamento di sguardo
Per
alcune delle intervistate, inoltre, il femminismo rappresenta
un’opportunità non colta fino in fondo, oppure
semplicemente sfiorata, se non ignorata come irrimediabilmente
lontano dalle proprie esperienze e convinzioni. Tuttavia, la ricerca
ha voluto descrivere e raccontare l’esperienza di questi gruppi
come parte di un «generale processo di assorbimento da parte
della popolazione femminile di alcuni dei contenuti espressi dal
femminismo. Un assorbimento che, a partire dal Movimento, coinvolge
poi come per osmosi le situazioni sociali, culturali, lavorative e
politiche in cui agiscono e vivono le donne; si tratta di un processo
che possiamo indicare col termine femminismo
diffuso,
intendendo con ciò la penetrazione in una pluralità di
strati e situazioni sociali di tematiche quali, per citarne alcune,
il diritto dell’esistenza della donna come persona in quanto
persona, la rivendicazione di spazi di autonomia, una maggiore
consapevolezza di sé» (Calabrò e Grasso, 1985:
145-146).
Queste
esperienze ci raccontano di come sia stato complesso e non univoco il
rapporto tra il movimento femminista e gli altri gruppi di donne
presenti sulla scena politica. Ciò che è importante
sottolineare è la grande circolazione di idee e di pratiche
che hanno caratterizzato questi anni, pur in una contrapposizione a
volte dura fra donne e fra gruppi. Sono le fonti della memoria che ci
restituiscono questa storia, a volte effervescente, a volte dolorosa,
sempre carica di significati e di passione e pratica politica. Si
percepisce, nella maggior parte delle intervistate, il senso della
scoperta di sé e della percezione della differenza come
momento cruciale e fondativo della propria esperienza. In molte
narrazioni è presente una sorta di “movimento
dell’esperienza”: allontanamento dalle modalità
tradizionali della politica, dai gruppi di appartenenza (gerarchici,
istituzionali, misti) per approdare ai gruppi di donne, diverse per
formazione e appartenenze precedenti, ma unite dall’esperienza
del ritrovarsi. Rispetto agli altri movimenti, i gruppi di donne
hanno una propria forma, una propria pratica politica. Gli anni
Settanta e Ottanta sono gli anni del movimento largo (Rossi-Doria,
2005), coinvolgendo donne differenti attraverso occasioni e incontri
diffusi; ma anche gli anni del movimento molecolare: tanti diversi
gruppi si confrontano nello spazio pubblico, costruiscono spazi di
incontro, cambiano singolarmente e collettivamente le loro vite
quotidiane, progettano nuove forme di politica. In definitiva, si
costituiscono come soggetto politico. Gli anni Novanta sono gli anni
della disgregazione e della ricostruzione: in modalità
diverse, che rispecchiano una rinnovata attenzione al personale, ma
anche alla costruzione di una sfera pubblica differente, nella quale
lo sguardo della differenza sia presente e capace di innovazione
sociale.
Come far convivere, ancora
oggi, il raggiungimento della parità dei diritti, la
dimensione delle pari opportunità, con la prospettiva della
differenza? Quali compromessi accettare, attraverso la decisione di
entrare – o condividere percorsi – nelle istituzioni, la
cui logica non si condivide fino in fondo. Su queste scelte, molti
gruppi si sono confrontati nel corso degli anni, scegliendo via via
la strada del coinvolgimento, del privato, della diversificazione
degli interessi
Abbiamo
anche abbiamo cercato di
portare delle trasformazioni nei luoghi in cui ognuna di noi operava,
perché quello che è importante del pensiero della
differenza sessuale è che ti costringe ad ancorarti al luogo
in cui sei, alla persona che sei, al momento in cui vivi, ti devi
ancorare alla realtà. Il mondo non si trasforma perché
c'è qualcun altro che deve sempre far qualcosa, invece ci sei
tu, e le trasformazioni partono da te. Sei tu che, nella realtà
in cui operi, devi essere capace, attraverso le
relazioni
che riesci a stabilire, soprattutto le relazione politiche con altre
donne, a trasformare il luogo e le relazioni in cui sei. Quindi, nei
luoghi in cui tu vivi e operi puoi produrre trasformazione e
cambiamento, se solo trovi un’altra donna con cui stabilire una
relazione politica, a partire dalla quale riconoscere autorità
e libertà. Dunque, sono stati anche anni importanti che ci
hanno visto operare nelle nostre realtà. Ad esempio, Assunta è
entrata nell’amministrazione comunale di Soverato, Fulvia è
diventata sindaco di Cenadi; io, anche nel luogo di lavoro, ho
organizzato, insieme con la Responsabile delle Risorse Umane ed una
operatrice (anche lei nel pensiero della differenza sessuale), una
serie di seminari per tutte le donne della Fondazione. Sono stati dei
momenti e delle occasioni importanti, perché praticamente
tutte le donne di questo ente (oltre 400 dipendenti, la stragrande
maggioranza all’epoca erano tutte donne) sono state coinvolte
in questo percorso (Maria Procopio)
Oggi,
la variegata mappa dei gruppi di donne è caratterizzata da una
diversificazione e istituzionalizzazione che alcuni promuovono come
ricchezza, altri come dispersione e isolamento. Si istituzionalizzano
i luoghi delle donne, con vocazioni anche molto diverse fra loro;
luoghi che segnano sempre lo spazio pubblico, se non in maniera
diffusa, in modalità estremamente visibili di elaborazione
politica, di iniziativa culturale, di diffusione dei saperi
femminili, di accoglienza e di supporto ad altre donne. Un tentativo
dalla grande portata innovativa: ritessere l’esperienza degli
anni Settanta (portare al centro della politica il corpo, la
sessualità, il desiderio) per estendere questo modello al di
fuori del piccolo gruppo (che pur rimane tale, senza proselitismi,
nel rispetto e nella curiosità per le differenze), senza
delegare ad altri la pratica nelle istituzioni. Quello che unisce
questi diversi periodi storici è questa continua modificazione
delle forme e dei contenuti della politica delle donne, da cui
derivano scelte individuali o nuove pratiche di aggregazione. La
stessa categoria di femminismo si rivela troppo parziale per
descrivere le specificità e le differenze che attraversano il
territorio di Catanzaro dagli anni Sessanta ai giorni nostri: rischia
da un lato di sottacere le conflittualità e le ambivalenze fra
i vari gruppi e all’interno dei gruppi stessi, e d’altro
lato rischia di confondere esperienze individuali e collettive in una
dimensione totale e totalizzante. I gruppi di donne presi in esame,
al contrario, mostrano una diversificazione di pratiche e di
percorsi, e di elaborazioni che hanno attraversato territori di
esperienze estremamente ricche e sedimentato saperi dai quali
attingere nuova linfa di idee e di forza. Guardare a quali
opportunità e limiti le donne organizzate hanno riscontrato
nella loro esperienza, quali strategie hanno sviluppato, rappresenta
una fonte di idee per elaborare strategie ancora oggi, ed è
anche un bagaglio di esperienza che alimenta la percezione delle
possibilità attuali, e di cui è quindi importante avere
consapevolezza.
Nel
1990 ho costituito la sezione Fidapa a Soverato, nel momento in cui
io, e un gruppo di amiche, abbiamo sentito il bisogno di ritrovarci
in un'associazione che favorisse l'espressione del nostro impegno
culturale, della nostra sensibilità verso ogni problematica
femminile, per potere così affrontare e risolvere, per quanto
possibile, i problemi che riguardano la collettività, in modo
da incidere nell'organizzazione delle strutture sociali e politiche
presenti nel territorio. Ho voluto costituire un gruppo di donne,
cosa che allora fu criticata e ostacolata col dire che oggi l'avrei
aperta questa sezione e domani l'avrei chiusa (...figurati, un
circolo di donne!) perché la coesione è una forza, una
forza che si fa potere quando nasce dalle idee e dal comportamento
consapevole di ognuna di noi. Ho sempre rilevato, nell'esistenza
delle donne, un certo divario tra ciò che sanno e possono
fare, e le possibilità loro concesse di poterlo attuare. Ho
sempre visto in loro un sapere profondo, un patrimonio (anche nelle
persone meno istruite) di innumerevoli generazioni, una capacità
di vedere, di intuire, laddove gli uomini non riescono neppure a
guardare. Ecco perché ho costituito il gruppo, perché
credo nelle capacità, nella tenacia e nella forza morale delle
donne, anche se ancora dobbiamo acquisire maggiore fede in noi
stesse. E in questo un gruppo di amiche (a volte anche una sola
amica) può aiutarci molto, per raggiungere la liberazione da
ogni pregiudizio, liberazione intesa come crescita, avente come
condizione anche la libertà di sbagliare (Francesca Lovecchio)
Un problema che rimane quanto
mai aperto e attuale, in questa prospettiva, è proprio la
difficoltà del passaggio generazionale, il pericolo che dopo
la moltiplicazione dei luoghi delle donne negli anni Ottanta e
Novanta venga meno la trasmissione delle radici di un’esperienza
che ha difficoltà a raccontarsi ma che desidera accogliere la
sfida del futuro:
No,
non c'è stato. Nel senso che poi è finito, si è
chiuso. Noi ci siamo collegate dopo con la casa di Mago Merlino, che
è collegata con l'Oasi Bartolomea, quindi il materiale che
avevamo lo abbiamo dato a questa associazione che sostiene delle
ragazze madri. Per quanto riguarda il discorso del centro Lilith e
del pensiero della differenza, per me è stato importantissimo
perché ha segnato un ulteriore passo in questo senso: che
comunque puoi cambiare a partire da te stessa, che il lavoro è
molto su di te, le relazioni attorno a te, quindi sulla
consapevolezza che non c'è un meglio di te – che può
essere il maschile – ma ci sei tu e ti devi riconoscere in
quello che tu sei, con riferimento al fatto che sei donna, che è
una differenza di fondo, sostanziale, e che quindi i parametri non
sono quelli che passano per oggettivi – che poi sono quelli
maschili – ma possono essere altro. Questa è stata una
svolta molto liberatoria, anche per quanto riguarda il rapporto con
l'esterno, con il contesto professionale, con il contesto domestico,
per quanto riguarda i rapporti con l'altro sesso, con il marito. C'è
stata una presa di coscienza del fatto che non ti devi parametrare a
questo altro (Loredana Rubino)
Io
non ho un rapporto con le ventenni, non so come si collocano;
naturalmente hanno una vita molto diversa da quella che abbiamo
vissuto noi, in cui noi abbiamo lavorato e operato. Tuttavia continuo
a pensare che c'è una subalternità ai maschi molto
forte; non so se se ne accorgono, se ne sono consapevoli. Non vedo il
delinearsi di un'organizzazione propria della donna, cioè,
vedo una sciatteria delle donne, magari disposte a utilizzare gli
uomini, che però non lavorano sull'accrescimento della propria
dignità, della propria autonomia, della propria consapevolezza
di soggetto compiuto, completo, capace di misurarsi ad alto livello.
Non c'è questo (Annamaria Longo)
Dopo
il periodo di riflusso credo che ci sentiamo, parlando fra di noi, in
grado di essere noi, adesso, le madri di quelle che si aprono alle
altre. Io sono stata ad un convegno dell'UDI l'anno scorso, ed ho
sentito parlare delle giovani. Avevano dei problemi diversissimi da
noi. Intanto sono stata contenta perché, uno, le battaglie che
abbiamo fatto hanno avuto dei risultati; due, perché il tipo
di femminismo che volete, il tipo di libertà che volete, è
il vostro...E' la vostra libertà, non può essere più
la mia. Però che vi possiamo insegnare come sostenere questo
desiderio, delle pratiche, ve le possiamo pure passare; con il
rischio di essere poi rifiutate come succede alle madri. Noi
l'abbiamo passato con le nostre figlie! Mi pare normale. Adesso credo
che siamo capaci, perché vedo che è un desiderio che
serpeggia, di aprirci, ascoltarvi e, in qualche modo...la tecnica è
un po’ quella della terapia...siete voi, la risonanza, che dona
senso. Possiamo fornirvi il luogo, farci luogo noi, ma voi avete la
vostra vita, questo lo sappiamo bene, perché noi siamo quelle
la cui vita è stata già scritta (Fulvia Geracioti)
Negli
anni Settanta il movimento delle donne si è ritratto
progressivamente dal confronto con le istituzioni, anche se un
rapporto tra femminismo e sistema politico ha continuato ad esistere,
assumendo connotati più locali, moltiplicano iniziative
specifiche – quali quelle riguardanti la violenza sessuale –
spesso a raggio territoriale limitato. Questo sostegno ad un
femminismo più “culturale” e meno esplicitamente
politico rivestirà particolare importanza per il femminismo
degli anni Ottanta. Quello che i gruppi di donne continuano a
rivendicare, tuttavia, non è solo una presenza quantitativa
nelle istituzioni, quanto una partecipazione autorevole, senza
precisi confini tra pubblico e privato, ma che all’interno
i questi
confini potesse muoversi liberamente. Nota Anna Rossi-Doria che le
elaborazioni del pensiero della differenza hanno trasmesso una
visione per cui «proprio il femminismo italiano, che aveva
avuto un carattere di massa superiore a quello di ogni altro paese, è
stato rappresentato come un percorso teorico di piccoli gruppi o
singole pensatrici, sia pure grandi. Negli anni Settanta, a
differenza di quel che avvenne in seguito, il femminismo italiano era
stato invece prima di tutto una pratica politica che aveva
profondamente trasformato la coscienza e la vita di molte migliaia di
donne, in tutte le regioni italiane, in città grandi e
piccole, anche in moltissimi paesi» (Rossi-Doria, 2005: 3). Le
differenze tra il modo di sentire e vivere il femminismo dopo gli
anni Ottanta hanno a che fare con un diverso modo di rispondere alla
domanda su che cosa sia la politica. L’oggetto della politica,
in molte testimonianze, non è più un gioco per pochi
eletti, ma una realtà costituita concretamente dai vissuti
delle persone. Una realtà in cui non si può continuare
a giocare, ma in cui occorre mettersi in gioco, percepirsi come
eticamente responsabili del cambiamento. L’obiettivo è
la realizzazione del cambiamento, nonostante le sconfitte le battute
di arresto. Un cambiamento che deve affrontare, ancora una volta, la
sfida delle istituzioni, del dilemma dentro-fuori:
Per
ora sono ‘tornata a casa’, nel luogo più sicuro
della Biblioteca delle Donne. Uno scacco? Forse, ma credo di avere
imparato molto dall’ esperienza in Comune e anche dallo scacco,
perciò non me ne pento, anzi. E, in ogni caso, non posso non
essere contenta della gratitudine che mi dimostra ancora oggi la
gente per come il lavoro è stato svolto; se non hanno
dimenticato, anche per loro deve essere stata un’esperienza
particolare (Assunta Di Cunzolo)
Non
faccio un discorso generale, non so fare previsioni universali. Parto
da me e dalla mia esperienza. Qui in Calabria non la vedo tanto bene.
Ci sono singole esperienze che continuano ad essere significative,
forti, e a rappresentare dei momenti anche importanti per le donne in
Calabria, però manca il collegamento, forse un progetto
politico che – anche al di là delle singole appartenenze
– riesca a ricostruire degli obiettivi – all'interno
delle istituzioni, fuori...Se penso che in Consiglio regionale, dal
'90 ad oggi, in fondo che cosa è cambiato? Io sono stata unica
consigliera regionale per 5 anni, poi siamo state in 4, poi nessuna,
ora due. Insomma c'è ancora una distanza enorme dalle
istituzioni. Questo significa ancora molta strada da fare all'interno
delle istituzioni politiche, nonostante tutto, e c'è secondo
me in Calabria – nonostante esperienze che io so essere
significative, penso ad Emily, le donne di Soverato, dell'Università,
del Lanzino, alcune donne dell'Unione che so si stanno muovendo in
questi mesi per costruire una forma di collegamento – però
vedo ancora molta improvvisazione (Rosa Tavella)
L’associazione
[Federcasalinghe], di recente, ha assunto tra le sue funzioni quella
di istituire dei Patronati. Siamo in procinto di aprire il patronato
provinciale , che sarà ubicato a Catanzaro, affiancato da
altre sedi zonali. L’associazione, in questi ultimi tempi, è
cresciuta notevolmente, e si è trasformata in Holding
sociale (che non si
rivolge solamente alla casalinga, ma alla famiglia) con numerosi
settori di intervento, dando vita ad una formula che possa coniugare
il concetto di holding economica vera e propria con quella di
economia sociale, attraverso un gruppo di tredici organismi che
interagendo tra di loro possano offrire una migliore qualità
di vita. Tra questi ci sono: Informafamiglia per informare ed essere
di servizio; Fondo pensione famiglia per rappresentare una certezza
per il futuro; Incontro S.p.A. Lavoro interinale per i servizi alla
famiglia; Domina – sindacato della famiglia; Progetto salute
per il benessere della famiglia (Anna Parrello)
Sono
tornata con le donne adesso, nell'ultima campagna elettorale, quando
ho fatto questo coordinamento regionale delle donne dell'Unione, e
c'è stata una risposta immediata. Su questo lavorerò
adesso, dovrò preparare uno Statuto, insieme ad un'altra, per
dare un taglio giuridico a questo coordinamento...Adesso io sento che
la politica si deve fare in altro modo: non si può prescindere
dal disertare i luoghi maschili della politica, bisogna essere lì,
altrimenti non incidi. Bisogna essere lì e avere idee chiare e
obiettivi precisi: questo è il mutamento di fondo.[…]
Con tutti i dispiaceri che mi sono presa, e i conflitti più
cocenti, tuttavia tu devi imparare a nuotare in quel mare, con la
consapevolezza del tuo percorso, di cosa tu vedi che gli altri non
vedono. Ma misurarti con la politica: questi gruppi sono una voce nel
deserto, non hanno un impatto con la politica; non si può
tornare a fare le conventicole, i convegni delle donne con le donne
solo. Ormai bisogna fare i conti con questi Moloch maschili che sono
i partiti, che sono in via di disfacimento, ma in cui noi non siamo
entrate.[…] A me non vanno più le Commissioni femminili
nei partiti. Non mi va più questa figura ibrida: la portavoce
delle donne. Che vuol dire? Che senso ha? A me va di misurarmi ex
aequo, consapevole della mia differenza di genere - e tutta la mia
cultura e la mia storia diversa – in tutte le attività
della politica, negli organismi dei partiti, nelle cariche elettive,
nella politica nelle sedi dove si fa. Questo dovrebbe essere. Allora
le elucubrazioni di riformare l'UDI sono elucubrazioni che
appartengono al passato che non esiste più. E' un ritagliarsi
una specie di orto dove lavori tu e basta. Non è che dobbiamo
continuare...I campi di esplorazione li abbiamo esplorati tutti;
l'elaborazione era arrivata ad un punto alto. Anche la Luisa Muraro
ci aveva dato una serie di indicazioni: il rapporto madre-figlia, il
riconoscere un'altra donna come fatto fondamentale della
politica...abbiamo detto tutto quello che si poteva dire. Quello che
ci è mancato è stato il fare, il misurarci nelle sedi,
nei luoghi della politica; avere uno scontro, dove esci perdente,
esci forse anche perdente perché sei sola, perché
continui a trovare le donne che sono subalterne agli uomini. A me
interessa fare politica a questi livelli, del resto non mi interessa
più niente. Non voglio fare la portavoce delle donne
(Annamaria Longo)
Dove
siamo, dove stiamo andando? Mi piace concludere questa narrazione
ripercorrendo a ritroso una genealogia femminile, per come narrata da
alcune intervistate:
Sono
cresciuta in un’enorme famiglia di donne; ero la prima nipote e
le mie sette zie, le sorelle di mia madre, hanno curato insieme a lei
la mia prima educazione. L’immagine successiva della mia
adolescenza, che ho recuperato solo molto tempo dopo, è
l’incontro domenicale di mia nonna con le figlie sul terrazzo
della casa materna. Godevano della loro compagnia in quelle poche ore
pomeridiane concesse dall’assenza di lavoro e dei mariti
dedicati al tifo allo stadio. Abbastanza acculturate per l’epoca
– diplomate, frequentanti l’Università o laureate
tranne una zia disabile e mia madre che aveva dovuto abbandonare per
vicende legate alla guerra che, a Battipaglia, dove sono nata, era
stata sofferta molto; anche mia nonna aveva frequentato il ginnasio
in collegio e dava molta importanza all’istruzione. In quella
famiglia veniva riconosciuta intelligenza e valore a ciascuna, anche
alla zia disabile che aveva il compito della gestione della famiglia
e della casa. Perciò, tutte e tutti –mio padre,
particolarmente, che aveva dovuto interrompere gli studi per lavorare
e poi arruolarsi volontario per la sciagurata guerra d’Africa-
mi avevano spinto a studiare, a coltivare ambizioni non
necessariamente legate ai ruoli allora rigidamente assegnati alle
donne. Ma non avevo la libertà di movimento e di relazioni dei
miei fratelli, anzi non avevo nessuna libertà se non quella di
studiare: non potevo uscire di casa se non accompagnata da qualche
parente, né potevo avere amici e tantomeno frequentare i
compagni di classe al di fuori della scuola, nella quale eravamo
rigidamente separati tra file di banchi per ragazze e quelle, più
numerose, di ragazzi, quando non eravamo in classi esclusivamente
femminili. Tra diffidenze e conflitti potevo frequentare, a casa mia,
l’amica del cuore [… Non dimenticherò mai la
severa maestra Bonanno delle scuole elementari o la dolce Wanda che
insegnava italiano alle medie e le docenti delle superiori, Cino di
filosofia e Gambino di matematica che insegnavano le materie da me
preferite. Non ricordo più i nomi dei professori maschi,
tranne uno, Guerriero, che al ginnasio insegnava italiano e greco.
Avevo già acquisito allora la piena consapevolezza che
intelligenza e capacità delle donne non fossero affatto
inferiori a quelle dell’altro sesso, anzi. Piuttosto ero piena
di rabbia per come venisse limitata la nostra libertà e non ne
comprendevo il motivo reale (Assunta Di Cunzolo)
Ero
sempre vissuta con le donne: ho studiato dalle suore salesiane che
hanno contribuito molto alla mia formazione culturale e morale. In
particolare, recupero nel mio ricordo, Suor Nicoletta – anziana
- e Suor Clemenza – giovane - che, comprendendo il mio
carattere ribelle alle convenzioni e alle ipocrisie, mi hanno aiutata
a capire e a mediare nei rapporti con le altre/i. Sono state le mie
Maestre insieme con mia madre, prima di sei figli (tre sorelle e tre
fratelli) in una famiglia, con tanti problemi, che lei ha governato
fin da giovanissima (a Soverato, allora, c’era solo
l’Istituto Magistrale “Maria Ausiliatrice” per le
donne e il Liceo Classico “Don Bosco” per i maschi). Ho
fatto l’Università al Suor Orsola Benincasa di Napoli,
Magistero solo femminile soggiornando al pensionato delle suore,
sempre salesiane (Marisa Rotiroti)
Avevo
questa idea di separatezza...Io sono stata cresciuta in un gineceo.
La cucina di casa mia era una cucina rurale, grande. In fondo c'era
il caminetto, mio padre; qui c'era il braciere e c'era mia madre. Non
erano mondi contrastanti, erano mondi separati. Io mi sono cresciuta
con questa idea, che possiamo stare nella stessa stanza, abbiamo dei
momenti insieme, però...le risate, l'apprendimento, quello
avveniva qui; lì ne avveniva un altro, venivano delle persone
a chiedere dei pareri, a farsi scrivere delle lettere. Parlo degli
anni '50. Lì venivano per un motivo, qui venivano per un
altro. Secondo me quella è la misura del mondo (Fulvia
Geracioti)
Questo
mio pensiero positivo sulle donne è da ricondurre al mio
vissuto durante l'infanzia e la giovinezza. Durante l'infanzia sono
stata educata con amorevole cura da mia madre e da alcune mie zie che
non erano sposate, che per me hanno rappresentato il prototipo
dell'intelligenza, dell'intuizione, della comprensione, dell'amore e
della capacità di proiettare le loro idee in un futuro
lontano. Ho avuto la fortuna anche nella mia giovinezza di avere un
gruppo di amiche splendide, alle quali ho dato tanto affetto sincero
e tanta disponibilità, ma dalle quali ho ricevuto anche tanto
affetto che dura ancora adesso...quando ci rivediamo, anche per poco,
sembra che ci vediamo ogni giorno! Da loro ho ricevuto tanto affetto,
stima e considerazione di me, mi hanno sempre dimostrato tutto
questo. Questo mi ha sempre spinto a fare di tutto, infatti con loro
facevo teatro, organizzavo concerti, insomma...ci divertivamo tanto,
però io ero l'anima della compagnia...avendo sempre il loro
incondizionato appoggio morale e materiale. Il loro supporto non mi è
venuto a mancare mai, anche se da 35 anni manco dal mio paese natale,
Palmi. Ecco perché io credo nei gruppi e nelle relazioni tra
donne, anche se a volte ci sono delle divergenze, ma c'è
sempre un arricchimento tra donne, anche quando si scontrano
(Francesca Lovecchio)
Postfazione.
Utopia della memoria
Percorsi
di gruppi di donne nella provincia di Catanzaro
[…questa
per me è un’occasione tanto fortunata
quanto
difficile per ripensare ad anni per molti versi
straordinari
che hanno segnato tutto il resto della
mia
vita, ma il cui senso unitario non so ancora cogliere.
Fortunata
per la luce di nostalgia che porta con sé
la
rievocazione di una rarissima stagione di
“felicità
pubblica”; difficile perché quello che cominciò
allora,
per me come per tante più giovani di me,
non
è finito, il che ostacola la necessaria distanza critica
(Anna
Rossi - Doria)
Come
eravamo, vent’anni fa, trent’anni fa, ieri? E come rimane
viva in noi, donne del femminismo, donne dei “gruppi
organizzati”, la memoria del nostro essere diventate donne
adulte in una fase storica di effervescenza collettiva? Che cosa è
rimasto, e che cosa, magari avremmo voluto dimenticare, rimuovere? A
partire da oggi appare sorprendente fino a che punto fossimo state
parte, anche a nostra insaputa, di processi culturali e sociali più
vasti. Amelia Paparazzo, nella sua introduzione, rimanda a
connessioni di tipo verticale: le donne del Sud, le antenate, le
“madri” reali e simboliche, segnate dai destini di quella
emigrazione che profondamente ha strutturato, sovvertito, ma anche
arricchito le traiettorie biografiche di gran parte dei calabresi e
delle donne calabresi in modo particolare.
Io
invece vorrei soffermarmi sulle connessioni di tipo orizzontale. Vale
a dire i fermenti di movimento
che
ci hanno attraversato in questi decenni e che fanno sì che
siamo diventate, pur con grandi diversità rispetto alle
singole strategie politiche e culturali delle varie espressioni del
femminismo, tutte parte di quel “popolo delle donne “ di
cui parla Luce Irigaray.
Ho
letto le interviste, i documenti e le analisi di questo testo con
piacere e con una certa emozione. Ho riconosciuto e ricordato
incontri ai quali ho partecipato, ma, di più ancora, questa
lettura mi ha fatto rivedere situazioni analoghe in altri contesti. E
questo è ciò che intendo con connessioni orizzontali:
lee mie esperienze concrete si riferiscono a contesti diversi come
Milano, Cosenza, Cagliari, infine anche un pezzo di California e di
New York. Eppure la vivacità della discussione, le tematiche,
il tipo di conflitti fra donne presentano molti tratti comuni.
Eravamo in movimento, letteralmente. Partecipanti di una rete molto
vasta e articolata. Credo che si possa dire che la ricostruzione non
sistematica dei gruppi di donne in un raggio territoriale piuttosto
ristretto (Catanzaro, Soverato, Lamezia) ci offre, tuttavia, uno
spaccato ampio delle questioni in discussione, dal rapporto con i
partiti alla doppia militanza, dalle inquietudini della sessualità
al rapporto con la salute e con le istituzioni della “mala
sanità”. Dal lavoro femminile tra produzione e
riproduzione all’intellettualità diffusa, al desiderio e
ai conflitti tra donne. Dall’uguaglianza alla differenza. Darsi
valore (finalmente), prendere la parola, gestire il proprio
corpo….osare.
Più
che una ricostruzione sistematica questo testo rappresenta un
esercizio della memoria: guardarsi dentro e guardare indietro per
lanciare in avanti. Ma verso chi, con chi e per mettersi in relazione
con chi? Sotto questo profilo, implicitamente – ma in alcune
testimonianze anche in modo esplicito – le donne che
incontriamo in questo testo pongono la questione della trasmissione
generazionale. La difficoltà di trasmettere alle giovani
generazioni, alle figlie, l’esperienza e lo spirito di
creatività che ha connotato quegli anni è stata
variamente tematizzata. Senza peraltro ricevere risposte esaurienti.
Risposte forse impossibili, perché la domanda potrebbe essere
stata posta male. Intendo dire che, magari, dovremmo renderci conto
che loro, le figlie, sono persone autonome che hanno bisogno di fare
le loro proprie esperienze. Sono ragazze che crescono in un mondo
diverso dal nostro di allora, partono da presupposti oggi “ovvi”
che sono anche risultato delle nostre lotte, ma che, tuttavia, ormai
sono parte integrante del contesto sociale. Le nostre “conquiste”
in termini di libertà, autonomia, accesso ad una serie di
servizi, garanzie legislative ecc., a loro sembrano scontate, fanno
parte del senso comune. Oggi altre appaiono le priorità, altre
le mete da conquistare: la convivenza interculturale, le sfide della
globalizzazione, il disastro ecologico e così via. Strada
facendo incontreremo sempre di nuovo alcuni nodi che erano anche
problemi prioritari per noi, come la sessualità, il potere,
l’oppressione patriarcale. In modi analoghi e, insieme,
diversi. E allora, forse si ricorderanno o scopriranno i nessi tra la
loro e la nostra esperienza. Ho fiducia che di volta in volta
capiranno, compiendo un proprio percorso, analogie e dissonanze. In
un certo senso è significativo che questo testo si appoggi ad
un rapporto intergenerazionale: due giovani donne, Maria Marino e
Giovanna Vingelli, che interloquiscono con le protagoniste e le
testimoni del movimento. Le “figlie” che interrogano le
madri, semplicemente.
Ma
torniamo alle protagoniste. Si ha l’impressione che tutte
rispondano con interesse e piacere alle sollecitazioni della memoria.
Alcune sottolineano che volentieri colgono l’occasione di
uscire dal silenzio. Vale a dire da una fase, parte degli anni ’90,
che da molte è stata vissuta come un periodo stagnante. Ci
sono alcuni filoni che attraversano queste testimonianze, come la
questione del potere, il rapporti con la politica e i partiti, il
dentro e il fuori dalle istituzioni e la relazione fra donne. Parità
o disparità? Uguaglianza o differenza?
Possiamo
dire che le interviste, i racconti, i ricordi ci svelano una doppia
realtà: da una parte una cronaca di avvenimenti, lotte
politiche e vicende italiane di quegli anni, dall’altra una
storia nascosta, quella in un certo senso intrecciata e parallela del
femminismo, tutta ancora da scrivere. Prendiamo ad esempio la storia
dell’UDI, organizzazione nata durante la Resistenza dai Gruppi
di difesa della donna, che si era impegnata nel corso degli anni ’50
e ’60 in innumerevoli battaglie per l’affermazione dei
diritti delle lavoratrici madri, nel solco della tradizione
egualitaria ed emancipazionista. Nel corso delle battaglie attorno
alla legge 194 l’UDI si avvicina al Movimento femminista e,
dopo un ricco dibattito interno, l’associazione approderà
al proprio autoscioglimento nel Movimento nel corso dell’XI
congresso. I racconti delle protagoniste ci portano nella realtà
di una città di provincia meridionale come Catanzaro dove
l’UDI rappresenta un punto di riferimento importante.
Diversamente dal Centro - Nord, qui le militanti sono in gran parte
donne della media borghesia, colte, illuminate e assai combattive.
Capaci di toccare temi, come la sessualità e la riproduzione
largamente ancora tabù. Forse è proprio tale retroscena
sociale che permette loro di mettersi contro l’ospedale, la
sanità e la burocrazia - e parte dei propri compagi. Sono
battaglie su almeno due fronti, verso il proprio partito di
riferimento, il PCI, o il PSI, da una parte, e verso i collettivi
femministi dall’altro.
L’eterogeneità
delle appartenenze politiche e culturali degli anni ’70 sembra
essere attraversata da una comune e dolorosa tensione, quella tra lo
stile e i contenuti della politica tradizionale o maschile dei
partiti e dei gruppi extraparlamentari da una parte, e la
rivendicazione del Movimento delle donne di prendere la parola e di
considerare il personale politico. “Partire da sé”
è, contemporaneamente, una questione politica e una questione
metodologica. Due contesti che si sovrappongono: il rapporto con i
partiti della sinistra storica e con i gruppi politici nati nel ’68
e il rapporto con “le altre”, le altre donne dentro e
fuori dai partiti e dai gruppi. Perché donne e basta.
Nel
passaggio dagli anni ’80 e ’90, come per incanto, la
situazione cambia sostanzialmente. Gli anni Ottanta registrano, in
tempi un poco sfasati, il crollo di tutti questi contesti, abitati
dai corpi politici dei fratelli, dei padri e delle sorelle. Da questa
tragedia familiare si salverà fortunosamente la madre, già
emersa in carne e ossa nei collettivi (e precipitosamente sepolta), e
resuscitata simbolicamente dal femminismo della differenza (Baeri,
2005:25). Chi in un modo, chi nell’altro entra in contatto con
il “Sottosopra Verde”, con l’elaborazione della
“differenza sessuale”, proposta da Libreria delle Donne
di Milano e rappresentata da Luisa Muraro, figura carismatica, in
particolare.
Siamo
negli anni “craxiani”, quelli dei nuovi modelli
manageriali, competitivi, paritari ed economicisti, che elogiano il
modello della donna in carriera e del manager rampante.
“Quasi
una fuga inconsapevole da quel sé centrato sui corpi del
desiderio che aveva riempito i luoghi politici degli anni precedenti:
nessi da individuare, forzature da evitare”, avverte Emma
Baeri, e prosegue: “Eppure, come non cogliere tra le righe del
lessico del “Sottosopra” verde del 1983, una certa
assonanza con quel clima ? curiosamente, infatti a rileggere quel
testo importante che affermava a chiare lettere la necessità
di uscire dalle secche del femminismo dei conflitti – diritti
(quello che aveva portato all’approvazione della legge 194
sull’autodeterminazione della maternità e che aveva
raccolto le firme per presentare una proposta di legge contro la
violenza sessuale), si colgono parole inusitate alle nostre orecchie
di allora: relazione significativa duale, dispari
perché modulata sulla relazione madre – figlia, e sulla
messa a punto di una
voglia di vincere nei
commerci
sociali
attraverso la conquista di un agio visibile, di cui l’affidamento,
imprevedibile parola feudale, era strumento e
fine. La tradizione egualitaria, che il femminismo storico aveva più
o meno esplicitamente mutuato dalle sue origini libertarie-la
sorellanza tra uguali - veniva liquidata assieme al suo retroterra
teorico e alle sue risorse politiche, non ultima quella legata al
nesso tra femminismo e democrazia, che veniva d’un colpo
cancellato dalla riflessione politica di quella parte del movimento.
(Baeri 2001:26).
Ho
voluto riportare in modo esteso le parole di Emma Baeri perché
segnano con pregnanza un punto centrale del dibattito di quegli anni
che ha visto protagoniste le donne del movimento, indipendentemente
dalla collocazione geografica, al nord, al sud, al centro. E perché
di questa discussione troviamo ampia traccia nelle testimonianze di
questo libro. La fascinazione del pensiero della differenza colpì
un po’ tutte, ma poi le storie ed esperienze delle singole
donne portarono a modulazioni diverse. Chi aveva alle spalle una
formazione laica temette l’alone sacrale di quel pensiero; chi
aveva fatto autocoscienza o attraversato un’analisi diffidava
della seduzione della madre simbolica; chi cercava certezze e
soluzioni abbracciava con entusiasmo il nuovo amore. Ciò che è
certo, il pensiero della differenza non lasciò indifferente
nessuna e fu- qualunque fossero i singoli percorsi- uno stimolo forte
per andare avanti. Nel caso specifico delle nostre testimoni, il
“salto” nella differenza generò gioiose esperienze
collettive, associative, creative e letterarie, per alcune. Per altre
incentivò un ritorno alla politica, alle istituzioni e alla
società civile in modo diverso da prima; e per altre ancora
portò verso nuove forme di spiritualità e di impegno
nel volontariato.
Renate
Siebert
INDICE
INTRODUZIONE...........................................................................................................4
PRIME
FORME ORGANIZZATIVE:
L’UDI
ACCANTO ALLE LAVORATRICI DELLE
CAMPAGNE....................................9
1.1
L’UDI di
Badolato................................................................................................10
1.2
La lotta affianco alle raccoglitrici di
olive.............................................................14
1.3
La Fidapa di
Catanzaro.......................................................................................19
LA SVOLTA DEGLI ANNI
SETTANTA:
LE POLITICHE SOCIALI E I
COLLETTIVI.................................................................22
2.1
UDI: Circolo di
Catanzaro...................................................................................26
2.2
UDI: Circolo di
Soverato.....................................................................................38
2.3
UDI: Circolo di
Lamezia Terme
..........................................................................46
2.4
Collettivo femminista Via
Casa
Arse...................................................................51
2.5
Collettivo
Femminista di Lamezia
Terme.............................................................55
Fidapa
di Lamezia
Terme...................................................................................62
GLI
ANNI OTTANTA E NOVANTA.
ORGANIZZAZIONI
FEMMINILI: IMPOSTAZIONE E ATTIVITA’................................63
3.1 Kore, Tempo di
Marea..........................................................................................64
3.2
Centro Lilith, Le
Lune...........................................................................................68
3.3
Federcasalinghe, Fidapa di
Soverato...................................................................73
3.4
La Biblioteca delle
Donne Kore -
Fidapa...............................................................77
IL
RACCONTO............................................................................................................81
Parole
e
silenzi............................................................................................................81
Desiderio
e scelta: i luoghi delle
donne......................................................................86
Relazioni
e
conflitti....................................................................................................120
Uno
spostamento di
sguardo....................................................................................130
BIBLIOGRAFIA
.............................................................................................................
|





