|
|
Sei su Archivio / LIBRI_HTML / Uno_sguardo...altro
Imp.
|
BIBLIOTECA delle DONNE KORE -FIDAPA
|
|
Cineforum: raccolta di schede critiche
|
|
Gruppo di progettazione:
|
Teresa Ciaccio
|
|
|
Mara Gaudioso
|
|
|
Paola Nucciarelli
|
|
|
Maria
Grazia Riveruzzi
|
|
|
Marisa Rotiroti
|
|
Coordinamento:
|
Maria Grazia Riveruzzi
|
|
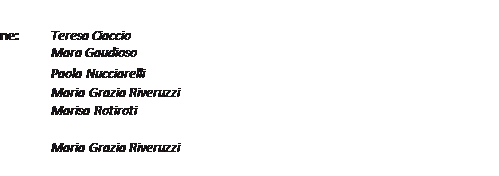
|
Realizzazione multimediale: Tina Alvaro
|
|
La foto di copertina è tratta dal libro “Jane Campion” (Dino – Audino Editore)
|
|
L’idea della
Biblioteca delle donne di Soverato è nata come realizzazione del desiderio di
un gruppo di donne delle due Associazioni “Progetto donna Kore” e
“F.I.D.A.P.A. “, gruppo che gestisce con passione la Biblioteca fin dalla sua
istituzione nel 1995. È ubicata nel Palazzo di Città ed è stato possibile
realizzarla grazie a un rapporto di scambio tra soggetti diversi: le due
Associazioni su indicate e le Istituzioni: il Comune che ha concesso i locali
e il Progetto Donna della Regione Calabria che l’ha finanziata. Per la
diffusione dei saperi femminili ci siamo aperte al territorio con presentazione
di libri, seminari di discussione e di riflessione sulla diversità dei saperi
e del pensiero delle donne che, partendo dalla propria esperienza, ci offrono
uno sguardo diverso della vita e della realtà nella quale viviamo.
Consapevoli che la Scuola sia una palestra di formazione in cui le ragazze e
i ragazzi prendono coscienza della propria identità e valore di genere, fondante
del proprio esistere e indispensabile per rendere possibile una
convivenza, civile e democratica anche fra culture diverse, abbiamo rivolto
la nostra attenzione alle/ai giovani delle scuole superiori. Per loro e per
la cittadinanza tutta abbiamo realizzato progetti di Cineforum e Incontri
con Scrittrici contemporanee.
|
|
Così, attraverso la
comunicazione scritta e visiva ci proponiamo di rafforzare l’autorità
femminile e di ripensare noi stesse e il mondo per abitarlo con maggiore
agio.
|
|
Per il Comitato di
Gestione
|
|
La Coordinatrice Marisa Rotiroti
|
|
Sono ormai quattro anni che la
Biblioteca delle Donne di Soverato realizza progetti di cineforum per le classi degli istituti
superiori e rassegne di film d’essay per la cittadinanza. La Biblioteca ha la
finalità di dare visibilità e promuovere la creatività femminile in tutti
settori della cultura, dalla narrativa alla poesia, dalla scienza all’arte,
alla cinematografia. In quest’ottica si colloca la realizzazione dei
cineforum che, frutto di un lavoro corale, ha visto coinvolte molte di noi
in un unico desiderio. Quale desiderio ci univa quando abbiamo scelto di
presentare film accuratamente selezionati? Innanzitutto volgere uno sguardo altro,
e trovare un modo altro di raccontare, un punto di vista
femminile sul mondo, sulla vita: storie di donne viste dal-l’interno, storie
di donne raccontate da altre donne. Rivedere film prodotti in tempi diversi,
andare a riscoprire l’universo stesso delle donne e rivivere con loro i
nostri sentimenti per trasformarli in storia è stata una meravigliosa
avventura. Pensare al cinema e alle donne può riportare la mente alle femmes
fatales, alle eroine, alle Giovanne d’Arco, alle comprimarie dell’eroe
maschio, a tutte quelle che hanno acceso i desideri degli uomini e che hanno
contribuito a creare un pericoloso stereotipo di figura femminile, oggetto di
consumo o sempre in funzione di… . Ma rivedere con uno sguardo altro il
cinema e le storie delle donne può al tempo stesso mettere nella giusta luce
il ruolo determinante di una madre, moglie, amante, amica, di donne non
necessariamente legate ad un uomo, dare cioè un senso più fondante a tante
esistenze comuni e non, spes-so trascurate o dimenticate, mettere in evidenza
il comune sentire delle donne esaltarne la dignità, le frustrazioni, ma
soprattutto quei valori che da secoli costituiscono le vere fondamenta della
società. Il cinema, ieri come oggi, ha saputo rappresentare forse meglio di
ogni altra espressione artistica, l’anima di un’epoca storica, di proiettare
sullo schermo le speranze, le gioie e i dolori di una società in fieri e
ha saputo influenzare con grande capacità lo spettatore/trice
coinvolgendolo/a in questo fluire di sentimenti sempre diversi. Non è
difficile immaginare quindi quale potere abbia avuto il cinema sull’immaginario
collettivo, quando l’autorità era essenzialmente maschile (registi) e alle
donne erano riservati i ruoli di secondo piano o modi di essere di altri e
quando cioè tutto un universo girava intorno agli uomini unici soggetti della
“storia” fino a rasentare una quasi misoginia in generi come il Western o i
film di guerra. Negli anni ’70 il movimento femminista ha rivoluzionato con
le sue teorie i modelli dominanti allora in voga nel mondo cinematografico e
ha distrutto lo sguardo patriarcale che irretiva in un gioco di desideri la
figura femminile e l’immaginazione dello spettatore. Ha dimostrato di poter
rompere con la narrazione classica e sessuata, di fondare un modo diverso di
raccontare. Narrare non è mai asessuato, o neutro, occorreva trovare un
linguaggio filmico “di genere”
|
|
in
cui le donne si autorappresentano e rappresentano le proprie storie senza gli
idola theatri. Dare spazio all’immaginazione femminile e al suo
desiderio è stata un’operazione politica, di politica delle donne, un gesto
di autodeterminazione in chiave estetica. Il linguaggio simbolico del cinema
ha dato legittimità e cittadinanza ad un sentire “differente” ma reale che
finora non aveva avuto visibilità nel gioco prettamente maschile della
rappresentazione. Si intuisce come le nostre scelte cinematografiche
privilegino il cinema delle donne con le donne, e come attraverso la
rappresentazione delle loro storie abbiamo voluto mettere in circolo i loro
saperi, le loro emozioni, le loro gesta, la loro “storica quotidianità”.
Affrontando in una attenta sintesi temi diversi dell’universo femminile, questo
volume raccoglie analisi e riflessioni maturate dalle donne durante gli
incontri promossi dalla Biblioteca in occasione dei cineforum. La scelta dei
film e le schede di lettura cinematografica sono state riferite alla
promozione delle pari opportunità con lo scopo di rimuovere gli stereotipi di
ruolo e di creare relazioni e cultura di genere.
|
|
Le tematiche più significative,
affrontate nei dibattiti e recensite durante questo excursus, sono state:
|
|
La donna nel cinema e
nella letteratura
|
|
Una rassegna di film tratti da libri di scrittrici e confronto tra linguaggio scritto e quello
visivo:
|
|
•
Ragione
e sentimento -di Ang Lee
•
Mrs
Dalloway -di Marleen Gorris
•
Marianna
Ucrìa -di Roberto Faenza
•
La
casa degli spiriti -di Bille August
•
D’amore
e ombra -di Betty Kaplan
•
Il
colore viola -di Steven Spielberg
|
|
Donne e relazioni fra donne
|
|
Ricerca e ri-nascita di un modo nuovo di “fare politica”, intesa anticamente dai Greci come
“l’arte del vivere bene insieme”, l’arte di creare relazione genealogiche al
femminile e di scoprire un mondo comune di valori, di sentimenti, di
aspirazioni attraverso la trama sottile dei ricordi:
|
|
•
Piccole
donne -di Gillian Arm Strong
•
Camilla
-di Deepa Mehta
•
Gli anni dei ricordi -di Jocelyn Moorhouse
•
Anni di piombo -di Margareth Von Trotta
•
L’albero
di Antonia -di Marleen Gorris
•
Relazioni
pericolose -di Stephen Friars
|
|
Donne nel cinema e nella storia
|
|
Ricerca e confronto di immagini e ruoli femminili nel cinema e nella storia al fine di ricostruire
un’identità femminile attraverso il recupero di genealogie che hanno
valorizzato l’esperienza e la soggettività storica delle donne spesso
dimenticata tra le pieghe della storiografia ufficiale:
|
|
•
Shakespeare
in love -di John Madden
•
Storia
di una capinera -di Franco Zeffirelli
•
Come
eravamo -di Sydney Pollack
•
La
scelta di Sophie -di Alan J. Pakula
•
Elisabeth -di Shekhar Kapur
|
|
Analisi dell’alienazione femminile all’interno delle tre religioni monoteistiche e
del processo di emancipazione scaturito dal desiderio di autodeterminarsi delle donne, schiacciate dal secolare integralismo religioso presente nelle
società di ogni epoca:
|
|
•
Il
gioco dei rubini -di Boaz Yakin
•
Il
cerchio -di Jafar Panahi
•
Agnese
di Dio -di Norman Jewison
•
Giovanna
d’Arco -di Luc Besson
•
Kadosh
-di Amoi Gitai
•
Yentl
-di Barbra Streisand
•
Jesus
Christ Superstar -di Norman Jewison
•
La
settima stanza -di Marta Meszaros
|
|
Maria Grazia Riveruzzi Paola
Nucciarelli
|
|
Tratto dal romanzo di
Jane Austen
|
|
Regia: Ang Lee Sceneggiatura:
Emma Thompson Fotografia: Michael Coulter Costumi:
Jenny Beavan, Jonn Bright Musiche: Patrick Doyle Prodotto:
Lindsay Doran
|
|
2 Globi d’oro: sceneggiatura e film durata 135’
|
|
Personaggi e interpreti Elinor:
Emma Thompson Marianne: Kate Winslet Brandon: Alan Rickman Willoughby:
Greg Wise Edward: Hugh Grant
|
|
* a cura di Marisa Rotiroti
|
|
Tratto dal romanzo “Sense
and Sensibility” scritto con lucida ironia da Jane Austen, s’inserisce
nel fertile filone che, da Jo March a Jane Eyre, offre la scena a figure
cardine della soggettività femminile moderna.
|
|
“Una di quelle fate
che vigilano sulle culle deve averle fatto compiere, appena nata, un volo per
il mondo. Quando di nuovo fu posta a giacere nella culla, sapeva non solo
come era fatto il mondo, ma già aveva scelto il suo regno. Aveva accettato
che, se avesse potuto dominare quel territorio, non ne avrebbe desiderato
altro”. (Virginia
Woolf)
|
|
La storia raccontata da Jane Austen
e ambientata nella provincia inglese d’inizio ‘800, prima dell’età
vittoriana, nasce dal contrasto di carattere tra le due sorelle Dashwod:
Elinor e Marianne. Tranquilla, ragionevole, piena di buon senso, pronta ad
adeguarsi alle ragioni dell’ordine sociale in cui vive la maggiore Elinor
(Emma Thompson); appassionata, estroversa, sensibile, incapace di accettare
le regole che la società vorrebbe imporre al suo cuore Marianne (Kate
Winslet). Alla morte del padre, (a causa delle rigide leggi britanniche che
vogliono erede del patrimonio familiare il figlio primogenito), sono
costrette a lasciare la casa di Norland, dove sono sempre vissute, al
fratellastro Jonn. Si trasferiranno insieme con la madre e la sorellina
Margareth a Barton, nel Devonshire, in un modesto cottage, messo a loro
disposizione da sir Jonn Middleton, con un appannaggio di 500 sterline
l’anno. Le due ragazze non possono aspettarsi granché dalla vita perché non
hanno dote. Come conciliare, quindi, le speranze del cuore con le regole
della società? La vita al cottage scorre abbastanza serenamente: le ragazze
leggono, dipingono, suonano il pianoforte, fanno lunghe passeggiate, sono
spesso invitate in
|
|
casa
dei signori Middleton, che “conducevano un genere di vita in cui l’ospitalità
era pari all’eleganza. La prima era vanto di sir Jonn, l’altra della sua
signora”. Sotto l’aspetto gentilizio, le conversazioni brillanti e frivole,
le buone maniere della piccola aristocrazia di provincia s’intravede la
condizione femminile dell’800, i rituali sociali, le forme esasperate di
galateo, la fatica di adeguare buon senso e passioni senza farsi stritolare
dalle convenzioni e dai pregiudizi. Elinor è innamorata di Edward Ferrars,
cognato del fratellastro, un giovane incapace di dar voce al suo desiderio di
abbracciare la vita ecclesiastica, per non contravvenire alle regole della
buona società e a quelle della madre, che desidera per lui una brillante
carriera nell’esercito. Egli, pur amando Elinor, non può mostrarle i suoi
sentimenti perché da cinque anni è segretamente fidanzato con Lucy Steele, la
quale, quando lui verrà diseredato dalla madre proprio a causa di questo suo
fidanzamento segreto con lei (donna senza alcuna possibilità economica),
preferirà sposare Robert, il fratello minore divenuto ricco. Elinor alla fine
sposerà il suo Edward che diverrà rettore nella parrocchia di Delaford, di
proprietà del colonnello Brandon, amico di sir Jonn e innamorato di Marianne.
Il colonnello Brandon è un uomo di 35 anni serio e silenzioso e “quantunque
il suo viso non fosse bello, aveva una fisionomia intelligente e modi
particolarmente signorili”. Marianne s’innamorerà del giovane Willoughby,
“dotato di molte qualità, pronta immaginazione, vivacità di spirito e
maniere aperte e cordiali. Era fatto in tutto e per tutto per attirare il
cuore di Marianne, perché univa a quelle doti non solo una figura attraente,
ma un naturale ardore dell’animo”. Egli, però, era superficiale e privo di
scrupoli. Abbandonerà Marianne per sposare una donna ricca. Anche lui vittima
di forti condizionamenti sociali, si riscatterà solo alla fine quando sa che
Marianne è gravemente ammalata e corre da lei. Non potrà vederla, ma parlerà
con la sorella, le confiderà la sua sofferenza, i suoi sensi di colpa e i
sentimenti nutriti per Marianne. Nel film questo colloquio è sostituito da
una scena molto bella: Marianne e il colonnello Brandon sposi escono dalla
chiesa: sullo sfondo, in cima alla collina, un cavaliere su un bianco
destriero osserva commosso la coppia e si allontana al gran galoppo.
|
|
“Il Principe
azzurro non è altro che un cavaliere su di un cavallo!….”
|
|
“ Ragione e sentimento ” è la traduzione italiana di “Sense
and sensibility” meno bella di quella letterale “Senno e sensibilità” o,
meglio, “Buon senso e sensibilità”. Sense e Sensibility hanno
in comune non solo la radice, ma sono due elementi imprescindibili della
conoscenza, che passa attraverso i cinque sensi e ad essi associa un sesto
elemento della coscienza che è relazione intellettuale: “l’acquisizione della
capacità di ragionare in accordo con le cose” dice Nadia Fusini in “Uomini e
donne” (Donzelli). Senno Elinor, sensibilità Marianne
sono le due sorelle, personaggi femminili del romanzo. Opposti eppure
uguali, sdoppiamento simbiotico della scrittrice, fratture tragiche di
identità divise, esse rappresentano, con le sorelle Bronte e
|
|
Virginia
Woolf, il conflitto di gran parte della letteratura femminile del tempo. La
traduzione italiana “Ragione e sentimento” facendo riferimento ai due
grandi movimenti culturali del secolo XVIII (Illuminismo -Ragione) e
del secolo XIX (Romanticismo -Sentimento), è limitativa
rispetto al significato più ampio di sense che, per me, è relazione
intellettuale. Marianne, è vero, ama romanticamente, ma non al modo dello
Sturm und Drang: ella mostra un modo di stare al mondo con la
consapevolezza delle proprie fragilità senza arrendersi al desiderio (il
desiderio indica una mancanza), vive intensamente le sue emozioni, si mette
in gioco e... cresce, matura una nuova consapevolezza di sé, trova la sua
misura. Come Ada in “Lezioni di piano” di Jane Campion, abbandona in
fondo all’oceano il proprio pianoforte divenuto ingombrante e ricomincia a
suonare su un nuovo pianoforte con un dito in meno, così Marianne, purificato
sotto la pioggia il suo dolore per l’abbandono di Willoughby , ritorna alla
vita. (Questa scena nel film è stata risolta in maniera sbrigativa) Vivere
in accordo con la realtà è il matrimonio di Marianne col colonnello
Brandon. Il film, che ha guadagnato due globi d’oro per il miglior film e la
migliore sceneggiatura, è ideato da donne (Jane Austen, la scrittrice,
Lindsay Doran la produttrice, Emma Thompson la sceneggiatrice e
protagonista) e diretto da un uomo, il cinese di Taiwan Ang Lee. Ang
Lee riesce a combinare felicemente rigore formale inglese e magiche ispirazioni
d’oriente. Simile, infatti, a quello cinese è il microcosmo familiare e
sociale della Austen: i riti fortemente codificati, il rispetto delle forme,
la difficoltà nella comunicazione emotiva, l’assillo dell’armonia, la
ricerca di un equilibrio tra gli opposti. Anche nella sapienza con cui sono
inquadrati i paesaggi, i cieli, le piogge inglesi troviamo qualcosa di
orientale. Il lavoro di Ang Lee, però, non sarebbe stato possibile se Emma
Thompson non avesse sceneggiato, scandito, dialogato, riscritto il romanzo
nel modo in cui lo ha fatto, rispettando il genio comico della scrittrice; se
Jenny Beavan e Jonn Bright (i costumisti) non avessero mirabilmente
ricostruito la moda britannica del tempo; se in definitiva non avesse avuto
“gli ingredienti” che lui in qualità di “cuoco” (come si è definito in un’intervista
rilasciata dopo la realizzazione di “Mangiare Bere Uomo Donna) ha messo
insieme abilmente. In questa commedia, sostenuta dall’ironia e dall’umorismo,
in cui il motore centrale è il denaro, la lucidità dello sguardo è
conservata nella struttura espositiva agile, favolistica, che non fa sentire
i 135 minuti della sua durata. I personaggi, dove “i deboli sono gli uomini
(eccetto il colonnello Brandon Alan Rickman) e l’unica arpia è una donna (la
sorella di Edward), sono interpretati da una affiatata squadra di attori
inglesi tra i quali sarebbe ingiusto prima che ingeneroso stabilire una
gerarchia di bravura. In prima fila Kate Winslet, l’appassionata Marianne...
e Emma Thompson, la diciannovenne Elinor così degna nel suo self control”.
(Rivista del cinematografo n. 4/96 Morando Morandini , critico
cinematografico de “Il Giorno”).
|
|
La scrittrice: Jane
Austen (1775-1817) e il romanzo
|
|
La figura di Jane
Austen si staglia nel panorama europeo del XIX secolo come innovatrice nel
campo del romanzo di costume al quale diede qualità d’arte. Ella s’inventò
uno stile perfettamente naturale ed elegante, adeguato alle sue necessità e
al quale rimase sempre fedele. Libertà di pensiero e pienezza d’espressione
sono l’essenza della sua arte. La sua conoscenza e capacità di penetrazione
dell’animo umano, la sua consapevolezza ironica del conflitto tra spontaneità
e convenzione, tra esigenze della moralità individuale e della convenienza
sociale ed economica, fanno di lei una grande scrittrice, antesignana del
romanzo moderno secondo schemi che verranno poi seguiti senza significative
variazioni da tutti gli autori/trici a venire; a lei si ispirarono sia
Charles Dickens che Henry James. La straordinaria modernità di Jane Austen in
termini di sensibilità, è stata riconosciuta tra gli altri da Virginia
Woolf che nel bellissimo saggio “Una stanza tutta per sé” dice: “Scrisse
come scrivono le donne” e poi, riferendosi a lei e alle sorelle Charlotte
ed Emily Bronte, “fra le mille donne che scrivevano romanzi in
quell’epoca, furono le sole a ignorare completamente i perpetui ammonimenti
dell’eterno pedagogo: scrivi questo, pensa quello. Furono le sole a
dimostrarsi sorde a quella voce (ora insistente, ora brontolante, ora
condiscendente, ora ferita, ora dominante, ora scandalizzata, ora familiare)
che non lascia in pace le donne, ma deve sempre inseguirle come una
governante troppo onesta”.
|
|
Jane Austen, vissuta a
cavallo tra il 700 e l’800, oltre ad aver impersonato le culture che hanno
caratterizzato quei due secoli: la cultura illuministica e quella romantica,
fu partecipe del grande mutamento che avvenne alla fine del 1700 (mutamento
più importante delle Crociate e della Guerra delle due Rose): la donna
della classe media comincia a scrivere. Questa scrive nella stanza di
soggiorno della famiglia perché la famiglia di classe media possedeva
sol-tanto una stanza di soggiorno. Jane Austen, figlia di un pastore
protestante della contea dello Hampshire e settima di otto figli, scriveva
in quella stanza di soggiorno dove era soggetta a molte interruzioni, ma dove
aveva sempre dinanzi agli occhi lo spettacolo delle relazioni umane. Ebbe un
rapporto particolare con la sorella Cassandra, che fu nfidente per tutta la
vita. Cominciò a scrivere in età molto giovane esclusivamente per la sua
cerchia familiare, ma questo non le impedì di fare un’analisi spietata e
ironica dell’ambiente sociale del suo tempo; il piccolo mondo aristocratico
della provincia inglese tra il 1700 e il 1800. La sua istruzione e quella di
Cassandra alla Abbay Boarding School a Reading (troviamo qualche
rassomiglianza con la scuola di Mrs Goddard in “Emma”) avvenne nella
famiglia. Ebbero, come insegnante, oltre al padre, Mrs Cawly, moglie di un
loro zio che era vissuta a Oxford. In casa imparavano a dipingere, a suonare
il pianoforte, a …leggere anche: dalla biblioteca paterna che già nei 1801
contava 500 libri. Lesse parecchio sia della letteratura seria che popolare,
e scrisse che nella sua famiglia erano grandi lettori di romanzi e non si
vergognavano di esserlo. Le
|
|
furono familiari i
romanzi di Fielding e di Richardson, molto meno inibiti di quelli della
successiva epoca vittoriana. Il suo primo romanzo “Ragione e
sentimento”, pubblicato nel 1811, risale a una precedente stesura (1795)
ora andata perduta, di quando era poco più che ventenne. E’ forse il meno
perfetto dei suoi romanzi, ma, come scrisse il
|
|
Daiches “la cristallina
precisione dello stile, la struttura equilibrata delle frasi e dei paragrafi,
il quieto, abile ordine in cui succedono dialoghi e avvenimenti, sono già
quelli delle opere maggiori”. La pubblicazione avvenne a suo rischio e fu
anonima (By a Lady – da una donna). In seguito pubblicò: “Orgoglio e
pregiudizio”, il suo capolavoro, “L’Abbazia di Northanger”, “Mansfield
Park”, “Persuasione”, “Emma”. Della lettere (circa 100)
scritte alla sorella non rimane quasi nulla, “Sandition”, iniziato nei
primi giorni del 1817, non fu mai completato a causa della sua morte (pare,
per il morbo di Hadson), avvenuta a Winchester venerdì 18 luglio 1817, dove
si era recata per cure mediche. Fu sepolta nella Cattedrale di Winchester il
24 luglio. “Vergine Letteraria”, giace ora nella Cattedrale di Westminster
accanto ad altri grandi della storia britannica. Da più di mezzo secolo in
Inghilterra esiste un vero culto di Jane Austen e quel culto viene praticato
da una piccola, agguerrita setta di lettori chiamati Janeites, che
dagli anni ’80 in poi hanno seguito, analizzato e severamente giudicato le
riduzioni televisive dei romanzi austeniani prodotti dalla BBC.
|
|
Jane Austen tra cinema
e letteratura “Orgoglio e Pregiudizio” divenne un film MGM nel 1940,
interpretato da Laurence Olivier e rifatto dalla BBC nel 1980 e nel 1995. La
BBC Britannica produsse anche negli stessi anni “Sense and Sensibility”
“Mansfield Park” fu realizzato nel 1966 e “Northanger Abbey” nel
1987. “Persuasione” ebbe due riduzioni televisive nel 1969 (TV) e nel
1988 (BBC). “Emma” è stato scritto e diretto da Douglas Mc Crath.
|
|
Il regista Ang Lee è nato nel 1954
in Taiwan. Dal 1973 al 1976 ha studiato teatro e cinema presso l’Accademia
delle Arti a Taipei, e ha realizzato i suoi primi film in super 8. Nel 1978
ha lasciato il suo paese per gli U.S.A. dove si è laureato in Arte
Drammatica all’Università dell’Illinois. In seguito ha fatto un master come
regista all’Università di New York. Mentre studiava ha girato diver-si film
brevi e anche un film di media lunghezza chiamato Fine Line (1985), che gli
ha fatto vincere due premi (miglior film e miglior regista) al festival
Universitario del cinema di New York. Ang Lee ha intrapreso una carriera promettente
con Pushing Hands (Mani che spingono) mostrato nel 1992 nella sezione
“Panorama” a Berlino. “Il Banchetto di nozze”, nominato per un Oscar e per
l’Orso d’oro al festival di Berlino nel 1993, è stato un successo di critica
e un film popolare. Il tema esplo
|
|
rato
in questo film è il tema dell’identità, che fa dichiarare ad Ang Lee: “l’identità
per noi taiwanesi è un problema che la nostra breve, contraddittoria storia
non può fornire. Nel “Banchetto di nozze” identità culturali, nazionali,
familiari e individuali si contraddicono l’un l’altro”.
|
|
Il suo terzo
lungometraggio “Mangia Bevi Uomo Donna” del 1994 è una commedia melodrammatica
sui valori tradizionali cinesi mescolati con la modernità occidentale: i
costumi ancestrali si fondono con rituali urbani in cui lo spirito della
tradizione evapora lasciando posto solo per bugie e giochi. Quando parla
della realizzazione dei suoi film, Ang Lee utilizza una metafora culinaria
“essere chiamato regista dà un senso di potere……, ma in realtà non abbiamo
alcun reale potere: tutto ciò che facciamo è selezionare gli ingredienti,
mentre si gira, e metterli insieme durante il montaggio. In fondo il regista
è solo un cuoco”. Nel 1995 ha diretto “Ragione e sentimento”, che gli è valso
due Globi d’oro: migliore sceneggiatura e miglior film, e sette nomination
all’Oscar. Nel 1997 è stato ospite presso l’Università dell’Illinois in
occasione della rassegna cinematografica dei suoi film, sponsorizzata dal
Centro di Studi per l’Asia Orientale e del Pacifico. Lo scopo del centro è
coordinare, promuovere, sviluppare e divulgare gli studi dell’area orientale:
Pacifico e Asia Orientale.
|
|
Gran Bretagna 1997 Regia: Marleen Gorris Soggetto e sceneggiatura:
Eilen Atkins Musiche: Ilona Sekacz Direttore Fotografia:
Sue Gibson Scenografia: David Richens Costumi: Judy
Pepperdine Personaggi e Interpreti: Mrs Dalloway : Vanessa
Redgeave Clarissa Dalloway: Natascha McElhone Septimus
Warren Smith: Rupert Graves Peter Walsch: Michael
Kitchen Richard Dalloway: John Stunding Peter giovane:
Alan Cox Sally gio Vane: Lena Headey Lady Burton:
Margaret Tyzack Durata: 97’
|
|
*a cura di Angiola
Alferazzi
|
|
Tratto dal romanzo
omonimo di Virginia Woolf. L’azione è concentrata in un solo giorno. Comincia
nel mezzo della vita della protagonista e poi ne completa la parte
antecedente e la seguente. Tutto si svolge attraverso le impressioni e i
ricordi della mente di Clarissa e di alcuni personaggi. Non c’è trama, ma una
successione di immagini che man mano prendono esistenza dinamica e
sequenziale. Vi sono due linee intrecciate di sviluppo che si accentrano su
due personaggi, Clarissa e Septimus, un reduce colpito da chock: Una linea
segue il corso della giornata nello sviluppo lineare del libro, l’altra segue
il profondo della coscienza dei personaggi e porta l’uno verso la morte,
l’altra verso il sospeso equilibrio della vita. Le vicende di Clarissa e di
Septimus procedono parallelamente, dando l’impressione di una certa attinenza
che verrà resa manifesta solo alla fine, quando i temi della vita espressi
dal flusso della coscienza di Septimusangoscia, aggressività, ma anche
colori, suoni, uccelli che cantano in greco si raccolgono in lei. Attraverso
il suicidio del suo alter ego Clarissa intuisce il significato della morte
come momento di verità e di estasi. La cognizione del dolo-re la porta al
riconoscimento del valore inestimabile della vita, alla consapevolezza di un
nuovo senso dell’esistenza e della solidarietà.
|
|
Non c’è dunque trama
vera e propria. C’è una situazione che nei fatti dura una giornata, mentre
nel tempo interiore abbraccia due esistenze. L’azione è ambientata al centro
di Londra ed è scandita dai rintocchi del Big Ben che del tempo rappresentano
solo un’illusione. Perché il tempo il vero tempo non appartiene a nessun
orologio, ma è il momento, l’attimo in cui un turbamento passa nella
coscienza e la spinge a guardare nella sua profondità; è il tempo delle
emozioni che segna il fluire di un mondo interiore, e che si ribella al tempo
ufficiale perché è falso, perché non tiene conto della vera realtà, quella
costituita dal movimento della vita interiore, fatto di una serie di visioni
in cui il fisico stesso della persona scompare. La protagonista non è
descritta mentre progredisce nel tempo, ma è fissata nello spazio di un
giorno, è presentata in tutte le sfumature del suo carattere,attraverso i
continui riferimenti al passato. Se il tempo ufficiale tiene distinti
passato e presente, nel tempo vero c’è una continua integrazione dei due
momenti. Sicché il presente di Mrs Dalloway, moglie di un membro del parlamento
è continuamente mescolato al suo passato, ai suoi giorni a Burton, all’amore
per Peter Walsh, al rapporto con Sally, così come il tormento presente di
Septimus è frutto dei ricordi che si presentano con insistenti flashback del
periodo passato in guerra. Il ricordo, la memoria, movimenti essenziali della
vita interiore, riuniscono l’unica realtà che è quella dell’esistenza
interiore che avviene nella coscienza attraverso stadi che avanzano sempre
più incalzanti verso la visione finale, in cui avviene l’identificazione
della realtà. Clarissa riesce a vincere il terrore del suicidio e a trovare
attimi in cui conosce la gioia di esistere, mentre Septimus, il suo doppi,
soccombe al pensiero del passato che gli riporta solo angoscia e morte. Nel
libro, e con buoni risultati nel film, i fatti sono resi attraverso una serie
di immagini, le sole a poter rendere il movimento della vita interiore. Come
osserva il Praz, la tecnica della Woolf “potrebbe accostarsi a quella del puntinismo.
Essa si sottopone ad una doccia di immagini, così come la vita ci mette sotto
una doccia di sensazioni”. Virginia Woolf, lottando contro la limitatezza dei
mezzi esressivi, cerca di esprimere le sue visioni attraverso immagini,
talvolta metaforiche; la loro funzione è di allargare ed espandere concetti,
approfondire significati, comprendere maggiormente i personaggi. In Mrs
Dalloway troviamo insistenti le immagini del mondo Woolfiano:le onde,
fluidità, mobilità delle cose, la stanza che rappresenta il rifugio segreto
del proprio io, la finestra tempo esterno, il sole, il suono del Big Ben,
che assumono tutte valore specifico e sempre diverso a seconda dell’attimo
psicologico in cui il personaggio le recepisce. L’immagine che ricorre più
frequentemente e con azione coordinatrice e rivelatrice è il Big Ben le cui
campane con “suono martellante” non solo forniscono la struttura
esterno-temporale della storia, ma con la loro ossessività creano una
tensione drammatica nella descrizione del pensiero e della vita dei
personaggi.
|
|
La scrittrice: Virginia Woolf
|
|
Nata a Londra nel
1882, morì suicida a Rodmell nel 1941. È la terza figlia di Leslie e Julia
Stephen, ma sia la madre che il padre avevano avuto altri figli da precedenti
matrimoni. Il padre era un intellettuale famoso. Alla nascita di Virginia era
impegnato nella compilazione del Dictionary of National Bibliography. La
madre era bellissima, e come lei la nonna, una delle sette sorelle Pratile,
tutte famose per la loro bellezza. In più la settima, era una fotografa
straordinaria. Come dimostrano le foto che farà a Virginia e a sua madre.
Nella casa intellettuale e colta le fanciulle ricevettero un’istruzione
privata, mentre i figli maschi furono liberi di frequentare l’università di
Cambridge. È così che grazie al fratello Thoby, che Virginia e sua sorella
Vanessa vennero in contatto con giovani uomini, che all’inizio del secolo
sfidavano le convenzioni più brutalmente repressive della società
vittoriana. I fratelli Stehen andarono ad abitare a Bloomsbury, allora un
quartiere povero, che dominerà per un ventennio la vita intellettuale
londinese. Darà un suo stile a un’epoca. Irriverenti, inquieti, i giovani di
Bloomsbury volevano riscrivere la politica, l’economia, la letteratura. Fra
questi c’è Leonard Woolf che Virginia sposò. Con questo nome, Virginia Woolf,
firmò il suo primo romanzo, La crociera nel 1913. Con il marito fondò
poi la casa editrice Hogarth Press, dove usciranno alcune opere sperimentali
di questo secolo e i romanzi di Virginia. Nel 1941, un mese dopo aver terminato
Tra un atto e l’altro, atterrita dai segni di un’ennesima crisi
depressiva, spaventata dalla guerra (Il guerra mondiale), dalle sue promesse
di morte, si lasciò morire annegando nel fiume Ouse che scorreva sotto
l’amata casa di Rodmell. Le sue opere la confermano come tra le maggiori
scrittrici di questo secolo, fra le numerose produzioni ne citiamo:
|
|
Notte e giorno – 1919
La stanza di Giacobbe – 1922 La signora Dalloway – 1925 Al faro – 1927
Orlando – 1928 Una stanza tutta per sé – 1929 Le onde – 1931 Le tre ghinee –
1938 Gli anni – 1937 Tra un atto e l’altro – 1941
|
|
La regista: Marleen
Gorris
|
|
Mrs. Dalloway è
diretto da Marleen Gorris, una regista olandese nata nel 1950. I suoi primi
due films “A question of silence” (1982) e “Broken mirrors” (1984) le hanno
guadagnato la definizione da parte della stampa di “eurofemminista
arrabbiata”. Una definizione che la stessa Gorris rigetta preferendo
considerare il suo femminismo niente di più che “l’espressione di un punto
di vista personale” che poco ha a che vedere con l’ideologia politica o con
la propria identificazione con qualsiasi gruppo organizzato.
|
|
Dopo quindici anni di
“oscurantismo olandese”, la Gorris ha ottenuto il riconoscimento
internazionale guadagnando l’Oscar per il miglior film straniero nel 1997 con
“L’Albero di Antonia”. E’ stato questo successo a portare Eileen Atkins e
Vanessa Redgrave a proporle la regia di “Mrs Dalloway”. I due films hanno
qualche tema in comune. Entrambe le storie ritraggono una giornata nella vita
di una donna, e tornano indietro con la memoria, sono ginocentriche col tema
del lesbismo. In tutti e due i casi si tratta di un mondo senza Dio, nel
quale si può vivere, ma non ci si può salvare. La sceneggiatura del film è di
Eileen Atkins e sulla fedeltà o meno della riscrittura cinematografica i
pareri sono discordi, in qualche caso nettamente negati
|
|
vi. In verità la
grandezza del romanzo, col suo linguaggio poetico lascerebbe perplessi sulla
possibilità di un trasposizione così esplicita come quella cinematografica,
ma lo stesso Joyce, la cui “stream of consciousness” è ancora più arcana si
diceva in parte ispirato da ciò che allora era il miracolo della tecnica
cinematografica. La Atkins ha dimostrato che è possibile il procedimento
inverso. Il film quindi è fedele all’autrice perché segue l’intenzione
centrale della storia; l’ambientazione è accurata, “tutto è nitido,
levigato, ovattato, contenuto”.
|
|
Italia 1996 Regia: Roberto Faenza Soggetto: tratto
dal romanzo di Dacia Maraini “La lunga vita di Marianna Ucrìa” Fotografia:
Tonino delli Colli Musica: Franco Piersanti Scenografia
e costumi: Danilo Donati Personaggi e Interpreti: Marianna:
Emmanuel Laborit marito – zio: Roberto Herlitza madre:
Laura Morante nonno: Philippe Noiret il precettore:
Bernard Girudeau Fila: Selvaggia Quattrini Saro: Lorenzo
Crespi Laura Betti, Eva Grieco et altri….. Produzione: Cecchi
Gori
|
|
*a cura di Francesca Lo Vecchio
|
|
Il film ambientato a Palermo nella
seconda metà del ‘700, racconta la storia di Marianna, giovane aristocratica
muta fin dalla tenera infanzia. Il mutismo di Marianna è il tema principale
del romanzo in quanto attraverso la negazione della parola la protagonista
rappresenta la sua libertà interiore contro le convenzioni sociali e le
imposizioni familiari. Marianna vive nel suo mondo muto e silenzioso, ma ciò
non le impedisce di vedere le grandi ingiustizie del mondo. All’età di 13
anni, ancora bambina è costretta, nonostante il suo netto e deciso rifiuto a
sposare un vecchio zio. Marianna comincia la sua vita da donna coltivando
comunque i suoi interessi e dedicandosi alla pittura. Metterà alla luce tre
femmine e un maschio e da Palermo, contro la volontà del marito, si
trasferirà in una villa di campagna isolata, ma piena di libri. C’è uno
strano sodalizio fatto di complicità tra lei e il nonno che intuisce la sensibilità
e l’intelligenza di Marianna alla quale lascia tutti i suoi averi scandalizzando
l’intera famiglia. Marianna resta vedova molto giovane e manda avanti con
caparbietà e decisione le sue proprietà, destando la meraviglia dei suoi
lavoranti, che la consideravano una povera donna incapace. Soltanto Saro, il
fratello della sua domestica le dichiara il suo amore, ma Marianna anche se
attratta da lui, non riesce ancora a vivere liberamente e senza freni i suoi
sentimenti e fa in modo che Saro si sposi, per poter così interrompere ogni
loro rapporto. Dopo tanto tempo, anche perché nel frattempo Saro perde la
moglie in
|
|
modo
tragico, Marianna si concederà delle ore d’amore con Saro, assaporando per la
prima volta le gioie della passione. Nello stesso tempo scoprirà che il suo
handicap non era congenito, ma che era insorto in seguito allo stupro subito
a cinque anni proprio da parte dello zio-marito. Questa sconvolgente verità
la porterà a riflettere sulla sua esistenza e a partire, allontanandosi dalla
Sicilia, alla scoperta del mondo e di se stessa. Il suo mutismo è la
rappresentazione simbolica del suo profondo dissenso e del suo rifiuto a
comunicare con un mondo incapace di comprendere i sentimenti, gli ideali e le
speranze di una giovane donna. Marianna può ritenersi una donna libera a
tutti gli effetti, in quanto riesce a mantenere intatto il suo mondo interiore
e a scegliere in prima persona: fare l’amore con Saro e poi decidere di
abbandonarlo alla ricerca della libertà. Si affida alla lettura e alla
scrittura e diventa così una donna colta e intelligente riuscendo a
comprendere anche il marito con il quale non c’è mai stata un’intesa affetiva
e sessuale; si rivolgerà a una solitudine voluta, non imposta, cercata con
saggezza. L’altro tema del romanzo è la critica a un’aristocrazia immobile,
oziosa e pigra. La figura di Marianna Ucrìa è stata ispirata all’autrice
durante un viaggio a Bagheria, dove si era recata alla ricerca delle sue
radici. La visita a Villa Valguarnera, casa nobiliare dei nonni materni, costruita
nel ‘700 e la visione del ritratto di una sua antenata che vedeva fin da
bambina, le ispireranno la protagonista del romanzo. Il libro, oltre a
essere tra i più amati dal pubblico femminile, è stato stampato in più di
300.000 copie ed è stato tradotto in 19 lingue. Il film di Roberto Faenza
resta più o meno fedele al testo letterario, ma sostituisce la figura
paterna con quella del nonno e mantiene il senso omertoso e ipocrita che
unisce tutti i membri della famiglia in una complicità e in un silenzio che
è più forte di quello di Marianna. La metafora del silenzio è parte della
cultura femminile tanto nella tradizione classica quanto nel presente
cinematografico. “Non è che le donne non parlino, o non siano capaci di
esprimere il loro vissuto -afferma Maraini -ma spes-so la loro parola è
sorda, non arriva da nessuna parte. È priva di prestigio e di potere. Per
questo la storia di Marianna è molto sentita e condivisa. Perché è condiviso
il suo silenzio”. Il romanzo “La lunga vita di Marianna Ucrìa”, pubblicato
nel 1990, ha ricevuto, in quello stesso anno il Premio Campiello.
|
|
La scrittrice : Dacia
Maraini
|
|
È nata a Firenze nel
1936 da una coppia giovane, bella e contestatrice, il padre Fosco seducente e
avventuroso e la madre Topazia Valguarnera di illustre nobiltà siciliana. Da
questo matrimonio, oltre a Dacia nacquero Vuki e Toni. Abitavano a Fiesole,
ma durante le vacanze tornavano nella villa di Bagheria, scontrandosi con la
mentalità ristretta e schiava di pregiudizi dei parenti siciliani. Bagherìa
sarà dapprima oggetto di un rifiuto totale da parte dell’adolescente , solo
più tardi diverrà il fulcro di un ritorno sia fisico che narrativo di Dacia.
|
|
La sua infanzia si svolgeva tra luci e ombre, c’era il contatto con
la natura, c’erano le letture appassionate e c’era un rapporto con il padre,
intenso, ma insidiato da dolorose consapevolezze. Quando il padre abbandonò
la famiglia Dacia soffrì moltissimo e scrive così: “Per tutta la mia infanzia
l’ho amato senza esserne ricambiata”. Questa figura paterna la ritroviamo poi
nelle sue scelte sentimentali (pensiamo a Moravia amato come un padre
-bambino) “mi piacciono gli uomini molto vecchi che ritornano infantili”
così lei scrive. Viene bocciata alla maturità e in attesa di pubblicare
qualcosa, pensa a un impiego come segretaria e in questo periodo incontra
Moravia. Nel 1962 Dacia diventa la compagna di Alberto Moravia che in
quell’anno si separa dalla moglie Elsa Morante. In questo periodo pubblica il
suo primo romanzo “Le vacanze” in cui c’è la rappresentazione di una
Bagherìa molle e corrotta. Lo stesso quadro di miseria fisica e morale, la
stessa Bagherìa meschina , senza ideali, la stessa solitudine di
un’adolescente tornavano nel romanzo successivo “L’età del malessere” che
viene pubblicato nel 1963. Nel 1967 pubblica un volume di racconti dal titolo
“Mio marito” dove Dacia Maraini denuncia il costume maschilista, ipocrita e
interessato che relegherebbe la donna al ruolo di angelo del focolare, dolce
e sottomesso, privo di personalità e di autonomia. Da una sua inchiesta sul
carcere di Rebibbia uscirà “Memorie di una ladra” nel 1972 e successivamente
nel 1974 la poesia “Donne mie”, considerato da molti il manifesto del
femminismo. La poesia è un’esortazione alle donne a ritrovare la propria dignità
e libertà, responsabili loro stesse del loro stato perché non si oppongono
alla volontà maschile. Ecco allora l’invito a dichiarare guerra non all’uomo
ma a un certo modo di essere donna, che spinge alla rivalità tra donne. Nel
1975 pubblica “Donne in guerra”, Ma dopo questo periodo assumerà un
atteggiamento più meditato e comprensivo sulla realtà. C’è la consapevolezza
maturata lentamente di un destino doloroso comune a tutti gli uomini e
donne, di una solitudine che è alla radice di ogni persona, indipendentemente
dal seso e dalle condizioni storiche. Nel 1986 Ha pubblicato “Il bambino
Alberto”, intervista con Moravia. Nel 1993 Bagherìa e nel 1994 “Voci”.
Bagherìa è un lungo racconto autobiografico che dipinge la Sicilia nel fluire
dei ricordi, con i suoi colori, i sapori e le luci di una terra antica e
sorprendente, ancorata a vecchi pregiudizi e a una mentalità chiusa. Ha
scritto inoltre “Lettere a Marina” 1981, “Il treno per Helsinki 1984,
“Lezioni d’amore” 1982, “Stravaganze” 1987. Ha pubblicato anche una raccolta
di poesie dal titolo “Viaggiando con passo di volpe” 1991. Dacia Maraini può
considerarsi senza dubbio la figura più rappresentativa del nostro panorama
letterario attuale.
|
|
Il regista: Roberto
Faenza
|
|
Oltre ad essere un
bravo regista è scrittore e docente universitario ( dal 1970 presso il
Federal College di Washington, dal 1977 presso l’Università di Pisa).
|
|
Ha iniziato la sua
carriera cinematografica nel 1968 con Escalation interpretato da Lino
Capolicchio e Gabriele Ferzetti. Nel 1978 ha realizzato il film di montaggio
Forza Italia. Ha diretto “Si salvi chi può” “Iona che visse nella balena”,
“Sostiene Pereira”. Ha diretto in maniera brillante “Marianna Ucrìa” che
vuole essere una storia di libertà e di emancipazione. La vita di Marianna è
dominata dalla sottomissione e dal silenzio, ma la sua mente e la sua
immaginazione sono piene di voci, prima fra tutte la voce dell’amore che una
società e una famiglia spaventosamente repressive le hanno negato. Tra le
ragioni dell’interesse di Roberto Faenza per la vicenda di Marianna c’è il
tema della memoria: una storia che racconta il passato, ma che in realtà
riguarda il presente. Del resto la straordinari unicità del grande schermo,
dice Faenza; consiste nel poter riportare a galla ciò che il tempo ha
confinato all’oblio, poter dare alla memoria perenne continuità. Il cinema,
egli dice, deve differenziarsi dalla televisione, ormai relegata a registrare
solo cronaca e attualità, proprio per la sua incapacità a rielaborare
memoria.
|
|
Tratto dal romanzo
omonimo di Isabel Allende Regia: Bille August Sceneggiatura:
Bille August Fotografia: Jorgen Persson Scenografia:
Anna Asp Musica: Hans Zimmer Montaggio: Janus
Billeskov Jansen Costumi: Barbara Baum Trucchi speciali:
Horst Stadlinger Co-Prodotto: Martin
Moszkowicz Prodotto: Bernd Eichinger Personaggi e
Interpreti: Esteban Trueba: Jeremy Irons Clara: Meryl
Streep
|
|
Ferula: Glenn Close Blanca:
Winona Ryder Pedro: Antonio Banderas
|
|
Transito: Maria Concita
Alonso
|
|
Esteban Garcia: Vincent Gallo Satigny:
Jan Nicklas Segundo: Joaquin Martinez Pancha: Sarita
Choudhury Rosa: Teri Polo Nana: Miriam Colon Germania
/ Danimarca / Portogallo / USA , 1993. 158’
|
|
È frequente che da libri famosi -è
il caso de “La casa degli spiriti di Isabel Allende -vengano realizzati dei
film altrettanto noti che, in alcuni casi contribuiscono ad accrescere il
successo e la diffusione del libro stesso. Ma qual è il rapporto tra le due
opere? È possibile una precisa trascrizione del-l’una nell’altra? E un libro
tradotto in linguaggio cinematografico è sempre riconoscibile? Conserva
ancora tutti i suoi caratteri, i suoi tratti, le caratteristiche che ne hanno
decretato il successo e che soprattutto lo hanno fatto amare dalle sue
lettrici e dai suoi lettori. È il problema consueto delle traduzioni. (E nel
caso specifico, di traduzione si tratta da un linguaggio, quello scritto che
permette percezioni del tutto personali e squisitamente interiorizzate, a un
linguaggio diverso, che s’avvale di tecniche, di mezzi espressivi, di
tensioni emozionali diverse, qual è il linguaggio visivo, il linguaggio per
immagini che raggiunge e opera la percezione emozionale attraverso il mezzo
diretto e immediato dello sguardo). È molto difficile, a mio avviso, che ciò
avvenga con assoluta fedeltà traspositiva e non perché un regista di vaglia
non sia in grado di riportare in immagini ciò che la parola di un libro detta
e regala, ma perché un’opera d’arte, un’opera compiuta, qualunque sia il suo
linguaggio, di parola o di immagi
|
|
ne,
cinematografico o teatrale, non può essere una “copia”, non può limitarsi a
“trascrivere”, da una forma all’altra. Deve necessariamente “ricreare”. E nel
ricreare, necessariamente pecca d’infedeltà. È altro. È diversa opera d’arte.
Un’opera compiuta, altra, non più quella. Più bella o più brutta a volte può
verificarsi che l’opera cinematografica, tratta da un grande libro, sia
addirittura più intensa, più bella, più compiuta del libro stesso (un caso
potrebbe essere “La casa degli spiriti” di Bille August, che ricostruendo la
saga familiare creata da Isabel Allende, la accende di luce nuova, la
arricchisce, dà spessore alle situazioni, alla trama narrativa ai paesaggi,
alle atmosfere e soprattutto ai personaggi facendo di Esteban, di Clara, di
Nivea, di Blanca, di Pedro, figure indimenticabili tali che altri non
potrebbero essere e che, in ultima analisi, arricchiscono il libro da cui sono
stati tratti e generati, di tale intensità e tale spessore, che è l’opera
letteraria a divenire debitrice di misura di emozione e di intensità e a
trovare, quindi, una consacrazione definitiva. È quanto avviene, quanto è
avvenuto per altri film famosi tratti da famosi libri: Parlo de “Il
Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa tradotto in linguaggio filmico da Luchino
Visconti, o de “Il Postino” di Skarmeta, interpretato magistral-mente da
Troisi, o de “Il Giardino dei Finzi Contini” di Bassani, divenuto notissimo
grazie al film di De Sica. Ma perché un miracolo di tal genere avvenga, qual
è la misteriosa alchimia che lega le due opere d’arte? Il regista del film
deve calarsi profondamente nel libro, intenderlo, amarlo e poi guardarlo con
gli occhi dell’anima e regalargli la “visibilità” che ne ricrea non tanto i
fatti narrati, quanto le atmosfere, il fascino le percezioni emotive, le
suggestioni. È quanto ha fatto il regista Bille August nel film in esame. “La
Casa degli spiriti” di Isabel Allende e di Bille August, sono non più la stessa
opera realizzata con due linguaggi diversi, ma due opere egualmente riuscite
e pienamente realizzate, con reciproco scambio. D’altra parte per chi avrà
letto il libro e poi visto il film sarà chiaro che il regista si è liberamente
ispirato al testo, che molti episodi del libro sono spariti, che, addirittura
i tempi si sono, come suol dirsi, accorciati, che alcuni personaggi sono
stati cancellati (vedi lo zio Marcos o i due fratelli di Blanca), tutto ciò
per esigenza di concretezza nel racconto essendo la saga familiare
dell’Allende assai estesa nel tempo, come d’altra parte avviene per molti
libri latino-americani a cui il racconto di Isabel Allende si avvicina per
climi ed atmosfere. Mi riferisco soprattutto a “Cent’anni di solitudine” di
Garcia Marquez, uno dei libri più fascinosi e misteriosi e ricchi e
debordanti e intensi che io abbia mai letto, o ai libri di Adolfo Bioy
Casares, grande scrittore argentino, scomparso da pochi giorni Da Marquez, la
Allende ha certamente tratto l’idea della lunga saga familiare, ma
soprattutto ha tratto le atmosfere misteriche che danno suggestione al libro.
|
|
“La Casa degli spiriti” è il bellissimo affresco di una
famiglia che si allarga ad affresco di una storia, di una terra, di un popolo,
di una tradizione. Atmosfere e tradizioni per noi molto lontane e come tali
intrise di fascinazioni. Il lungo rac
|
|
conto
a gola spiegata dell’Allende è reso in un linguaggio piano, diretto, che va
ai particolari delle cose e si sofferma sull’emozione del dettaglio (pensate
ai lunghi capelli verdi di Rosa che scivolano come un’onda verde dal tavolo
di cucina dove i medici operano sul suo corpo l’autopsia. Il libro si basa
sul fascino del paranormale e sui climi misteriosi, basti ricordare le
capacità divinatorie di Clara, i grandi e piccoli eventi, le sue strabilianti
interpretazioni dei sogni, il suo mutismo che, chiudendola alle piccole cose,
amplia i suoi orizzonti e le sue percezioni divinatorie. E poi, tutto lo
strano e affascinante rapporto con la morte e coi defunti. Nel libro
dell’Allende vive e ha senso la poesia del soprannaturale e del fantastico,
ma senza caratteri orrifici. È l’intero clima del libro a essere intriso di
magia, così come avvolti in un alone di magia o di misteriosa diversità sono
i personaggi piccoli e grandi che lo popolano -non solo Clara ed Esteban, o
Blanca o Pedro, ma anche i personaggi secondari, pensate a Ferula, a Nivea (e
alla sua strana morte agghiacciante per certi versi, ma consona al clima del
libro, che Clara aveva previsto) e alla tata Nana -le sue tenerezze, le sue
intuizioni, il largo e tenero abbraccio di cui è capace. La storia della
famiglia Trueba (e del Valle) via via che scorre la narrazione, diventa
storia di un popolo, e l’ultima parte del libro, si sposta dai climi stupefacenti
e magici verso eventi e vicende storiche del Cile a noi note, cariche di
tutti gli orrori che una testimone diretta, quale è stata Isabel Allende, può
riferire nella loro drammatica verità. Nell’ultima parte il romanzo dell’Allende
perde parte della sua fascinazione misterica, ma si carica di riflessioni e
considerazioni sulla libertà di un popolo e la drammaticità di una dittatura
militare. Ma, affidando la lettura del libro alle coscienze delle nuove
generazioni, sono tre gli elementi primari del romanzo che vorrei mettere a
fuoco per confrontarle poi con l’esito artistico del film che dal libro è
stato tratto e che porta lo stesso titolo. La morte. Presente in tutta
la letteratura ispano -americana (basti pensare a Garcia Marquez o a poeti
come Neruda -“io me ne rido della morte -semplicemente che io non ho paura
di morire tra uccelli e alberi -e Cesar Vallejo, per i quali morte e vita
fanno parte dello stesso ciclo e si danno senso reciprocamente), la morte
perde, in questo libro, come in altri testi della letteratura latino-americana,
gli aloni orrifici per caricarsi di suggestioni e di misteri (pensiamo alla
morte di Rosa, di Ferula, di Nivea, della stessa Clara). La morte arriva
quasi consolatoria e necessaria (Clara si stacca lentamente dalla vita, con
serenità, pianificando le sue memorie per i posteri, ma con lei vi muore
tutto lo spirito della casa che è come se improvvisamente si spogliasse
dell’energia vitale: muoiono i fiori del giardino, le piante, non cantano più
gli uccelli. I silenzi diventano pesanti. La pagina della morte di Clara è
tra le più belle del libro. La morte è dunque accettata come la vita. Fa
parte della vita. È il più naturale degli even-ti. È un ciclo che si compie,
ma non si interrompe perché i morti comunicano con i vivi, fanno sentire la
loro presenza, sono compagni. In un certo senso continuano a vivere. La
morte, dunque, non sorprende e non turba, anche se a volte si
carica di particolari macabri che la leggera ironia dell’autrice stempera
|
|
in
un sorriso (ricordiamo
la testa mozzata di Nivea conservata nella cappelliera). Gli spiriti dei
morti, continuando ad agitarsi attorno ai vivi, fanno parte del grande
affresco della vita e della storia e come tali non spariscono, ma danno senso
alle cose passate come a quelle a venire. Il Tempo. Il tempo, nel
romanzo della Allende (ma così in tutta la letteratura latino-americana:
basti pensare a “Cent’anni di solitudine”) appare dilatato. La lunga
storia che passa per 4 generazioni allarga il tempo. Lo allunga a dismisura,
dà il senso dell’evento lungo in cui ogni avvenimento è concatenato all’altro
in un’armonica disposizione di tempi e di cose, quasi un evento non potesse
esistere senza l’altro e certi accadimenti anche minimi, ne preparassero altri
che danno senso all’intera storia. Per cui non è più la vita o la vicenda del
singolo a contare, ma la sua vicenda inserita in una storia più lunga.
L’intera storia in cui ogni individuo è calato, ne è partecipe e ne diventa
parte integrante. Parlerei perciò di un tempo circolare che dà senso
agli eventi piccoli o grandi che siano, solo circolarmente in una definizione
più ampia e più larga delle cose. Tale concetto del tempo e del lungo
svolgersi delle vicende, affascinante e misterioso come ogni cosa ne “La
Casa degli Spiriti”, non è contemplato nelle saghe familiari della
letteratura italiana dei nostri giorni (pensiamo a “Le strade di polvere” di
Rosetta Loy o a “Il catino di zinco” di Margaret Mazzantini). Le Donne.
Nel romanzo della Allende sono l’elemento forte, vitale, essenziale negli
eventi così come nella vita e nella morte. Basti pensare a tutti i personaggi
del libro, a tutte le figure femminili, anche secondarie, a un personaggio
come Nana che pare secondario, ma ha in sé intero l’humus, lo spirito
della terra in cui vive. E’ grembo caldo e protettivo, quasi l’angelo
tutelare della famiglia. Le donne del libro, oltre a determinare la storia,
ad esserne il perno ne sono il fulcro, il senso stesso. Basti pensare alla
fragilità di Esteban, con le sue collere e la sua violenza messa a confronto
con la forza silenziosa di Clara,
|
|
o con la costruttiva capacità di
opporsi al mondo e alle cose di Blanca prima e di Alba dopo. E il film, che
porta lo stesso titolo del libro, riesce a realizzare il fascino, il mistero,
la magia lieve e ironica de “La Casa degli spiriti”? Sì, il miracolo
della trasposizione avviene pienamente anche se il regista riscrive la
storia modificando tempi ed eventi (in effetti salta una generazione dei
Trueba ed è Blanca e non Alba a vivere la vicenda drammatica della prigione e
della violenza). Ma tutto ciò risulta positivo perché concentra nel film
eventi essenziali; nel libro sminuzzati in una serie di piccoli accadimenti
e d’infiniti personaggi necessari a creare l’affresco familiare e storico,
nonché l’intreccio, il “mitos”, che realizza la grandezza del
romanzo. Il film riesce a centrare pienamente i personaggi, i paesaggi, gli
ambienti, i costumi, i colori, ma anche le atmosfere, rispettando pienamente
quelle caratteristiche che ho evidenziato nel libro: L’idea della morte come
evento naturale non orrifico e come transito non definitivo nell’unità tra
la vita e la morte; La convivenza con i morti e il loro sopravvivere tra i
vivi;
|
|
La
circolarità del tempo che dispone gli eventi come in un preordinato rapporto
di vicende mai fine a se stesse, La ricchezza e la pienezza delle figure
femminili realizzate in tutto il loro fascino e, assieme, in tutta la loro
forza. Tutto ciò fa sì che la trascrizione cinematografica de “La Casa
degli spiriti” realizzi e concretizzi il valore estetico ed emozionale
del libro stesso, affidandolo a una lunga durata e a una lunga messe di
emozioni.
|
|
La scrittrice: Isabel
Allende
|
|
È nata a Lima nel 1942
ed è vissuta in Cile fino al 1973 svolgendo la professione di giornalista.
Dopo il colpo di stato di Pinochet, che ha instaurato in Cile una dittatura
militare, concludendo drammaticamente l’esperienza del governo socialista del
presidente Salvator Allende, la scrittrice si è trasferita prima in Venezuela
e poi negli Stati Uniti. Il suo primo romanzo “La casa degli spiriti”, pubblicato
nel 1983, ha ottenuto uno strepitoso successo in tutto il mondo e Isabel
Allende si è imposta come una delle voci più significative della letteratura
sudamericana. Il suo romanzo in cui s’intrecciano fantasia e realtà, è stato
avvicinato a “Cent’anni di solitudine” di Gabriel Garcìa Marchez.
Anche i romanzi successivi sono stati accolti dal pubblico con grande favore
e Isabel Allende è diventata una “Grande” della letteratura. Da “La
casa degli spiriti” è stato anche tratto un film di grande successo.
Altre opere di Isabel Allende: “D’amore e ombra” (1985); “Eva Luna”
(1988); “Eva Luna racconta” (1990); “Il piano infinito” (1992);
“Paula” (1994); “Afrodita” (1997)
|
|
È nato in Danimarca
nel 1948. Dirigendo il suo film “Pelle alla conquista del mondo”, premio
al Festival di Cannes, aveva fatto credere in una rinascita del cinema
danese. Il secondo film “Con le migliori intenzioni” rifletteva
un’attenta lettura delle opere di Bergman e la critica era in attesa di una
conferma definitiva di questo autore. “La casa degli spiriti”, secondo
alcuni critici, non si è dimostrato all’altezza delle aspettative.
|
|
“Il rapporto tra il
libro e il film va cercato proprio in questa dialettica degli opposti:
circolare il primo, lineare il secondo; allusivo, trasparente, inafferrabile
il primo; concreto, ridondante, eccessivo, il secondo. Ciò nonostante il peso
non sgretola il film, la dissoluzione del romanzo non lo fa smarrire,
l’epopea di un Sud America mai così assente (e mai così presente nella sua
diversità non letteraria) alla fine coinvolge. Quando lasci le sue donne
sbattute da un vento da romanzo, tra foglie ingiallite e polvere inventata,
sei comunque prigioniero di una doppia illusione di verità. Quante Alba,
Nivea, Clara, Blanca, si porteranno via altre notti fantastiche e violente?” Paolo Taggi,“Segnocinema”, marzo
-aprile 1994
|
|
Dal Romanzo omonimo di
Isabel Allende Regia: Betty Kaplan Personaggi e Interpreti:
Irene: Jennifer O’ Connelly Francisco: Antonio
Banderas Beatrix: Stefania Sandrelli Gustavo: Camillo
Gallardo Sceneggiatura: Donald Feed Musica: Josè
Nieto Copodruzione Cinematografica:
|
|
Drammatico – Colore
Durata:
106 minuti
|
|
* a cura di Maria
Grazia Riveruzzi
|
|
La storia è più o meno
quella di una ragazza di buona famiglia che ai tempi della dittatura di
Pinochet vive in una villa (trasformata dalla madre in una lussuosa
residenza per vecchi) in attesa di convolare a nozze con il fidanzato
Gustavo, promettente ufficiale dell’esercito, che si rivelerà alla fine
ufficiale – gentiluomo. Malgrado la censura sulla stampa, malgrado
l’atmosfera di terrorismo, Irene trascorre le sue giornate libera e
spensierata, come ovattata nel suo distacco da tutto (Isabel Allende e i
primi mesi dopo il golpe in “Paula”). Apparentemente emancipata e
intraprendente nel suo lavoro di giornalista di moda, Irene sembra esprimere
il proprio anticonformismo attraverso il modo strano di abbigliarsi,
folkloristico e spesso poco curato, in netto contrasto col perbenismo fatuo e
civettuolo della madre Beatrix filofascista, che nutre per la figlia grandi
speranze e ambizioni borghesi. L’indipendenza della figlia Irene, la
noncuranza delle apparenze stizziscono ed irritano l’effimera madre che
lancia contro di lei sospiri, gridolini, gesti sospesi e artificiosi. Beatrix
è il simbolo della dissoluta leggerezza della borghesia che permetteva e ha
sempre permesso l’avvento dei regimi totalitari i loro genocidi, le torture,
gli stermini; rappresenta il veicolo degli effimeri e vuoti valori di un
sistema patriarcale – autoritario. Il conflitto tra madre e figlia si
acuisce quando arriva Francisco, il fotografo ed Irene ne sposa la causa. È
Francisco che apre gli occhi ad Irene: seguendo le tracce di Angelina una
“santa” di campagna finita nelle liste dei “desaparecidos”, la giornalista,
quasi per caso, comincia a svegliarsi e nel frattempo s’innamora di Francisco
che collabora con la Resistenza per svelare al mondo gli orrori del regime.
|
|
Il passaggio di Irene dall’adolescenza all’età adulta subisce una
drastica accelerazione: il cartello che chiude la vecchia miniera
abbandonata e che reca due parole “Prohibido pasar”, le svela di colpo gli
orrori del regime. Le vittime, poveri resti che il regime addebita al
terrorismo, sono, invece, l’ultimo palpito della bandiera della libertà.
Irene è sconvolta, ma determinata: lascia il fidanzato e rischia seriamente
di lasciarci la vita nella lotta clandestina contro la dittatura militare.
Con molte pallottole in pancia e con l’innamorato al fianco Irene alla fine
passa il confine condannandosi all’esilio.
|
|
Ancora una volta
dobbiamo constatare che l’emancipazione e la consapevolezza politica,
l’adesione ideologica, la militanza della donna – protagonista avvengono per
opera di un uomo: l’amore è l’organo di rivelazione, è lo strumento della
presa di coscienza di Irene che ha sposato la causa dell’uomo amato. Non è un
atto di autocoscienza né il risultato di un graduale e autonomo processo di
emancipazione e di liberazione, ma è una scelta suggerita dall’amore per
l’altro. È, infine, degna di nota la contrizione di mamma Beatrix, quando
intuisce appieno il sacrificio della figlia che voleva immolare al sistema
patriarcale. Le incertezze e i conflitti di un tempo si sciolgono in
un’accorata solidarietà. Falsa o vera che sia, tocca al lettore/trice e allo
spettatore/trice giudicare.
|
|
Il cinema continua a
corteggiare i romanzi di Isabelle Allende e questo non stupisce se si pensa
che sono stati apparentati alla narrativa di Marquez, e sono diventati uno a
uno dei best-seller internazionali.
|
|
Allende è la nipote di Salvador
Allende presidente di un governo socialista del Cile. Nata in Perù, ma
cresciuta in Cile fino alla cacciata della famiglia, ordinata nel 1973 da
Pinochet, dopo il colpo di Stato, Isabella Allende si trasferì in Venezuela e
poi negli Stati Uniti. I suoi romanzi “La casa degli spiriti”, “Paula”, “Eva
Luna”, “Piano infinito”, hanno fatto di Isabelle Alliende una star della
letteratura latino-americana. Lei stessa non immaginava che i periodi più
difficili del terrore in Cile e di solitudine in esilio sarebbero stati gli
anni più importanti della sua vita, perché diedero slancio, forza e
materiale per la sua scrittura. Aveva conosciuto in quei terribili giorni,
per esempio, Francisco uno psicologo senza lavoro, una persona dolce e un po’
ingenua con cui Isabelle collaborò per fare espatriare tanti poveri
derelitti, donne e bambine. Nove anni dopo Francisco servì da modello per il
protagonista del suo romanzo “D’amore e Ombra”. Al cinema sembrò fin troppo
invitante la prospettiva di sfruttare il successo rilanciandolo sugli
schermi. Invece non è sempre così automatico prevedere l’esito di questa
facile operazione di calcolo: l’adattamento cinematografico de “La casa
degli Spiriti”, realizzato da Bill August due anni fa, e “D’amore e Ombra”
di Betty Kaplan, ha lasciato generalmente perplessi i lettori conquistati dai
romanzi di I. Allende:
|
|
d’altra parte le storie della scrittrice si prestano ad essere interpretate in chiave
banalmente sentimentale sullo sfondo del Cile e della dittatura militare.
D’amore e Ombra” è un’altra esposizione dei temi cari alla scrittrice. Alla
storia d’amore s’intreccia la presenza tragica dell’ombra: le torture, le
sparizioni, i morti del regime, i desaparecidos. L’amore mescolato alla
politica, agli orrori della dittatura visti come atroce contrappunto alla
passione bruciante che nasce tra i due protagonisti; il mito intrecciato a
momenti e personaggi magici( Evangelina giovane con doti media-niche).
Seguendo la trama del romanzo, l’esordiente regista Betty Keplan di origini
statunitensi, ma cresciuta in America Latina, esperta nella fiction
televisiva, tenta un mix tra i temi mitici dell’Allende, e il ritmo narrativo
di scuola americana. Così la generosità stilistica dell’Allende, le
accensioni fantastiche della sua scrittura, la sua capacità di appassionare
con ricordi tormentati e personaggi nevrotici, l’approccio col mondo
paranormale e magico così caro e familiare….. tutto ciò si stempera in una
melodrammatica love-story da fotoromanzo. Le belle pagine del romanzo
smarriscono, nella riduzione cinematografica, gran parte della loro suggestione
a favore della pura azione ( la fuga rocambolesca degli innamorati dal Cile
nella formula auto-cavallo) Di fronte a un film come “ D’amore e Ombra” sono
possibili – dice la giornalista della Stampa Alessandra Levantesi -due punti
di vista assolutamente contrastanti: deplorare che la sanguinante vicenda
dei “desaparecidos” cileni sia presa a pretesto di uno scadente melodramma;
oppure rallegrarsi che temi di grande rilevanza civile siano convogliati in
un prodotto che vorrebbe essere popolare”. Sappiamo che l’Allende ha
dichiarato di apprezzare molto i film della Betty Kaplan, ma i due
melodrammi, quello letterario e quello cinematografico, differiscono
parecchio: nel senso che l’appassionata descrizione della crescita
sentimentale ed etica dei due giovani dietro cui si cela una vicenda collettiva
dura e drammatica si tinge e si appiattisce sullo schermo secondo moduli
stereotipi della cinematografia hollywoodiana. Isabelle Allende, nipote del
celebre caduto vittima del golpe di Pinochet, ha il pregio di trattare con
sobrietà ed equilibrio un argomento d’indubbio valore civile e politico.
”D’amore e Ombra” è un documento letterario che scruta tra le pieghe della
Storia, ne coglie i palpiti e le emozioni più recondite e consegna alla
memoria collettiva la tragedia di un popolo, la morte della democrazia.
Accade che la forza delle idee, la denuncia, l’invettiva contro l’ingiustizia
e i diritti umani, tutto ciò che traspare nella scrittura dell’Allende, non
si traducono nel film in emozioni, non toccano le nostre visceri, perché
tutto nel film viene banalizzato sul nascere. Ho detto tutto, ma sarebbe più
corretto dire quasi tutto; perché si vorrebbe conoscere il nome dell’attrice
di secondo piano che confida a Francisco gli orrori della tortura; infatti è
l’unica a mostrare di sapere come va interpretata una pagina così drammatica
del copione e della storia umana. “D’amore e Ombra” doveva essere un film
politico. La ricostruzione dei delitti della dittatura di Pinochet, la
vicenda dei desaparecidos sono, nel film, un’occasione mancata di ricordare
la tragedia cilena.
|
|
Titolo orig. The
color purple Usa 1985 Regia: Steven Spielberg Soggetto:
tratto dal romanzo di Alice Walker Sceneggiatura: Menno Meyjes Fotografia:
Allen Daviau Musica: Quincy Jones Scenografia: Robert
w. Walch – Linda Descenna Costumi: Aggie Guerard Rodgers Personaggi
e Interpreti: Celie: Woopi Goldberg Mister: Danny
Glover vecchio Mr: Adolph Caesar Shug: Margaret Avery Sofia:
Oprah Winfrey Squeak: Rae Dawn Chong Harpo: Willard
Pugh Nettie: Akosua Busia Celie giovane: Desreta
Jacson Grady: Bennet Guillory Miss Millie: Dana
Ivey Produzione: Steven Spielberg, Katleen Kennedy, Frank
Marshall, Quincy Jones / Warner Bros. Prod.
|
|
* a cura di Paola Nucciarelli
|
|
Il film racconta la
vita di Celie, una donna, negra, brutta e povera nello stato della Georgia
nei primi del ‘900.
|
| Violentata da colui
che credeva essere suo padre, privata dei figli, sposata a un uomo che la
tratta da schiava, allontanata dall’unica cosa bella della sua vita, la
sorella Nettie, che sfugge ad un destino analogo, Celie riesce a sopravvivere
con la speranza di riabbracciarla. Celie parla con Dio, perché non può
raccontare a nessun’altro gli orrori della sua vita, rimette a Dio tutti i
suoi problemi, non ha futuro sulla Terra, solo la morte la renderà libera.
Quando la moglie del figliastro, Sofia, le dice che non si sarebbe aspettata
di dover combattere con una donna, segnata dal suo stesso destino, Celie,
rassegnata alla sua condizione di schiava e non riuscendo a concepire altro
che la morte quale fuga verso la libertà, conforta Sofia: -La vita finisce
presto…il paradiso è eterno… L’eroina del film vuole magnetizzare tutta la
pietà e la compassione dello spettatore: Celie è l’apoteosi della
svantaggiata. È quasi un dovere amarla, ma la sua maledetta passività, la sua
espressione stramba, il suo chiudersi in se stessa, il suo raggomitolarsi,
la sua paura, il suo disappunto, ci rendono esauste e impazienti. Alla fine
Celie si riscatta grazie alla relazione con una bella figura di donna, Shug
Avery, l’amante del marito.
|
|
Il romanzo è in forma epistolare, un racconto a due voci attraverso
una corrispondenza che non arriva a destinazione. Nelle lettere di Nettie il
linguaggio è più fluido e descrittivo, viene raccontata l’Africa conosciuta
dalla Walker, i riti sanguinosi della tribù Olinka. I testi di Celie sono
scritti in uno stle più semplice, elementare, immediato e crudo. Scarno
nelle descrizioni, ma denso di significati e di spessore, il romanzo scorre
forse più velocemente del film. La versione cinematografica risulta
abbastanza fedele al testo sia nei nomi dei personaggi, nei dialoghi, che
nella storia, sebbene nel romanzo venga analizzato più profondamente il
rapporto fra Harpo e Sofia, la redenzione di Mr, l’inaspettato amore per
l’ex moglie, Celie. Da sottolineare la relazione amorosa fra Celie e Shug
che nel libro risulta molto più esplicita e dettagliata: Shug può amare
indifferentemente uomini e donne perché la sua morale le dice che Dio si
arrabbia se non si amano le cose belle, come un campo di fiori di colore
viola; Celie ama Shug perché gli uomini le hanno sempre fatto paura con il
loro potere fallocratico, con le loro violenze e sopraffazioni. Celie è vissuta
senza amore e senza affetto. Con Shug, Celie diventa persona, riacquista
considerazione e rispetto, trova la pace e la serenità, sente la dolcezza del
ventre materno, il gonfiore del seno: è come dormire con la mamma con la
quale non ha mai dormito. Il loro rapporto è una relazione psicologica-sentimentale,
non sessuale.
|
|
Il romanzo è anche una
denuncia contro i retaggi culturali che generano l’oppressione: Il vecchio
Mr. comanda Harpo e Celie, Harpo vuole comandare, tramite i vecchi luoghi
comuni, l’energica Sofia che non ne vuole sapere e l’amante Squeak che alla
fine lo lascia. I bianchi, ancora, vogliono sopraffare i negri. Nessuno è
soddisfatto della propria vita, né gli oppressori, né gli oppressi, solo la
relazione amicale, fra le più “reiette della terra”, le donne-negrepovere
produrrà qualcosa di positivo per le generazioni che verranno, alla fine una
speranza per il futuro.
|
|
Il dolore è il tema
dominante del romanzo e del film. Esso pervade in modo assoluto il corpo, la
mente e il cuore. Noi donne ci conviviamo più o meno consapevoli come delle
predestinate, (il dolore fisico come palestra preparatoria al dolore
psicologico). La vita di Celie è dolore. Celie vive in una dimensione di
assoluto dolore e lo accetta con assoluta abnegazione: sua madre ha vissuto
dolorosamente e così farà anche lei. AMEN. Il dolore è visto come
purificazione. Trova il suo Dio nella sofferenza, nella rassegnazione,
nell’accettazione, nell’immolazione. La sua povera esistenza accoglie con
rassegnazione e con esaltazione il martirio delle vergini cristiane.
L’ostentazione di Shug nel godere delle gioie della vita è l’altro modo di
superare la tragicità della vita e di interpretare la volontà di Dio che
esorta ad amare e a gioire per le cose belle del creato. Shug incarna la
secolare contraddizione della donna che aspira alla libertà nutrendo in un
tempo sensi di colpa.
|
|
Sofia è una figura di donna che incarna l’emancipazione: è forte,
libera, sicura, simpatica, ma non viene capita dall’ambiente in cui vive che
la schiaccia e l’annulla. Nettie che ha imparato a leggere e a scrivere,
trasferisce il suo sapere a Celie, ma poi deve scappare da quel mondo per
trovare la libertà. Il ritmo lento del film rispecchia il tipo di vita che
conducono Celie e le altre. Siamo nei primi del ‘900 in uno Stato, la
Georgia, che risente ancora della mentalità schiavista. La Walker vuole
anche denunciare la condizione psicologica delle donne, l’elemento più
debole, oppresse e represse da quella organizzazione patriarcale.
|
|
La scrittrice: Alice Walker
|
|
Nata il 9 febbraio 1944 a Eatonton
in Georgia, ultima di otto figli di una famiglia di poveri agricoltori,
ricchi di amore e spirito, è universalmente riconosciuta come una delle più
grandi scrittrici di questo secolo. Un’antenata del padre, Mary Poole, era
una schiava che fu costretta ad attraversare a piedi la Virginia fino ad
arrivare in Georgia con un bambino in braccio. La bisnonna materna
dell’autrice era una pellerossa Cherokee. La Walker è profondamente
orgogliosa delle proprie eredità culturali. Diplomatasi nel 1961, si iscrive
allo Spelman College di Atlanta, ma prima di partire la madre le dona tre
cose speciali: una macchina da cucire per la sua autosufficienza, una valigia
per la sua indipendenza e una macchina da scrivere per dare spazio alla sua
creatività. In seguito alla sua partecipazione a varie dimostrazioni per i
diritti civili, nel ’62 è ospite di Martin Luther King jr. Partecipa al
festival mondiale della pace ad Helsinky in Finlandia. In questo periodo
viaggia molto in Europa conoscendo popoli e culture diverse che
contribuiranno alla sua formazione. A Washington nel ’63 prende parte alla
marcia per il lavoro e per la libertà e ascolta il discorso < I have a
dream > di Martin Luther King. A soli 21 anni pubblica il suo primo
romanzo breve e si laurea nel 1965 al Sarah Lawrence College di New York.
Tornata in Georgia, continua il suo lavoro nel movimento dei diritti civili e
conosce un giovane studente di legge, ebreo, Mel Leventhal, con il quale si sposa.
La Walker scrive un saggio sui diritti civili che vince il primo premio sulla
American Scholar magazine. Vince una borsa di studio presso la prestigiosa
MacDowell Colony nel New Hampshire per i suoi scritti, mentre procede alla
stesura del suo primo romanzo. Nonostante i problemi razziali che la coppia
suscita, continua a lavorare nella difesa dei diritti civili e presenzia al
funerale del suo eroe, Martin Luther King ad Atlanta. Alice Walker pubblica
il suo primo volume di poesia, Once, mentre insegna all’università di
Jackson State. Le nasce una figlia, Rebecca e pubblica il suo primo romanzo, La
terza vita di Grange Copeland che riceve plausi, ma anche aspre critiche
dagli African-Americans perché tratta troppo duramente i maschi negri del suo
libro. La Walker riceve molte proposte da varie università, finchè accetta la
cattedra al Wellesley College dove dà inizio al primo corso sulla letteratura
femminile degli stati uniti, soprattutto sulle scrittrici African-American e
cura un’antologia dell’antropologa nera Zora Neale Hurston. Dal
|
|
’73
al ’76 lavora intensamente, ispirata dalla sua nuova eroina e pubblica la sua
prima collezione di racconti brevi, Amori & Guai: Storie di donne nere.
Eil suo secondo volume di poesie, Revolutionary Petunias & Other Poems
e diviene editrice nonché firma di punta della rivista MS. Vince
numerosi premi e pubblica il suo secondo romanzo, Meridian. Finito il
suo matrimonio con Leventhal, si trasferisce in California, dove incontra
Robert Allen, editore di “Black Scholar” e dove attualmente risiede nella
cittadina di Mendocito, vicino a San Francisco. I lavori della Walker
continuano a proliferare; pubblica il suo secondo volume di racconti, Non
puoi tenere sottomessa una donna in gamba e nel 1982 pubblica Il colore viola che vince il premio Pulizer e
l’American Book Award che la innalzano a fama mondiale, nonostante le
critiche degli scrittori neri americani che continuano a condannarle i
ritratti troppo duri degli uomini neri del romanzo. Amareggiata da tali
critiche, la Walker pubblica un saggio sulla sua ideologia femminista
intitolato Alla ricerca del giardino di mia madre. Dalla sorella Ruth
è stata creata una fondazione chiamata Il colore viola con lo
scopo fornire istruzione tramite lavoro di volontariato. Nel 1984 pubblica il
terzo volume di poesie, “I cavalli rendono più bello il paesaggio” e
nell’88 scrive un saggio, “Living by the word”. L’anno dopo pubblica
un romanzo epico, “Il tempio del mio spirito”. Scrive anche racconti
per bambini e il romanzo “Conoscere il segreto della gioia”, una
cronaca del dramma psicologico della vita di una giovane donna dopo la
mutilazione forzata dei genitali. Di questo argomento si è interessata
intensamente durante i suoi viaggi in Africa, lavorando a documentari e scrivendo
un manuale Warrior Marks, in cui racconta sotto forma di cronaca le
sue esperienze. Nel ’96 pubblica The Same River Twice: Honoring the
Difficult in cui descrive con saggi e articoli, la sua lotta contro la
malattia e la depressione e la sua versione della sceneggiatura de Il
colore viola. Successivamente pubblica un altro saggio ispirato dal
suo attivismo politico, sui diritti civili, sul movimento nucleare, sul
movimento delle donne, sulla protezione verso la cultura e l’ambiente delle
popolazioni indigene, sulle vittime del razzismo, del sessismo, delle armi
nucleari e sulla conservazione delle ricchezze naturali. A settembre 1988
aveva pubblicato anche una serie di racconti dove esamina le connessioni fra
spiritualità e sessualità, tramite le storie narrate da generazioni che
esplorano le relazioni fra padri e figlie, By the Light of my Father’s
Smile.
|
|
Il regista: Steven Spielberg
|
|
È nato nel 1947 a Cincinnati
nell’Ohio, USA. Sin dall’infanzia, Spielberg figlio di un ingegnere esperto
di computer, sviluppa la sua passione per il cinema. Munito di una semplice
cinepresa super8, gira filmetti ispirati a generi hollywoodiani. A 13 anni
vince un concorso cinematografico con il film bellico Escape to Nowhere,
ma a 16 la sua carriera inizia nel vero senso della parola con un film
fantascientifico di oltre due ore, Firelight. Trasferitosi in
California,
|
|
si
laurea in Inglese alla Long Beach University, nonostante passi tutto il suo
tempo negli ‘studios’ della Universal. Nel 1969 gira un cortometraggio di 24’,
Amblin, con il quale vince premi ai Festival di Venice e di Atlanta. La
Universal gli propone un contratto di 7 anni per la MCA-TV. Si guadagna in
fretta la fama di specialista dirigendo numerosi pilot (primi telefilm di una
serie) e episodi di serials di successo fra cui Colombo. Nel 1971 gli vengono
commissionati tre film per la televisione, fra cui Duel, che arrivato
in Europa, vince il il premio al Festival del cinema fantastico in Francia,
un altro premio in Germania, a Taormina, una menzione al festival televisivo
di Montecarlo. Il film incassa 6 milioni di dollari. Nel 1974 gira Sugarland
Express, un mezzo flop, ma nel ’75, con grande acume commerciale, talento
e fortuna gira Lo squalo che lo porta a concretizzare un suo sogno: Incontri
ravvicinati del terzo tipo. Nel 1979 gira poi un cocktail demenziale
postmoderno un po’ trascurato come 1941: allarme ad Hollywood. Nello
stesso periodo inizia la sua carriera anche di produttore con due opere che
lo inseriscono fra gli illusionisti immortali del cinema: I predatori
dell’arca perduta, nel 1981 e E.T. nell’82, che si affermarono
nel mondo intero come campioni d’incassi di una spettacolarità adeguata ai
tempi, un ritorno alla meraviglia secondo un punto di vista consapevolmente
infantile e ad un ritmo di racconto consono al gusto popolare. Entrato ormai
nell’Olimpo dei grandi, Spielberg fonda una propria casa di produzione,
producendo, nel campo fanta-favolistico, film con temi e prospettive
spielberghiani come Ritorno al futuro di Bob Zemechis. Nel 1984 gira Indiana
Jones e il tempio maledetto, nell’85 firma Il colore viola,
per il quale è candidato a 11 oscar, non vincendone nessuno. Spielberg,
appartenente alla comunità ebraica americana, nonostante abbia sempre
attaccato tutte le forme di oppressione, non venne accettato favorevolmente
da una parte della comunità nera americana, con il motto “la questione nera è
nostra e non si tocca”. L’impero del sole è del 1987, Always e Indiana
Jones e l’ultima crociata vengono girati nel 1989, successivamente firma
uno dei suoi peggiori film. Hook e nel 1993 si riscatta con Jurassic
park, un film mozzafiato che ha battuto il record d’incassi di tutti i
tempi. Nel 1994 Spielberg vince l’Academy Award per la regia del film che
merita di essere inserito fra le cento migliori opere cinematografiche della
storia del cinema : Schindler’s list. Nel 1995 produce Casper, nel ’96
Twister e Men in Black, tutti film del genere fantastico. Nel 1997 ha prodotto
e firmato Amistad con Antony Hopkins (Il silenzio degli innocenti) e
con Morgan Freeman ( A spasso con Daisy) che pro-segue il discorso iniziato
con Il colore viola sulla questione nera. Ha prodotto la continuazione di
Jurassic Park, The lost World . L’ultimo lavoro come produttore e regista è
del 1998, Salvate il Soldato Ryan con Tom Hanks (Forrest Gamp).
|
|
Regia: Gillian Armstrong Sceneggiatura:
Robin Swicord Fotografia: Geoffrey Simpson Musica:
Thomas Newman Personaggi e Interpreti: mamma March: Susan
Sarandon Meg: Trini Alvarado Jo: Winona Ryder Beth:
Claire Danes Amy: Samantha Matis Friedrich Bhaer:
Gabriel Byrne Laurie: Christian Bale Durata: 115’ Origine:
USA 1994 Il film è stato candidato a tre premi Oscar
|
|
* a cura di Marisa Rotiroti
|
|
Tratto dall’omonimo romanzo di Louisa May Alcott del 1868, le “Piccole donne” hanno
vissuto nei nostri cuori per intere generazioni..
|
|
Piccole donne, è il terzo film sonoro (due versioni mute: 1917 di
Alexander Butler e 1918 di Harley Knoles sono andate perdute) tratto dall’omonimo
romanzo della Alcott, che, dopo cento anni, ha ancora qualcosa da dirci. Nel
1933 Hollywood ne ricavava un film con Katherine Hepburn e nel 1949 con Liz
Taylor e June Allison; nel 1979 in Italia veniva tratto un “musical” ironico,
nel 1994 ha ispirato il film di Gillian Armstrong, (australiana) primo film a
regia femminile. In realtà la determinazione di Winona Ryder a voler
interpretare Jo e le pressioni della produttrice e della sceneggiatrice Robin
Swicord hanno convinto la regista a realizzare un altro film su una
scrittrice, come già aveva fatto con “La mia brillante carriera”. Il
libro è troppo noto per richiamarne la trama e il film è molto aderente,
anche se approfondisce meglio il contesto storico, culturale e sociale degli
Alcott consentendoci di capire meglio la diversità della famiglia March. Il
film, ambientato in America, racconta un anno della vita di una famiglia americana
durante la guerra civile che, tra il 1861 e il 1865, vede gli Stati del Nord
contro gli Stati del Sud e la loro politica schiavistica di cui si coglie
solo un’eco indiretta. La regista pone l’accento sulla vita quotidiana delle
quattro ragazze March, sulle giornate nere e su quelle gaie, sul lavoro e sui
divertimenti e soprattutto sulla realizzazione dei loro desideri. Traccia in
definitiva l’itinerario psicologico e di esperienza attraverso la quale elle
crescono e maturano la loro personalità. Il film è stato molto apprezzato
all’estero, in Italia è piaciuto soprat
|
|
tutto
alle donne. I critici, qui, lo hanno giudicato zuccheroso, noioso, fuori
moda, non adatto ai maschi. Il tentativo di inficiare l’opera arriva a
servirsi dell’affermazione della Alcott “non mi piacciono le ragazze”: in
realtà non le piaceva lo stereotipo che le ragazze del suo ambiente sociale
erano costrette a incarnare. Significativi, nel film, gli episodi delle due
proposte di matrimonio: non solo Jo, ma anche la più convenzionale Amy,
sostenute dall’insegnamento mater-no, rifiutano il matrimonio finalizzato a
qualcos’ altro che non sia il reciproco desiderio. È stata anche
disapprovata la scelta di Winona Ryder come interprete di Jo perché “troppo
bella”, e una monellaccia… non può esserlo…, naturalmente... secondo lo
stereotipo della percezione maschile, come ebbe a rispondere la stessa
regista in un’intervista. In realtà la Jo di oggi è molto più vicina all’immaginario
di molte di noi che vogliamo costruire il bene attraverso la
responsabilità, di quanto non lo sia la Hepburn che lotta per l’emancipazione
e la distruzione del male. Leggo in tali giudizi l’incapacità dei critici
di entrare in un mondo di relazioni femminili qual è quello della famiglia
March. Le figure maschili sono sbiadite: il padre, un pastore
protestante rigoroso fino al fanatismo e all’irresponsabilità verso la
famiglia, è assente nel film come nel romanzo (assente per scelta
dell’autrice); Laurie, nipote del vecchio sir Laurence divenuto ricco
con il commercio nelle Indie, osserva a lungo dietro i vetri e desidera
entrare in questa comunità femminile: ci riesce ma solo accettando le regole
e riconoscendo l’autorità femminile. Ogni volta che cerca di reintrodurre
le regole convenzionali ne viene espulso. Bella è la figura di Friedrich che
riesce a comprendere pienamente il cuore di Jo “leggere il tuo libro è
stato come aprire una finestra sul tuo cuore”.
|
|
L’interpretazione
di Susan Sarandon è superba: ella è la madre che avremmo
voluto avere e che vorremmo essere: punto di riferimento, capace di
dare sostegno affettivo, di autorizzare le figlie e i figli ad andare
libere/i nel mondo a scegliere ed inventarsi la propria vita. “Va’,
corri incontro alla libertà e scopri quali cose meravigliose ha in serbo per
te” dice la madre a Jo. Il film si conclude con la scena della
pioggia purificatrice e ci richiama alla memoria le parole di
Friedrich sulla definizione di Trascendentalismo (filosofia romantica
tedesca): “gettando via tutte le costrizioni arriviamo a conoscerci
attraverso l’introspezione e l’esperienza”, insegnamento di cui ancora
oggi possiamo far tesoro.
|
|
La
scrittrice: Louisa May Alcott
|
|
Figlia del pedagogista e filosofo Amos
Bronson Alcott, nasce a Germantowon in Pennsylvania il 29 novembre 1832. Ha
tre sorelle, una delle quali muore a 22 anni di scarlattina, come la Beth del
romanzo autobiografico “Piccole Donne”. Dolce, coraggiosa,
esuberante e profondamente umana, attraverso il padre, riformista sociale e
ideatore della comunità utopica di Fruitlands, Louisa entra
|
|
in
contatto con trascendentalisti e intellettuali eminenti quali Ralph Waldo
Emerson, Henry David Thoreau e Nathaniel Hawthorne. Comincia a scrivere in
età molto giovane e a 19 anni pubblica “Sunlight”, una raccolta di
poesie, sotto lo pseudonimo di Flora Fairfield. Si dedica per molti anni
all’insegnamento e nel 1862, durante la guerra civile americana, si
trasferisce a Washington dove lavora come infermiera volontaria nell’ospedale
militare di Georgetown. La Alcott s’impegna anche socialmente soprattutto per
i diritti delle donne. Diventa famosa con “Piccole Donne”, pubblicato
negli anni 1868/69, che è l’inizio di una saga autobiografica andata avanti
con “Piccole donne crescono”, “Piccoli Uomini” e “I ragazzi di Jo”.
Nei suoi libri racconta le proprie esperienze personali, il che li rende
moderni perché contengono gli elementi, sempre attuali, della ricerca della
propria identità e della realizzazione di sé sulla base di scelte personali e
responsabili. Muore il 6 marzo 1888, all’età di 56 anni senza essersi mai sposata.
|
|
Regia: Deepa
Mehta Scenografia: Sandra Kybartas Fotografia: Guy
Dufaux Costumi: Milena Canonero e Elisabetta Beraldo Musiche:
John Altman e Daniel Lanois
|
|
Personaggi
e Interpreti: Camilla: Jessica Tandy Freda: Bridget
Fonda Elias Koteas, Maury Chaykin, Graham Green, Hume Cronyn Produttori:
Christina Jennings e Simon Relph
|
|
* a cura
di Maria Grazia Riveruzzi
|
|
Liberamente
tratto dal romanzo “Camilla” di Christopher Davis edito in Italia da
Sonzogno
|
|
Freda
and Vincent Lopez (Bridget Fonda alias Elias Koteas) sono in vacanza in
Georgia. Lui è un disegnatore grafico, lei una compositrice musicale. Durante
una passeggiata nei dintorni della loro abitazione, Freda viene attratta
dalle note musicali di un violino e, rincorrendole, incontra, nel villino
accanto, Camilla Carp (Jessica Tandy), un’anziana ma energica signora ex
concertista, che vive col figlio Harold proprietario della casa e produttore
cinematografico, dalla madre stessa definito “ladro e buffone”. Vincent e
Harold simpatizzano e in breve tempo il futuro di Vincent viene segnato
dall’offerta di lavoro di Harold e dalla partenza immediata per Toronto dove
l’attende un luminoso futuro: sono in ballo soldi e carriera. I sogni ed i
progetti condivisi con Freda possono essere messi nel cassetto e Freda,
delusa, rifiuta di parti-re. Rimasta sola, Freda intreccia un’amicizia con
Camilla con cui condivide la passione musicale. L’amore per la musica supera
la barriera generazionale e spinge entrambe ad avventurarsi, con una
ritrovata incoscienza adolescenziale, a Toronto dove al Winter Gardens si
svolgerà un concerto per violino di Brahms, un brano musicale particolarmente
impegnativo e complesso che Camilla aveva, da giovane, tentato di suonare
senza successo. Durante il viaggio, ricco di sorprese e imprevisti, Camilla
realizza i suoi sogni: vedere le cascate del Niagara e ritrovare l’amore
“perduto”; Freda corre dietro ai suoi con rinnovata fiducia in se stessa e
nel suo compagno Vincent che è tornato più innamorato di prima.
|
|
Due donne, due generazioni, due storie in un certo
senso simili s’incontrano e s’intrecciano con complicità e con delicatezza:
L’una ha un passato, l’altra ha un futuro; entrambe hanno un grande amore: la
musica che le fa volare in alto ...in alto verso la libertà. La differenza
d’età è magistralmente superata, sparisce d’incanto in una simbiosi di sogni
e di illusioni, di fantasia e di speranze ancora vive nella giovane donna e
apparentemente spente nella “vecchia” signora. La relazione femminile crea
sinergie e rafforza il desiderio muliebre; genera impulsi e dà valore.
Camilla racconta a Freda con grande fantasia il suo passato d’artista, ricco
di fama e di bellezza e la ragazza ne trae nutrimento per recuperare la
fiducia in sé e per provare e riprovare concretamente le sue doti musicali.
Ma anche per Camilla è arrivato il momento di ritrovare il coraggio e di
riprendersi il suo “tempo”, la libertà di vivere. “È solo un piccolo fosso”
le sussurra Freda e Camilla trova il coraggio di saltarlo per correre
incontro all’uomo che aveva amato tanto...tanto tempo fa e a cui aveva
rinunciato per amore del figlio. Era diventata una dolce e tenera donna,
un’incorreggibile sognatrice, ma non una grande artista come avrebbe
desiderato: non era mai riuscita ad eseguire il brano di Brahms. Al concerto
di Toronto con grande emozione e ammirazione Camilla assiste alla mirabile
esecuzione di una giovane donna: un’altra, dopo di lei, sta suonando con
solenne maestria il brano di Brahms e altre ancora verranno e realizzeranno
i sogni di Camilla in una linea di simbolica continuità. La relazione di
Freda e Camilla, fondata sul desiderio di essere libere, produce una catarsi
anche nel mondo maschile: Vincent e Harold, rispettivamente marito e figlio,
figure sbiadite e stereotipate, opacizzate dalla logica del rampantismo e
del profitto, si riarmonizzano e riconquistano nitidezza e dignità nel
momento in cui riconoscono alle loro donne il diritto di sognare, di amare e
anche...di sbagliare...il diritto di ricominciare a correre non per capire il
senso...ma per sentire l’ebbrezza del vento nei capelli.
|
|
Nata in
India, laureatasi in filosofia all’Università di New Delphi, è emigrata in
Canada nel 1975. Ha cominciato la sua carriera cinematografica scrivendo
testi per film per bambini e ha partecipato come regista a molti programmi
televisivi. Nel 1987 ha prodotto e diretto il film televisivo “Martha Ruth e
Edie” presentato successivamente al festival cinematografico di Cannes nel
1988. Un premio di riconoscimento le è stato attribuito al festival
internazionale cinematografico delle donne a Firenze. Nel 1988 il dramma
“Inside stories” ha ricevuto la nomination per la migliore performance
dell’attrice protagonista. Un altro film “Sam and me” del 1991 ha ottenuto
lusinghieri riconoscimenti al festival di Cannes. Nel 1994 Metha ha diretto
la regia della delicata e affascinante storia di “Camilla”, seguito a breve
distanza di tempo dal film “Fire” che, negli Stati Uniti, ha ricevuto grossi
plausi al festival di New York.
|
|
La prima
parola che viene in mente quando si tenta di descrivere Camilla è
“straordinaria”. “Camilla è un genere di film che rende vivace e moderno un
certo tipo di letteratura romantica e sentimentale: non a caso la musica si
presenta come elemento di sublimazione umana, che trascende e purifica ogni
meschino impulso. Storie di sogni retroattivi e di speranze future creano
un’atmosfera onirica e stravagante, talvolta irreale. Bisogna ammettere che
tutti questi elementi sono stati combinati con abilità e la mancanza, voluta,
di effetti speciali, supportata dalla “naturalità” della scena rende “Camilla”
un’esperienza significativa ed esortativa per chi crede che ormai “tutto è
perduto”.
|
|
Cast
Tecnico Artistico Regia: Jocelyn Moorhouse Sceneggiatura: Jane
Anderson Dall’omonimo romanzo di Whitney Otto Fotografia: Janus
Kaminski, A.S.C. Montaggio: Jill Bilock Musica: Thomas
Newman Scenografia: Ed Verreaux Costumi: Ruth
Myers Produttore: Sarah Pilsbury, Midge Sanford USA 1996 Durata:
120’ Distribuzione cinematografica:
|
|
Personaggi
e interpreti: Finn: Winona Ryder Anna: Maya
Angelou Glady Joe: Anne Bancroft Hy: Ellen Burstyn Sophia
da giovane: Samantha Mathis
|
|
Costance: Kate Nelligan Em:
Jean Simmons Sophia: Lois Smith
|
|
* a cura
di Paola Nucciarelli
|
|
Il Film Gli anni dei Ricordi, della regista di origini australiane
Jocelyn Moorhouse, prende spunto da un romanzo di Whitney Otto, ’Come fare
una trapunta americana’, che crea un singolare parallelo tra l’arte di
realizzare una trapunta e l’amore, gli ostacoli che si incontrano e la
ricerca di un’armonia. Finn, una delicata e sensibile Winona Ryder è venuta
a passare l’estate a casa della nonna e della prozia. Circondata da aranceti,
la casa è un tranquillo rifugio che Finn ha scelto per portare a termine la
sua tesi di laurea sui riti dell’artigianato femminile nelle culture tribali
e per pensare alla proposta di matrimonio che ha ricevuto dal suo ragazzo.
La casa ospita da molti anni anche la ‘Quilting Bee’ , una piccola
associazione di donne che si riunisce una volta all’anno per tessere una
trapunta da esibire ad un concorso. Ciascuna delle otto donne racconterà a
Finn la storia d’amore che ha plasmato la propria vita. Ogni storia
affronterà un aspetto differente dell’amore, e quando la trapunta avrà
assunto un aspetto unico, Finn possiederà una visione complessiva di questo
sentimento e potrà essere padrona dei suoi pensieri e delle sue decisioni. Il
film, girato con delicatezza ed eleganza dalla Moorhouse, è un insieme di storie
evocate, flash backs che si accumulano con regolare misura, racconti nel rac
|
|
conto,
brandelli di comprensione e di messa in gioco: la vita è un ‘quilt’, una
trapunta fatta di pezzi, cui bisogna dare un ordine e un disegno, un’armonia
e un senso, dove i pezzi di porcellane rotte durante una vita di litigi
formano un murale di ricordi dolorosi.
|
|
Il tema dominante potrebbe essere individuato
nell’amore per gli uomini, ma è anche quello per loro stesse, per le loro
radici, per l’acquisizione di competenze tramandate da una genealogia di
relazioni fra donne, che non è solo uno squallido scambio di miserie, ma una
crescita personale. L’insicurezza della protagonista viene via via a
scomparire grazie all’influenza positiva che esercitano su di lei le storie
delle altre donne.
|
|
La
regista: Jocelyn Moorhouse
|
|
È una
giovane australiana di Melbourne. Nata nel 1960, già nel 1991 aveva diretto
un lungometraggio drammatico a sfondo psicologico ‘Proof’ passato in Italia
con il titolo ‘Istantanee’, per il quale ha ricevuto molti premi e la
menzione speciale a Cannes. Il film, interpretato fra gli altri da Russel
Crowe, l’attuale compagno di Meg Ryan e interprete del ‘Il Gladiatore’
racconta di Martin, cieco dalla nascita, che trascorre il tempo a scattare
istantanee per convincersi che la realtà esiste: Julio Carrera, nel suo
saggio ‘Da Aristotele a Spielberg. Capire la filosofia attraverso i film’ ed.
Mondatori, Milano, spiega il dubbio cartesiano attraverso film come Blow up
di Antonioni e lo splendido Istantanee di J. Moorhouse. La
Moorhouse ha coprodotto e sceneggiato nel 1994 un altro film di ottimo
livello, ‘Le nozze di Muriel’ diretto dal marito P.J. Hogan e ha
curato la regia di ‘Segreti’ con Michelle Pfeiffer e Jessica Lange
tratto dal romanzo ‘A thousand acres’ vincitore del premio Pulitzer.
|
|
Regia
Soggetto e sceneggiatura
|
|
Margarethe
Von Trotta Fotografia: Franz Rath Montaggio:
Dagmar Hirtz Scenografia: Georg Von Kieseritzky, Barbara
Kloth Musica: Nicolas Economou; “Lucretia” di Georg
Friedrich Händel
|
|
Personaggi
e Interpreti: Juliane Klein: Jutta Lampe Marianne:
Barbara Sukova Wolfgang: Rudiger Vogler Sabine: Verenice
Rudolph Werner: Luc Bondy la madre: Doris Schade Produzione:
Bioskop -film München Durata: 103’ RFT -1981
|
|
* a cura
di Marisa Rotiroti
|
|
Il film
“Anni di piombo” è ambientato nella Germania della fine degli anni ‘70 e
tratto da un fatto realmente accaduto durante il periodo del terrorismo, in
cui si distinse il gruppo Baader -Meinhof. Protagoniste nella realtà due
sorelle: Christiane e Gudrun Ensslin, due donne impegnate politicamente, che
riescono a restare profondamente legate nonostante nette divergenze
ideologiche e diverse scelte di vita: Gudrun, entrata in
clandestinità, viene arrestata e trovata impiccata in carcere; Christiane,
femminista e giornalista, dopo la morte della sorella, ha sempre cercato
di dimostrare l’assurdità della tesi del suicidio.
|
|
Il quadro si apre sulla vita privata
di Juliane una donna indipendente che si batte per i diritti femminili, come
l’aborto, e scrive su un giornale femminista. Un giorno Verner, il marito di
sua sorella Marianne, che lei ha lasciato per Karl col quale è impegnata a
piazzare bombe in giro per il paese, le affida il loro bambino Jan
prima di suicidarsi. Juliane rifiuta inizialmente il ruolo di madre, perché
impegnata nel lavoro, ma poi se ne fa carico. La storia si alterna a squarci
sull’adolescenza delle due giovani donne che mostrano Juliane sempre
fortemente ribelle e Marianne mediatrice tra il padre e la sorella maggiore.
Nel corso del film i piani temporali si fondano di continuo evidenziando le
diversità tra passato e presente. Quando Marianne viene arrestata, si
accentuano le profonde differenze di posizione politica fra le due
|
|
donne,
ma un affetto profondissimo le tiene unite fino alla fine e, pur nella loro
modalità di vita così fortemente inconciliabile, sono inseparabili. Nel corso
delle visite in carcere, Juliane, vittima anche delle brusche maniere dei
sorveglianti, fugge sconvolta dalle richieste di Marianne di continuare la
sua opera sovversiva, ma non perde occasione per tornare a parlare
con lei. Mentre è in viaggio di piacere in Italia, dalla televisione apprende
la notizia della morte di Marianne, ma non crede alla tesi del suicidio e fa
di tutto per dimostrare la responsabilità di politici e polizia nel
nascondere la verità: un omicidio collettivo di cui non si saprà mai niente
|
|
Margarethe von Trotta col suo film
sulla società tedesca degli anni plumbei lancia un messaggio di grande forza
morale analizzando la complessa storia personale di due sorelle di fronte
alle grandi scelte politiche del 68 e del post ‘68. Attraverso l’analisi
sottile e “realistica” dei comportamenti umani delle due donne, i cui
dialoghi sono carichi di emotività, la regista si interroga sulle complesse
motivazioni che hanno provocato il dramma del terrorismo, analizza le
caratteristiche della sinistra tedesca di quegli anni e sembra proporre
l’affermazione di una cultura democratica che tenta di tener viva l’ansia di
libertà e di giustizia. “È necessario non dimenticare e rivedere le nostre
certezze”. Nel film e nella realtà Margarethe von Trotta si identifica
con Juliane e, partendo dalla propria esperienza, ne racconta la storia
assumendo il suo punto di vista di aperta condanna della violenza come metodo
di lotta. Propone anche elementi di riflessione sui meccanismi psicologici e
culturali, messi in atto da un’educazione protestante autoritaria, sulle
esistenze speculari di due sorelle egualmente insofferenti e desiderose di
cambiamento. L’ansia di ideali non ipocriti stimolata dal rigore morale
paterno suscita in Juliane un precoce anticonformismo che la porterà a
collaborare stabilmente con i movimenti femministi e a scrivere, partendo
dalla sua personale esperienza, in un’atmosfera da “caccia alle streghe”.
Juliane esprime così la forza e la costanza di chi crede ai lenti, ma
sicuri cambiamenti delle coscienze. Marianne interiorizza invece
l’educazione religiosa in modo del tutto idealistico, nell’attesa di una
ricomposizione tra fede e vita sociale, accettando in un primo momento le
“regole della vita borghese”. Solo quando appare chiara l’impossibilità
della conciliazione (“Tutto e subito!”) Marianne rompe ogni precedente legame
e regola di vita sociale (abbandona il marito e il figlioletto) e sceglie emotivamente
la strada della lotta clandestina e della violenza organizzata. Per molti/e
all’epoca fu così. I flash backs sono costruiti su analogie spazio -temporali
che sottolineano la cultura di una società oppressiva, di una società pronta
a dimenticare e tenace nel rimuovere il passato. La macchina da presa fruga
dentro il cuore delle due sorelle, penetra nella loro affettività tanto ricca
quanto differente e offre soluzioni visive che propongono evidenti rapporti
simbolici:
|
|
le
due sorelle lottano contro l’oblio e l’occultamento dei problemi sociali pur
realizzando a livello personale e politico il loro impegno, impegno scaturito
da un comune “sentire”, dalla stessa “voglia di fare del bene”. Entrambe,
nella diversità, denotano l’inestricabilità dei loro destini e richiedono una
compresenza nella storia. La sovrapposizione sul vetro del parlatorio tra il
volto di Juliane e quello di Marianne: immagine unica… e dissociata della
stessa esistenza. L’immagine sfocata e il ricordo vivo delle due sorelle
bambine che, dimenticando i litigi, si aiutano ad abbottonarsi la maglietta.
Il rifiuto iniziale di accogliere il bambino come rifiuto della maternità
imposta. Il bambino strappa la foto della madre: il gesto interpreta
simbolicamente la cancellazione della madre terrorista, che ha indotto
comportamenti violenti nei suoi confronti, e la volontà di oblio del popolo
tedesco di fronte alle proprie tragedie storiche. Il film si conclude con le
parole di Juliane “tua madre era una donna straordinaria. Non mi credi?
Ti racconterò di lei”. “Devo sapere tutto…….. parla! Parla”.
|
|
Il
bambino Jan, futuro della Germania, vuole sapere per …..ricostruire.
|
|
La
regista: Margarethe Von Trotta
|
|
Nasce a
Berlino nel 1942. A Parigi compie le prime esperienze in campo cinematografico,
tornata in Germania intraprende gli studi di filologia e frequenta corsi di
recitazione. Come attrice teatrale recita negli anni ‘60 a Stoccarda e a
Francoforte. Comunista mai tesserata, è attiva nel movimento studentesco
degli anni Sessanta da fiancheggiatrice intellettuale. Dal 1968 lavora anche
per il cinema e la televisione recitando, tra l’altro, nei film di
Fassbinder: “Gli dei della peste” (1969), “Il soldato americano” (1970), e
Attenzione alla puttana santa” (1970). Sposatasi in seconde nozze con il regista
Volker Schlondorff, lavora al suo fianco sia come attrice che come sceneggiatrice:
in entrambi i ruoli collabora a “L’improvvisa ricchezza della povera gente”
di Kombach (1971), “Fuoco di paglia” (1972) e “Colpo di grazia” (1976).
Assieme al marito firma la regia di “Il caso Katharina Blum” (1975). Qualche
anno dopo comincia a realizzare film da sola mettendo a fuoco -attraverso la
testimonianza di esperienze e problematiche femminili -molteplici aspetti
della realtà socio -politica tedesca. Con “Anni di piombo” (1981), vincitore
del Leone d’oro alla mostra di Venezia s’impone di colpo all’attenzione
internazionale. Negli anni successivi realizza: “Lucida follia” (1982), “Il
lungo silenzio” (1993), “La promessa” (1995) e “Rosa Luxemburg”.
|
|
Titolo
originale: Antonia’s line Regia: Marleen Gorris Sceneggiatura:
Marleen Gorris Fotografia: Willy Stassen Scenografia:
Harry Ammerlaan Musica: Ilona Sekasz Montaggio: Michiel
Reihwein Win Louwrier Produzione: Hans De Weers, Antonino
Lombardo, Judy Countihan
|
|
Olanda: 1995 Durata:
93’ Distribuzione: Lucky Red Personaggi e interpreti
Antonia: Willeke Van Ammelrooy Danielle: Els Dottermans Bas:
Jan Decleir Deedee: Marina De Graaf Dito Storto: Mil
Seghers Janne: Michael Pas
|
|
* a cura
di Paola Nucciarelli
|
|
Thérése: Verlee
Van Overloop Lara: Elsie De Brauw
|
|
Grottesca,
surreale visione di una famiglia di donne in un paesino rurale olandese. Uno
splendido affresco sulle genealogie femminili, un messaggio di speranza che
supera la morte.
|
|
La
storia inizia dal momento in cui Antonia, la protagonista principale, si riappropria
della sua vita: è vedova, ha una figlia di 16 anni e si trasferisce nella
fattoria dove è nata. Antonia è una donna vigorosa, indipendente, coraggiosa,
che non ha un minimo imbarazzo fisico del suo corpo femminile, lo porta
avanti con orgoglio, con forza. L’ALBERO DI ANTONIA, ovvero della sua
stirpe, della Genesi: Antonia generò Danielle, che generò Therese, che generò
Sarah.... In questo film troviamo donne capaci di autodefinire la propria
identità a prescindere dal potere e dal volere dell’uomo. Queste donne sono
tutt’altro che ostili verso l’altro sesso, prendono dall’uomo il buono che
può dare e lo fanno serenamente. Antonia e le sue compagne non si lasciano
sottomettere dal senso comune di un villaggio bigotto dell’Olanda cattolica
del dopoguerra, sono donne che superano certe ipocrisie religiose, non si
lasciano imbrigliare, vanno oltre.
|
|
Può sembrare irreale che queste donne particolari
riescano poi a vivere con agio in un paese che dimostra in fondo di non avere
pregiudizi, dove i buoni trionfano e i cattivi vengono puniti...se ben
ricordiamo per molto tempo le vedove, le donne sole o venivano costrette in
monasteri con l’imposizione della clausura o, se dimostravano autonomia di
pensiero, diventavano pericolose e venivano mandate al rogo dopo terribili
torture per cui erano costrette a dichiararsi streghe o eretiche. Perchè
abbiamo scelto questo film così diverso dai precedenti, senza la bella patina
stile Hollywood, per certi aspetti dissacrante? Perchè L’ALBERO DI ANTONIA
celebra la vita e la felicità di donne diventate forti attraverso la politica
delle relazioni di genere. In questa storia il tempo e la vita si evolvono
ciclicamente in modo onesto, crudele, divertente e in certi momenti
surreale. Attraverso lo scorrere del tempo, il lungo tavolo, al centro
dell’aia, diventa più popolato, più abbondante di cibo e di vivacità. Il
motivo della circolarità del tempo, del rincorrersi delle stagioni è sempre
presente; madre natura fa nascere, crescere e morire secondo un disegno che
va oltre la nostra semplice esistenza e quando la vita di Antonia ha compiuto
il suo cerchio, i banchetti gioiosi diventano depositari del suo testamento
che va ben oltre il suo albero biologico. Se c’è qualcosa che può disturbare
in questo film, è forse la difficoltà per alcuni di entrare nella dimensione
del ridicolo, dell’autocritica, in un regno della sincerità, e della verità.
Secondo la critica del mensile NOI DONNE, “il film ha una straordinaria e
sin-cera forza di pacificazione, una proposta di armistizio nella
interminabile e non conclusa guerra tra i sessi.” Ci piace infine
sottolineare che proprio la forza delle relazioni è il motore che ha creato
in questo film un modello utopico di armonia, una sorta di comunità dove si
lavora con gioia e con amore, dove non c’è lotta per il potere, il dominio,
la supremazia, dove con gioia si ama e si mettono al mondo i figli, dove il
diverso non viene emarginato, non è visto come castigo di Dio, ma come essere
umano facente parte del disegno divino, di madre natura, proprio da
quelle donne che hanno avuto una storia differenziata dall’uomo a causa del
loro sesso.
|
|
La
regista: Marleen Gorris
|
|
È una regista olandese nata nel 1950
che ha voluto fortemente questo film e che ha impiegato 6 anni a trovare i
finanziamenti per realizzarlo. Nel 1995 L’ALBERO DI ANTONIA ha vinto l’Oscar
come miglior film straniero all’Accademy Awards. È stato inoltre premiato per
la migliore fotografia al festival di Toronto e al festival di Hampton. Una
consacrazione per la regista olandese, che all’epoca era già al suo quarto
film. Eppure, per molto tempo, la sua figura era stata relegata nella
categoria “registe femministe”. Forse a causa della sua opera “A Question of
Silence, un’indagine sulla disparità tra
|
|
i
sessi: protagonista, un gruppo di donne di tutti i giorni che uccidono un
uomo senza ragioni apparenti. Una trama che fa scoppiare un focolaio di
polemiche nel mondo del cinema. Con “L’albero di Antonia” , cronaca famigliare
dai toni bucolici, Marleen Gorris riesce a scrollarsi un po’ di dosso l’etichetta
che le era stata assegnata. Ex studentessa di inglese e arte drammatica in
Olanda e diplomata presso l’Università di Birmingham in Inghilterra, viene
ora considerata una specialista nel raccontare storie di donne moderne. Il
suo ultimo film è “The Luzhin Defence”, con John Turturro e Emily Watson con
co-produzione francese.
|
|
Regia: Stephen
Friars Sceneggiatura: Cristopher Hampton Fotografia:
Philippe Rouselot Montaggio: Mich Ausdley Scenografia:
Stuart Graig Costumi: Jaames Acheson Musica: George
Fenton Personaggi e Interpreti marchesa di Marteuil: Glenn
Close Valmont: John Malkovich madame de Tourvel: Michelle
Pfeifer Cecile de Volanges: Uma Thurman cavaliere
Dangeny: Keanu Reeves Mildred Natwuic -Swoosie Kurtz Peter Capaldi
-Valerie Cogan Produzione: Norma Heeiman Hank Moonjean Distribuzione:
Warner Bross Durata: 121 Minuti Origine: U.S.A: * a cura
di Vanna Peronace
|
|
La
storia è ambientata nella Parigi di fine Settecento dove la perfida marchesa
di Marteuil (Glenn Close), per vendicarsi di un suo amante che sta per
sposare Cecile de Volanges (Uma Turrman), ordisce un intrigo perché la
giovanetta non arrivi pura alle nozze. Il seduttore perfetto è, per la
marchesa, il visconte di Valmont, il libertino più amato e temuto dai salotti
del tempo. Questi ha, però, in mente qualcosa di più intrigante: sedurre
madame de Tourvel (Michelle Pfeiffer) donna conosciuta per il rigore morale,
il fervore religioso, la fedeltà al marito. La posta in gioco si fa quindi
più alta. I due intriganti suggellano un patto: se Valmont (John Malkowich)
porterà una prova scritta per attestare la seduzione di madame de Tourvel, la
marchesa gli concederà una notte d’amore. La stessa, intanto, trova
nell’ignaro cavaliere Dangeny (Keanu Reeves) l’iniziatore ai piaceri del
sesso della giovane Cecile. Le vicende si complicano e le trame
s’infittiscono: Valmont fa cadere nella sua rete sia la de Tourvel che
Cecile. Dangeny si innamora di Cecile, ma stringe rapporti intimi con la
marchesa. ”Ognuno intesse relazioni forti” con gli altri creando una rete
inestricabile. Solo il finale tragico riesce a rompere tutti i legami: muore
la de Tourvel caduta, suo malgrado, nelle trame degli aristocratici, muore
anche Valmont dongiovanni di testa ma non di cuore, Cecile finisce in
convento, la perfida marchesa rimane vittima tragica perché, pur vincendo,
perde se stessa.
|
|
Ne ”Le Relazioni Pericolose” cinema e
teatro vanno piacevolmente a braccetto Il film teatralizza gli scenari, la
recitazione, gli oggetti e ne fa strumenti alta
|
|
mente
significativi. Anche gli attori testimoniano contaminazioni profonde con il
teatro: Glenn Close e John Malkowich nascono come attori di teatro; a loro è
dato di rappresentare il ceto aristocratico con il suo commovente decadere,
la loro è una recitazione più misurata, più contenuta. A Michelle Pfeiffer,
attrice cinematografica per eccellenza, è affidato il ruolo della borghese;
a lei è concessa la possibilità di una recitazione più spontanea, meno
vincolata, più immediata. Negli interni, ricostruiti senza risparmio, si
materializzano trame furtive: porte e specchi lasciano velocemente intravedere
il piacere, l’attesa, il sospetto. Lo spettatore si trova di fronte al
sorprendente comporsi di un puzzle dove ogni tassello ha un movimento
proprio che si inserisce, senza forzature, in un quadro d’insieme armonioso.
Del resto il romanzo epistolare, racconto fatto a pezzi dai suoi stessi
protagonisti, si offre alla messa in scena. Sullo sfondo il mondo
settecentesco appare come terreno neutro per conflitti, giochi pericolosi e
alleanze portate alle estreme conseguenze. Nel film la partita è tutta a
carte scoperte: il gioco consiste in una gara di menzogne notificate con una
fitta rete di prove scritte ed è permesso mentire anche a se stessi. La
finalità consiste nell’affermare la volontà di potenza attraverso la
conquista amorosa: vietato nominare i sentimenti. L’azione di questa brillante
partita a cinque parte su toni di commedia sofisticata per volgere rapidamente
al dramma, non appena gli ingranaggi del meccanismo cominciano ad incepparsi.
In questo gioco all’annullamento prevale l’esigenza ultima di riaffermare la
centralità del sentimento, la sua forza, la sua fondamentale giustizia: il
bene e il male sembrano appartenergli. Il sesso scompare dietro la forza e la
potenza del cuore, è un momento intrinseco al sentimento. Fuggire dai
sentimenti significa annullarsi. Accanto a personaggi virili, forti, intensi
(Valmont, la marchesa, madame de Tourvel) ci sono “anime grigie” (Cecile,
Dangeny) o troppo sciocche o troppo sensibili. Sullo sfondo ci sono i servi
“anime nere, col prezzo del tradimento stampato sulla faccia”. Madame de
Tourvel è il solo personaggio positivo. È una donna che, malgrado la rigidità
dei costumi, l’ossequio alla morale e alle ipocrisie della società contemporanea,
riesce ad essere una donna libera quando cede all’amore. Gli altri protagonisti
principali, la cui immoralità nasce per scandalizzare, non sono privi di
certa ambiguità che in parte può anche riscattarli: Il visconte di Valmont,
con tutto il suo cinismo, dimostra, ad un certo punto, accenti di vera passione
e persino di delicatissimo sentimento per la sua amante – vittima; la
marchesa di Marteuil, pur essendo donna di “genuina perfidia” che ha da
“sempre esercitato il distacco stringendo i pugni fino ad affondare le unghie
nel palmo delle mani senza perdere il sorriso sulle labbra”, appare, a volte,
gelosa proprio come una donna innamorata. Il regista che veste gli attori con
complicati rituali settecenteschi e li spoglia con moderna disinvoltura, ama
scolpire i loro volti e non esita, alla fine, a strappare la maschera
marmorea dal volto della marchesa: donna -attrice che merita di rimanere
sulla scena fino all’ultimo a raccogliere gli allori di una sconfitta che
finalmente “trascende ogni controllo”.
|
|
Il
regista: Stephen Frears
|
|
Nasce a
Leichester nel 1941, dopo avere girato parecchi films, molti dei quali per la
televisione, si stabilisce in America. La sua filmografia comprende Liam,
The Snapper, My beautiful Laundrette ecc. Ma è il film “Le relazioni
pericolose” del 1988 che gli vale una serie di “nominations” agli Oscar e che
vanta un “cast“ d’eccezione. C’è da dire che Frears, pur rifacendosi al
romanzo epistolare “Les Liaisons Dangereuses” di Choderlos de Laclos attraverso
la versione teatrale e la sceneggiatura di Hampton, resta alquanto aderente
al testo.
|
|
Vincitore
di 7 premi Oscar.
|
|
Regista: John Madden Musiche: Stephen
Warbeck Costumi: Sandy Powell Montaggio: David
Gamble Scenografia: Martin Childs Direttore della
fotografia:
|
|
Richard
Greatrex Produttori: David Parfitt e Donna
Gigliotti Sceneggiatura: Marc Norman e Tom Stoppard. Personaggi
ed Interpreti: Viola: Gwyneth Paltrow
|
|
W.
Shakespeare: Joseph Fiennes Elisabetta I: Judi Dench Conte
di Wessex: Geoffrey Rush
|
|
“Shakespeare
in love”, è una commedia romantica, brillante, avvincente, dal ritmo
incalzante e coinvolgente, interpretata magistralmente da un cast eccezionale
di attori.
|
|
Ambientato
alla fine del 500, il film registra con dovizia di particolari: l’atmosfera,
l’ambiente, la mentalità, l’ideologia dell’epoca.
|
|
Siamo a
Londra nel 1593, la città era stata sconvolta dalla peste ed i teatri erano
stati chiusi per paura del contagio. Nelle strade brulicanti di gente, un
puritano condanna apertamente il teatro considerato luogo di peccato e di
perdizione ed invita la folla a disertarlo. In realtà i teatri
rappresentavano un momento di aggregazione per tutte le classi sociali che
desideravano riconoscersi e vivere i drammi e le emozioni del palcoscenico.
In quest’atmosfera di tensione e di attesa per le opere da rappresentare, di
gelosie e di invidie tra i teatranti e gli attori, Shakespeare sta vivendo
una grave crisi ispirativa, non riesce a scrivere. L’incontro fortuito con
Viola, donna anticonformista, amante della poesia e del teatro, costretta a
travestirsi da uomo per poter essere libera di recitare, (soltanto alla fine
del 600 le donne potranno farlo), gli darà l’impulso necessario per scrivere
la tragedia d’amore più bella di tutti i tempi: Giulietta e Romeo. Viola, la
protagonista femminile, è una donna alla ricerca di se stessa, della sua
identità, ama la poesia ed il teatro più di qualsiasi cosa al mondo, ma non
può esprimere la sua vera essenza, può farlo solo diventando un uomo per 2
settimane: 14 giorni in cui sarà libera d’amare, recitare ed essere per una
volta se stessa. Ma purtroppo il sogno finisce, la realtà è lì pronta a
fagocitarla nello squallore di tutti i giorni: un matrimonio imposto a cui
non può sottrarsi, come Giulietta.
|
|
William
Shakespeare le dedicherà la sua opera successiva: ”La dodicesima notte”, la
cui protagonista porterà il suo nome: Viola. Il film si snoda tra vita e
palcoscenico, realtà e finzione, rendendo le sequenze suggestive, intense,
indimenticabili. Torna anche in questo film il binomio inscindibile
arte-vita, in cui uno Shakespeare innamorato, all’apice della sua passione
riesce a creare una storia indimenticabile, sempre attuale. L’opera di Shakespeare
viene resa in modo superbo ed impariamo ad apprezzarne la profondità proprio
dalla bravura degli attori. Che dire poi della Regina Elisabetta,
interpretata magicamente dall’attrice Judi Dench? Impeccabili e perfetti i
costumi, la scenografia, la ricostruzione storica. Ma il film, oltre ad
evidenziare, ancora una volta, la grandezza e l’unicità di questo grande
drammaturgo, pone una dovuta riflessione. Ci sarebbe potuta esse-re una
Shakespeare donna a quell’epoca? A questo interrogativo mi aiuta a rispondere
Virginia Woolf, la più grande scrittrice inglese del 900, nonché attenta
osservatrice del mondo femminile. Nel suo saggio: ”Una stanza tutta per sé”
(1929), raccolta di due conferenze sul tema: ”Le donne e la narrativa”,
tenute nel 1928 alle studentesse di Cambridge, esorta le donne a procurarsi
un’indipendenza economica ed una stanza dove poter scrivere in quanto donne
ed orgogliose di esserlo. Riguardo al periodo di Elisabetta anche la Woolf si
chiede: ”È un perenne rompicapo la ragione per cui nessuna donna abbia
scritto una sola parola di quella letteratura straordinaria; quando qualunque
uomo, pare, era capace di scrivere canzoni e sonetti. In quali condizioni
vivevano le donne? Innanzitutto le donne all’età di 15 anni si sposavano ed
avevano figli, nella maggior parte dei casi non avevano istruzione.
Consentitemi di immaginare, cosa sarebbe successo se Shakespeare avesse avuto
una sorella dotata, di nome Judith. Molto probabilmente Shakespeare
frequentò la scuola secondaria, dove avrà imparato il latino, Ovidio,
Virgilio ed Orazio, ed elementi di grammatica e di logica. A 18 anni si
dovette sposare di tutta fretta in quanto mise incinta una donna di 26 anni,
la madre dei suoi figli, ma ciò lo spinse a fuggire a Londra dove cominciò a
fare la guardia ai cavalli all’ingresso degli attori. Cominciò prestissimo a
recitare, diventò un attore di successo e di seguito il grande drammaturgo
che noi tutti conosciamo. Intanto sua sorella restava a casa. Non era meno
avventurosa, fantasiosa e desiderosa di conoscere il mondo di quanto lo
fosse lui. Ma non l’avevano mandata a scuola...di tanto in tanto, forse
prendeva un libro. Ma poi arrivavano i genitori e le dicevano di rammentare
le calze o di ricordarsi dello stufato, e di non perdere tempo fantasticando
tra libri e carte. ...Ancora adolescente era stata promessa in sposa, la
ragazza protestò ma fu picchiata da suo padre. Poi lui smise di rimproverarla
e la pregò invece di non arrecargli la vergogna di rifiutare quel matrimonio
. Le avrebbe regalato una collana di perle, oppure una bella gonna, diceva
con le lacrime agli occhi. Come poteva disubbidirgli? Come poteva spezzargli
il cuore? Solo la forza del suo talento la spinse a questo. Una sera d’estate
fece fagotto, si calò dalla finestra e prese la strada di Londra. Non aveva
ancora 17 anni. Gli uccelli che cantava
|
|
no
non erano più musicali di lei. Aveva, come suo fratello, la più vivace fantasia
per la musica delle parole. Come lui, si sentiva attratto dal teatro. Bussò
alla porta degli attori. Voleva recitare, disse. Gli uomini le risero in
faccia. Il capocomico sghignazzò e disse che nessuna donna poteva fare
l’attrice. Alluse invece...potete immaginare a cosa. Nessuno le avrebbe
insegnato l’arte. D’altronde, poteva mangiare nelle taverne o girare per le
strade di notte? Eppure il suo genio era letterario e desiderava nutrirsi
della vita degli uomini e delle donne, e dello studio dei loro costumi. Alla
fine , l’attore-capocomico, ebbe pietà di lei; si trovò incinta di questo
signore, e così si uccise, una notte d’inverno. Così, più o meno, sarebbe
andata la storia, penso, se a quei tempi una donna avesse avuto il genio di
Shakespeare. ...È indubbio che qualunque donna, nata nel 500 con un
grandissimo talento, sarebbe certamente impazzita, o si sarebbe uccisa, o
avrebbe finito i suoi giorni in qualche capanna solitaria fuori del
villaggio, metà strega, metà maga, temuta e schernita.-… Vivere una vita
libera nella Londra del 500 avrebbe significato per una donna, che fosse
poetessa o drammaturga, una tensione nervosa da ucciderla. E se pure fosse
sopravvissuta, i suoi scritti sarebbero stati comunque contorti e deformi,
appunto per il fatto di essere il prodotto di un’immaginazione forzata e
morbosa. E senza dubbio...le sue opere non sarebbero circolate con la sua
firma. ...Currer Bell (Charlotte Bronte), George Eliot, George Sand, tutte e
tre cercarono di nascondersi dietro un nome maschile e con loro siamo già
nell’800. Scrivere un’opera d’arte non è cosa facile, ma per le donne queste
difficoltà erano infinitamente più grandi. Il mondo diceva sghignazzando:
”Scrivere? A che serve che scriviate?” Oscar Browning che esaminava le
studentesse di Girton e Newnham era solito dichiarare che dopo aver preso in
visione le prove scritte, la migliore delle donne era intellettualmente
inferiore al peggiore degli uomini. ...Perciò è chiaro ed evidente che
perfino nell’Ottocento la donna non era incoraggiata a diventare artista. Al
contrario, venivano disprezzate, schiaffeggiate e ammonite. Una poetessa
inglese del 600, Lady Winchilsea, nobile per nascita e per matrimonio; non
aveva figli ed amava scrivere poesia, in alcune di esse la sentiamo scoppiare
di rabbia e d’indignazione per la situazione in cui vivevano le donne: Come
siam decadute, per regole sbagliate! Più dall’Educazione che non dalla Natura
Raggirate; impedita ogni crescita mentale, ignoranti per norma e per destino;
e se una vuol levarsi sulle altre, con calda fantasia, spinta dall’ambizione,
appare tanto forte la fazione contraria che mai speranza alcuna di crescita
può vincere il timore. È chiaro che la sua mente è turbata e dilaniata
dall’odio e dal risentimento. Per lei gli uomini sono “la fazione contraria”;
sono odiati e temuti, perché hanno il potere di impedirle di fare ciò che lei
vuole, cioè scrivere:
|
|
Ahimè! La donna che tenta la penna è stimata creatura
tanto presuntuosa che nessuna virtù può redimerne il fallo. Ci dicono: è un
peccato contro il sesso e il costume; buone maniere, moda, ballo, giochi e
vestiti, sono queste le doti che dovremmo bramare; scrivere , leggere,
indagar, pensare, ci oscurerà la grazia, ci consumerà il tempo, ci impedirà
le conquiste amorose; ma l’ottuso governo di una casa servile per noi è
ritenuto unico impiego ed arte.
|
|
Infatti,
per darsi il coraggio di scrivere, deve supporre che ciò che scrive non sarà
mai pubblicato; deve consolarsi con la malinconica strofa: Canta per pochi
amici, e per le pene tue, perché i rami di lauro non crescono per te; sia
oscura la tua ombra, e di questa sii paga.
|
|
John
Madden, regista di “La mia regina” (Mrs Brown, 1977), ha cominciato la sua
carriera come regista teatrale per poi passare alla televisione ed alla
radio. Nel 1975 si è trasferito in America e nel 1990 ha esordito al cinema
con “Ethan Frome-La storia di un amore proibito”, seguito da “Golden Gate”
(1994) .Nel 1998 dirige “Shakespeare in love”, vincitore di 7 premi Oscar:
Miglior film, Attrice protagonista (Gwyneth Paltrow), Attrice non protagonista
(Judy Dench), Sceneggiatura originale, Direzione artistica, Costumi, Colonna
sonora per commedia. Attualmente vive a Londra.
|
|
Regia: Franco
Zeffirelli Genere: Drammatico Durata: 100 minuti Produzione:
Italia 1993 Costumi: Piero Tosi Direttore della
Fotografia: Ennio Guarnieri Musiche: Claudio Capponi e
Alessio Vlad Sceneggiatura: Allan Baker,
|
|
F.
Zeffirelli, Piero Mattei Prodotto da Mario e Vittorio Cecchi Gori.
Personaggi ed interpreti Maria: Angela Bettis Nino: Jonathan
Schaech Suor Agata: Vanessa Redgrave Madre Superiora:
Valentina Cortese.
|
|
È il
1854. La Sicilia è devastata da un’epidemia di colera. Maria rinchiusa dalla
ricca matrigna in un convento, per evitare il contagio lascia il chiostro e
raggiunge la casa paterna alle falde dell’Etna. Qui incontra Nino, un amico
di famiglia, di cui s’innamora perdutamente. Incapace di lottare e di
contrastare apertamente le decisioni della sua famiglia che la vogliono suora
a tutti i costi, per motivi patrimoniali, impazzirà e morirà di dolore, nella
completa indifferenza . Il film è interamente tratto dal romanzo giovanile di
Giovanni Verga, scritto nel 1869 e pubblicato nel 1871. Il libro si basa
sulle lettere che la giovane Maria, costretta alla vita del convento pur
senza vocazione, scrive all’amica Marianna durante un breve soggiorno con la
famiglia in campagna. Queste lettere testimoniano il suo turbamento di
giovane novizia che al di fuori della vita monacale riscopre nuovi
orizzonti, soprattutto l’esistenza dell’amore che, osteggiato da tutti, la
porterà pian piano alla morte. Considerato a suo tempo una polemica denuncia
della condizione femminile, questo romanzo, adattato per il cinema da
Zeffirelli, è un grande dramma intimo, sentimentale, umano, estremo. La
critica cinematografica si è espressa in modo alquanto positivo sul film.
Possiamo leggere infatti: ”Il meglio di questa capinera di Zeffirelli è nella
sua funebre coralità, nel gusto con cui il desiderio viene sfiorato e negato.
“Io amo il mio peccato”! grida la novizia davanti al nudo crocifisso...”(da
l’Espresso). “Quel colera di Catania del 1854 con cui si apre il film è
ricostruito con un respiro spettacolare che scavalca Verga per ispirarsi
alla peste manzoniana….” (Tullio Kezich, Corriere della sera).
|
|
Alle origini della Storia di una Capinera ci sono
esperienze e ricordi autobiografici: i racconti della madre dello scrittore,
educata nella badia di Santa Chiara, prospiciente alla casa di Catania; il precedente
di alcune zie, che avevano abbracciato la vita del chiostro e allo stesso
tempo c’è anche un problema storico e sociale, quello delle monacazioni
forzate, rispetto a cui il romanzo verghiano intende in qualche modo porsi
come una presa di coscienza pubblica ed in ultimo ragioni letterarie ben
precise, (molti autori, Manzoni, Diderot, avevano affrontato questo tema
nelle loro opere). Maria, la protagonista del romanzo, è una giovane timida
ed insicura, già rassegnata al corso della sua esistenza priva di emozioni.
“Nacqui monaca”, constata senza nemmeno presumere di potersi ribellare. Tra
lei e la vita ci sono le mura di un chiostro, insormontabili. Maria infatti è
come una capinera e Verga lo spiega perfettamente nella prefazione del
romanzo. “Avevo visto una povera capinera chiusa in gabbia: era timida,
triste, malaticcia ci guardava con occhio spaventato; si rifuggiava in un
angolo della sua gabbia, e allorchè udiva il canto allegro degli altri
uccelli che cinguettavano sul verde del prato o nell’azzurro del cielo, li
seguiva con uno sguardo che avrebbe potuto dirsi pieno di lacrime. Ma non
osava ribellarsi, non osava tentare di rompere il fil di ferro che la teneva
carcerata, la povera prigioniera. Eppure i suoi custodi le volevano bene, cari
bambini che si trastullavano con il suo dolore e le pagavano la sua
malinconia con miche di pane e con parole gentili. La povera capinera
cercava di rassegnarsi, la meschinella, non era cattiva; non voleva
rimproverarli neanche con il suo dolore, poiché tentava di beccare
tristemente quel miglio e quelle miche di pane; ma non poteva inghiottirle.
Dopo due giorni chinò la testa sotto l’ala e l’indomani fu trovata stecchita
nella sua prigione. Era morta, povera capinera! Eppure il suo scodellino era
pieno. Era morta perché in quel corpicino c’era qualcosa che non si nutriva
soltanto di miglio, e che soffriva qualche cosa oltre la fame e la sete.
Allorchè la madre dei due bimbi, innocenti e spietati carnefici del povero
uccellino, mi narrò la storia di un’infelice di cui le mura del chiostro
avevano imprigionato il corpo, e la superstizione e l’amore avevano
torturato lo spirito: una di quelle intime storie, che passano inosservate
tutti i giorni, storia di un cuore tenero, timido, che aveva amato e pianto e
pregato senza osare di far scorgere le sue lacrime o di far sentire la sua
preghiera, che infine si era chiusa nel suo dolore ed era morta; io pensai
alla povera capinera che guardava il cielo attraverso le grate della sua
prigione, che non cantava, che beccava tristemente il suo miglio, che aveva
piegato la testolina sotto l’ala ed era morta. Ecco perché l’ho intitolata:
Storia di una capinera.“
|
|
La narrazione si pone come
confessione; le lettere però non sono inviate all’amato, bensì ad una confidente,
a una testimone passiva, Marianna, sua compagna di convento che finirà per
sposarsi. La confessione di Maria è perciò un monologo doloroso, senza
risposta, la sua vita è la storia di una repressione. Maria non è votata alla
vita monasti
|
|
ca,
ma la sua mitezza la spingerebbe a una graduale rassegnazione. Irrompe invece
l’amore che sconvolge il suo fragile equilibrio emotivo: Maria a questo
punto potrebbe diventare una Monaca di Monza, trovare anche lei il suo
Egidio, ma ciò non avviene, resterà stritolata nella tonaca nera a languire
nella sua prigione, non le sarà consentito volare e morirà come la capinera
nella sua gabbia dorata. La storia di questa repressione non può che portare
all’esplosione di una nevrosi, della pazzia della protagonista. Maria
finisce nella cella dei matti, in compagnia di suor Agata, con la quale
finisce con l’identificarsi. Il film ha reso perfettamente l’atmosfera
tragica e drammatica del romanzo verghiano che accompagna la presa di
coscienza e la maturazione individuale di Maria; una consapevolezza che
purtroppo non la salverà dalle sbarre del convento. L’amore per la vita, per
la natura e per Nino non cambieranno il suo triste e scontato destino, il
suo debole tentativo di ribellione non viene preso in considerazione, le
tagliano le ali, le impediscono di volare, di seguire il suo cuore e le sue
emozioni più profonde. La sua pazzia è un atto di protesta contro chi le ha
impedito di essere donna ed un modo per fuggire dalla realtà del convento
che odia, che le è divenuto insopportabile. Morire è per lei l’unica
salvezza, l’unica via d’uscita possibile all’inferno della sua atroce
esistenza.
|
|
Lo
scrittore: Giovanni Verga (Catania 1840-1922) Dal 1865 a
Firenze, dove compose i primi romanzi (Una peccatrice, Storia di una
capinera), si trasferì a Milano, dove, a contatto con la Scapigliatura,
rappresentò artisticamente il mondo aristocratico-borghese e le sue passioni
(Eva, Tigre reale, Il marito di Elena), per trovare la sua vera via, mediante
l’adesione al Verismo, nei racconti e romanzi di ambiente siciliano (Nedda,
1874; Vita dei campi, 1880; I Malavoglia, 1881; Novelle Rusticane, 1883;
Mastro don Gesualdo, 1889). L’arte di Verga rappresenta un mondo di
primitivi, in lotta con l’avverso destino, in cui inesorabilmente soccombono
quando si staccano dalla religione della famiglia e del lavoro. La lingua di
Verga, innovatrice, raggiunge effetti di grandiosa coralità. D’intensa
drammaticità è il suo teatro: Cavalleria Rusticana, Dal tuo al mio, In
portineria.
|
|
Il
regista: Franco Zeffirelli
|
|
Nato a
Firenze il 12 febbraio 1923, si diploma all’Accademia di Belle Arti della sua
città e, dopo aver frequentato architettura, s’interessa di prosa lavorando a
Radio Firenze (1946). Debutta nel cinema nel 1947, interpretando il ruolo di
Filippo Garrone ne “L’onorevole Angelina” di Luigi Zampa ed assistendo
Luchino Visconti sul set de “La terra trema”, esordisce come regista teatrale
due anni dopo con “Lulù”, ed in seguito si dedica con notevole successo alla
regia di opere liriche, attività che svolge con continuità.
|
|
Il primo
film da lui diretto è “Camping” (1958), una commedia di sentimenti piuttosto
convenzionale; più personale egli sarà ne “La bisbetica domata”(1967) ed in
“Romeo e Giulietta” (1968), brillanti trascrizioni shakespeariane realizzate
con notevole gusto e sorvegliata eleganza figurativa. All’insegna del
manierismo sono invece i successivi “Fratello sole, sorella luna”(1971) ed il
Kolossal televisivo “Gesù di Nazareth”(1977); il remake di “The champ”,
diretto nel 1979, il melodrammatico “Amore senza fine”(1981) risulta
sufficientemente godibile. Rigoroso nella trasposizione schermica de “La
Traviata”(1982), più leggero in quella di “Otello” (1986), Zeffirelli incappa
in un autentico infortunio con il ridicolo e gigionesco “Il giovane
Toscanini” (1988), parzialmente riscattato da un “Hamlet” (1990)
contraddistinto da un’insolita fisicità e da un inusuale vigore. Infine,
“Storia di una capinera” che rende merito alle pagine di Verga, e la trasposizione
del brontiano “Jane Eyre” (1995) va ascritta al novero delle sue pellicole
più riuscite. Il suo ultimo film è “Un tè con Mussolini”.
|
|
Titolo orig. The way we were Usa 1973
Regia: Sydney Pollack Sceneggiatura: Arthur
Laurents Musica: Marvin Hamlisch Fotografia: Harry
Stradling Jr ScenografiA: William Kiernan Montaggio:
Margareth Booth Personaggi e Interpreti: Hubbell: Robert
Redford Katie: Barbra Streisand Bradford Dillman Lois Chiles;
Patrick O’Neal; Viveca Lindfors Murray Hamilton; Herb Hendelman Produzione:
Ray Stark Per Columbia/Warner Durata: 118’
|
|
* a cura
di Paola Nucciarelli
|
|
Katie e Hubbel ex compagni di
università convivono, nonostante una sostanziale incompatibilità nell’America
di Roosevelt: lei è fermamente convinta delle idee comuniste, lui, uomo
intelligente e affascinante, vuole tenersi fuori dalla mischia e lavorare
come sceneggiatore e scrittore a Hollywood. Ritoccato nel montaggio dai
produttori, il film è una delle migliori prove di Pollack per la
caratterizzazione di due psicologie forti e decise, per la direzione degli
attori molto diversi, ma efficacemente amalgamati, per la regia sorretta
dagli ottimi dialoghi di Laurents che non cede mai al sentimentalismo nonostante
questo sia un film d’amore. (Ci pensa la bellissima colonna sonora del film)
L’impianto del film è quello di una storia sentimentale che accompagna le
vicende collettive di un periodo storico cruciale: il rooseveltismo, la
guerra fredda, i processi ai comunisti. Le attività antiamericane, il
reinserimento umano e professionale dei reduci della seconda guerra mondiale
nella società. Dopo la seconda guerra mondiale, mentre l’Europa era divisa in
due blocchi contrapposti, negli Stati Uniti il presidente Harry Truman
promulgò la cosiddetta ‘dottrina di Truman’ che consisteva nell’esplicito
impegno degli U.S.A. di aiutare i popoli liberi nella lotta contro i
tentativi di sopraffazione da parte di minoranze armate o di pressioni
esterne e di aiutarli se fossero stati aggrediti da qualche regime
autoritario. Questo andava anche considerato come un preciso monito
all’U.R.R.S: qualunque suo tentativo di interferire all’interno del blocco
occidentale avrebbe visto scendere in campo gli Stati Uniti d’America. Tali
decisioni ebbero gravi ripercussioni psicologiche all’interno del paese.
Rendendo esplicito il ‘pericolo rosso’, la politica di Truman fece degenerare
il
|
|
sentimento
anticomunista, già molto vivo tra gli Americani, in “caccia alle streghe”.
Con questa espressione si intendono le accuse e l’emarginazione di cui
rimasero vittime coloro che erano sospettati di simpatie per il pensiero
comunista, soprattutto gli intellettuali, gli scrittori, i registi e gli
attori e tutti quelli che occupavano posti di rilievo nell’amministrazione e
nella vita pubblica. Si distinse in questa crociata anticomunista, che fu
poi rinnegata dagli stessi americani, il senatore Joseph Mac Carthy, che
diede origine al fenomeno chiamato maccartismo e che costrinse molti
innocenti e personaggi illustri ad emigrare (Charlie Chaplin e molti altri).
|
|
Quando
si guarda un film, molte sensazioni affiorano e ognuno può leggerci quello
che vuole, indipendentemente da ciò che intendeva il regista. Per chi scrive,
“Come eravamo” è un film d’amore, è un film storico, ma è anche un
film su una donna che sacrifica l’amore della sua vita per tenere fede ai
propri principi. Katie è ebrea (lo è anche la Streisand), è bruttina, povera,
ma è tenace, ama la politica, la libertà di pensiero e rifugge il perbenismo.
È una donna piena di certezze che si innamora del ragazzo più carino del
college, Hubbel, che ‘era come la nazione in cui viveva: aveva tutto troppo
facilmente’. Hubbel si lascia travolgere dall’uragano Katie, l’ammira per i
suoi interessi, la invidia per le sue certezze, la stima per le sue capacità,
ma si rende conto che non appartengono allo stesso mondo, in quanto, a suo
modo di vedere, Katie prende tutto troppo sul serio, spinge troppo, non si
integra perché lei vuole essere se stessa a tutti i costi, anche a rischio di
mandare in fumo il loro rapporto. Questo è un film degli Anni Settanta, in
pieno periodo femminista: la nostra eroina vive da sola a New York, lavora, è
indipendente, ha rapporti sessuali prima del matrimonio, è una donna
emancipata, un termine che sa di antiquato, di superato, oggi che si parla
di valorizzazione delle differenze.
|
|
Il
regista: Sidney Pollack
|
|
Nato a
South Bend, Indiana il I luglio 1935 è regista, produttore e attore.
Poliedrico, geniale, intuitivo il cineasta americano, è un esponente del
cosiddetto New Hollywood: un filone artistico che emerge dalle sue
regie, caratterizzato da una visione pessimistica della realtà. Accentuata
dalla rievocazione del passato amara e disincantata, volta a confermare la
sconfitta idealistica dei valori del presente. Per svelare attraverso il
film il disinganno attuale. Emblematiche, in questo senso le pellicole quali Non
si uccidono così anche i cavalli? del 1970 e il memorabile Come
Eravamo con uno dei suoi interpreti preferiti: Robert Redford. Anche il
suo modo di raccontare il western è particolare: detesta la violenza e la
morte fine a se stessa e preferisce delineare personaggi eroici e solitari,
ma realistici. Con Joe Bass L’implacabile e Corvo Rosso non avrai
il mio scalpo del 1972 ebbe due successi intensi che fecero epoca.
|
|
Geniale
nei thriller sottili e psicologici uscì nel 1974 con Yazuka e I tre
giorni del Condor l’anno successivo. Uscì con una spietata analisi del
giornalismo con Diritto di cronaca nel 1981 e ebbe un gran successo
con Tootsie nel 1982. Tra i lavori degli ultimi anni sempre con
Redford, La mia Africa del 1985 dove ottiene uno fra i più grandi
successi commerciali della sua carriera, oltre che vincere 6 Oscar fra cui
quello per la regia e come miglior film. Nel 1993 dirige Il Socio con
Tom Cruise e Gene Hackman e nel 1995 il remake di Sabrina con Harrison
Ford e Julia Ormond. Cineasta controcorrente, polemico e idealista, resta il
sognatore che si arrende al pragmatismo, a volte necessario. Il personaggio
tipo che porta sullo schermo si muove tra ciò che deve essere in quanto
inserito nella società e ciò che vorrebbe. Diffidente verso le istituzioni resta
liberale. Vedere le sue direzioni è sempre interessante e l’elenco dei suoi
film non si ferma quì.
|
|
Sophie’s
Choice Usa: 1982 Drammatico: 2h e 31’ Regia:
Alan J. Pakula Personaggi e Interpreti Sophie: Meryl Streep Nathan:
Kevin Kline Stingo: Peter McNicol Yetta: Rita
Karin Morris Fink: Josh Mostel Larry: Stephen
D.Newman Sceneggiatura: Alan J.Pakula Fotografia: Nestor
Almedros Musiche originale: Marvin Hamilisch Scenografie:
Gorge Jenkins Notizie: Oscar alla Streep come attrice
protagonista
|
|
* a cura
di Teresa Ciaccio
|
|
Siamo
nel 1947. Sophie, un ebrea scampata ai campi di concentramento, vive ora col
compagno a New York, ma un giovane scrittore si innamora di lei e ne scopre
un terribile segreto del passato.
|
|
Sophie
Zawistowska, cattolica, polacca, sopravvissuta ad Auschwitz, si stabilisce
in America alla fine della II guerra mondiale. Sophie è molto bella…colta…preziosa
nei gesti e nei pensieri. Vive a New York con il marito, un nevrotico
intellettuale, un rapporto di coppia folle, romantico; un perverso gioco al
massacro; le umiliazioni fisiche e psicologiche si alternano a momenti
dolcissimi di gioiosa e creativa follia…. Una storia femminile crudelmente
dolorosa.. Tutto in lei rimanda alla tragedia… La tragedia d’essere donna e
madre... Racconta… distilla i ricordi popolati dalle ombre... dai rimorsi...
da una vita offesa. Dalle sequenze del film…emerge lentamente una trama di
sofferenza profondissima... senza tregua... senza pacificazione... che lascia
lo spettatore con il fiato sospeso. Non basta a quietare il dolore
martellante... l’amore nevrotico del marito.. tenerissimo generoso, la
passione dell’amico scrittore. Non basta l’intermezzo di una parola
poetica... di una musica.. di una gita... che spezza il silenzio, che va
oltre il grido...oltre il deserto del dolore.
|
|
Film
drammatico..intensissimo..magistralmente interpretato da una delle migliore
attrici americane (Merly Streep) e da un Kevin Kline (Nathan) perfetta
immagine del nevrotico.
|
|
Ci racconta una versione personale e commovente del
dramma dell’olocausto... attraverso la vicenda esistenziale di una
sopravvissuta. Ci racconta la tragedia collettiva di una generazione
devasatata dalla distruzione aberrante il senso della vita... È un Film che
fa male... una drammatica testimonianza... per allargare le coscienze... Una
denuncia... un ammonimento per le generazione future... Per non “dimenticare”
|
|
Il
Regista: Alan J.Pakula
|
|
È nato
il 7 aprile 1928 a The Bronx, New York, USA. È morto il 19 Novembre 1998, in
un incidente stradale a Melville, Longo Island. Ha diretto: L’ Ombra
del Diavolo Il rapporto Pellican Presunto innocente
|
|
Cast
Tecnico Artistico Regia: Shekhar Kapur Aiuto regista: Tommy
Gormley Sceneggiatura: Michael Hirst Fotografia: Remi
Adefarasin Scenografia: John Myrne Musica: David
Stephenson Costumi: Alexandra Byrne Montaggio: Jill
Bilcock Produttore: Alison Owen, Eric Fellner Inghilterra:
1997 Durata: 124’ Produzione: Working Titles
Films Distribuzione: Polygram Film International
|
|
Personaggi
e interpreti Elisabetta I: Cate Blanchett Sir Francis Walsingham:
Geoffrey Rush Duca di Norfolk: Christopher Eccleston Robert
Dudley, Conte di Leicester: Joseph Fiennes Sir William
Cecil: Richard Attenborough * a cura di Maria Grazia
Riveruzzi Maria di Guisa: Fanny Ardand
|
|
Inghilterra
1554: con la regina Maria I al trono, cattolica zelante, nel paese regna
l’instabilità economica e religiosa. Nulla in quegli anni sembrava più lontano
da lei, Elisabeth, dal trono d’ Inghilterra; anni che la giovane donna trascorre
però a studiare, danzare come vi fosse predestinata, anni in cui gli ingle-si
turbati dalle lotte di palazzo intorno ad Edoardo VI e sconvolti dalla
ferocia con cui Maria vuole riportare il paese all’obbedienza cattolica,
guardano sempre più a lei, Elisabeth con speranza ed ammirazione (scena del
passaggio della carrozza regale di Elisabeth tra i tumulti e le invocazioni
di aiuto del popolo). Sfuggita alla condanna a morte per tradimento, il 17
novembre del 1558, Elisabeth riceve l’anello di Maria Tudor da sir Nicolas
Throckmorton come pegno di consacrazione. Incoronata regina, Elisabeth si
trova a dover affrontare nemici interni, la bancarotta, l’aggressione della
Francia… un esercito in disfacimento. Difficile credere all’improvvisazione:
Elisabeth all’epoca venticinquenne (era nata dalle criticatissime seconde
nozze di Enrico VIII e Anna Bolena) rivela fin dal primo momento il
temperamento prudente e calcolatore e il gusto per la scene teatrali, per le
danze (era un’ottima ballerina e un’ottima cacciatrice) che l’avrebbero
contraddistinta per 44 anni di regno.
|
|
Legata sentimentalmente a Robert
Dudley, il suo scudiero, alto e bellissimo, dal viso bruno di zingaro e
chiacchierato per lo stretto legame con la regina (ritratto storico),
Elisabeth rifiuta di sposare il duca d’Anjou e tiene in scacco tra vaghe
promesse e vaghe assicurazioni sia il papa, sia il neovedovo cognato spagnolo
Filippo II. In politica interna il compito che le spetta è immane. Il paese è
sconvolto dalla contesa tra cattolici e protestanti, da quando Enrico III nel
1534 l’ha separato dall’obbedienza papale: chiusi i monasteri le ricche
terre, i tesori d’arte sono stati venduti a nobili borghesi che subito si
erano schierati col re e con la Chiesa anglicana. Ma i loro capi spirituali
furono i primi a salire sul patibolo, quando Maria, la cattolica,
innamoratissima del marito, ha sinistramente illuminato l’Inghilterra di
roghi degli eretici nell’assurdo voto di diventare madre in età matura. Colta
e pragmatica, nei confronti del problema religioso, Elisabeth assume una
posizione scettica derivata dalla sua educazione umanistica (illuminanti
sono le parole pronunciate durante la scena dell’interrogatorio “Le lotte
religiose sono cose meschine... in fondo siamo tutti credenti”): non prende
posizioni di condanna rispetto ai cattolici, ma ragioni economiche e
politiche la portano sulle orme del padre. Con l’atto di supremazia il
Parlamento la dichiara prontamente “ governatore della Chiesa” e l’Atto di
uniformità impone a tutti i sudditi il Libro protestante delle preghiere. Per
Elisabettta sono anni di duro lavoro: vuole restituire al suo paese l’unità,
l’ordine e la pace. Il sentimento nazionale si coagula intorno alla snella
ragazza dai capelli rossi e i vivaci occhi azzurri che sembra avere a cuore
prima di tutto il destino del suo popolo. Elisabetta non lo deluderà mai. Due
sono i problemi che impegnano i primi anni del suo regno: convince-re il
Parlamento che non desidererà sposarsi e prevenire le insidie dei partigiani
di Maria Stuart, regina di Scozia, cattolica e sua legittima erede. Sventate
le cospirazioni e confidando in sir Francis Walsingham, riuscirà a diventare
la leggendaria regina Elisabetta, formidabile, imbattibile, intoccabile...:
la Regina Vergine. Di regina Elisabetta sullo schermo ce ne sono state tante;
cominciando dalla tremolante Sarah Bernhart e continuando con il volto soave
di Jean Simmons, o spaventoso di Bette Davis, o superbo di Glenda Jackson, o
sorprendente del travestito Quentin Crisps. L’ultimo Elizabeth, presentato
fuori concorso, al Lido di Venezia (settembre 1998) dal regista Shekhar Kapur
la più umana, ingenua e intelligente, crudele e affascinante, esitante e
decisa, perdente e vittoriosa, dal viso luminoso ed inquietante di Cate
Blanchett che, nella sua assoluta modernità, fa pensare più delle altre ai
ritratti ingioiellati e austeri della grande regina che si avvolgeva in abiti
ricchi e sontuosi come un idolo orientale. Elizabeth I d’Inghilterra piace
perché consente spesso di porsi la domanda: era vergine o no? In ogni caso in
quest’ultimo film, Elizabeth di sicuro vergine non lo è, se si deve tener
conto delle scene di danze sensuali con il conte di Leicester
|
|
e
dell’entusiasmo con cui la regina lo accoglie nella sua stanza molto frequentata
da dame di corte e da dignitari. Può darsi che nella realtà non sia andata
proprio come costruisce il film (anzi la storia lo smentisce), ma è un bel
momento del cinema di cinema, il processo attraverso il quale Elisabetta,
ormai saldamente sul trono, ripudia la sua carnale femminilità per “farsi”
regina vergine e sposare l’Inghilterra: pallida e irraggiungibile come una
Madonna diventa simbolo eterno di un paese raccolto e trasformato nel più
potente d’Europa. Cate Blanchett, vulnerabile nella vaga trasparenza della
sua pelle e perforante grazie agli occhi chiari e talmente penetranti da
invadere l’animo di chiunque la guardi; presta tutta la sua bravura e
sensibilità, nonché la sua tizianesca bellezza, al ruolo d’Elisabeth, regina
innamorata del potere, della vita, dell’amore e della fedeltà ai propri ideali.
In un’intervista di Natalia Aspesi, l’attrice dichiara: “ogni mattina stavo
due ore al trucco e altre due ore ci volevano per indossare i pesanti
abiti-corazza. E ho segnato il passaggio di questa vita regale proprio
attraverso il mutare delle pettinature, dei costumi, del trucco, sino a
trasformare, come si vede nei ritratti d’epoca, il mio volto in una maschera
bianca, senza sesso e senza tempo”. Splendida lettura cinematografica di un
personaggio storico assurto a mito, che ha fatto dell’uso dell’abbigliamento
solo in piccola parte, la soddisfazione della sua vanità femminile. Era prima
di tutto uno strumento di governo offrire di sé l’immagine di una remota dea,
senza tempo, che appariva ai sudditi idealizzata, immortale e rassicurante.
Il film è di straordinaria modernità, una lezione di come sia possibile fare
un film storico senza annoiare, con un cast perfetto e una messa in scena
impeccabile. Il tutto per raccontare il travaglio e la metamorfosi di una
donna che da adolescente inquieta e appassionata si trasforma in feticcio
della regalità. “Il corpo e la persona di sua Maestà non appartengono più a
lei ma allo Stato” le ricorda Sir Williams (?), non appena Elisabetta diventa
regina d’Inghilterra e ancora giovane e ardente freme sotto le carezze audaci
di Lord Robert come la sua terra, l’Inghilterra, sta fremendo sotto lo
scalpitio degli zoccoli dei cavalli che annunciano la guerra. La ragione di
Stato non ascolta le voci del cuore ed esige la rinuncia dell’amore.
Congiure, complotti, e guerre, sangue e morti, nell’Inghilterra del ‘500,
esigono da Elisabeth un governo spietato ed intelligente. “ Sarò pure una
donna, ma posso avere il cuore di un uomo”. “Ho liberato l’Inghilterra dai
miei nemici. Devo, dunque, essere di pietra! Non potrò più intenerirmi?”.
Frasi emblematiche di Elisabetta che preannunciano il rito di una spoliazione
dolorosa dell’identità femminile per assumere la nuova vestizione di genere
maschile: Elisabetta si taglia la splendida chioma, il cui colore rimanda
alla passione così evirata e lo stesso fa subire al roseo colorito della sua
pelle, tingendola di bianco. Si tramuta così in una statua apparentemente
impenetrabile e
|
|
indistruttibile
come la statuetta della Madonna che tanto l’ ha ispirata: ”Ho liberato
l’Inghilterra della sua presenza, devo prendere il posto di quell’intoccabile
simbolo”. Così diventa Elisabetta la regina vergine e rinuncia alla sua femminilità
per sposare l’Inghilterra e il suo popolo.
|
|
Il
Regista: Shekhar Kapur
|
|
Nato in
Pakistan nel 1945, si trasferisce a Londra negli anni ’70 dove lavora come
contabile. Comincia qui a interessarsi di fotografia e di cinema e, a 25
anni, deciso a cambiar vita, ritorna in India e intraprende la carriera di
attore. Pur continuando a recitare, nel 1983 passa dietro la macchina da
presa e dirige Masoom. Il successo del film lo impone come uno dei
maggiori giovani talenti del cinema hindi. Quattro anni più tardi realizza Mr.
India, un altro enorme successo, ora diventato un classico. Entrambi i
film ottengono numerosi riconoscimenti in patria. Nel 1994 presenta Bandit
Queen, proibito in India, ma festeggiato in molti festival occidentali
gli ha dato la notorietà internazionale.
|
|
Titolo
originale: ‘A price above rubies’ Cast Tecnico Artistico
Regia: Boaz Yakin Soggetto e Sceneggiatura: Boaz Yakin Fotografia:
Adam Holender Montaggio: Arthur Coburn Musica: Lesley
Barber Scenografia: Dan Leigh Costumi: Ellen
Lutter Produttore: Lawrence Bender, John Penotti Per A Band
Apart USA: 1998 Durata: 110’ Produzione:
Miramax Distribuzione: Pandora Personaggi e
interpreti Sonia: Renee Zellweger Mendel: Glenn
Fitzgeral Ramon: Allen Payne Rachel: Julianna
Margulies * a cura di Paola Nucciarelli Mendicante: Kathleen
Chalfant Feige: Edie Falco Rabbino: John Randolph
Moglie del rabbino: Kim Hunter Sonia bambina: Jackie
Ryan Yossi: Shelton Dane
|
|
“...Tu
non credi, mamma, perché non ci vuoi credere, perché la tua è una saggezza
collettiva, grande, immensa, che in questo deserto ti rende più forte e più
sicura, ma poi ti senti sempre più spaurita e meschina di fronte a una minima
goccia di mistero, e perciò quella goccia ti perseguita dappertutto, con una
logica ferrea e chiara e lampante come il sole a mezzogiorno…ma io non mi
spavento, mamma, e non mi sono spaventata”.
|
|
(Abraham
Yehoshua, Il signor Mani, Einaudi -Torino, 1994, p.87)
|
|
Nel
chiuso universo ebraico ortodosso di New York, Sonia, una giovane donna
cresciuta ed educata secondo gli schemi e i precetti rigidi della Bibbia, si
ribella alle ipocrisie della Comunità in cui vive.
|
|
Secondo la Torà (il libro sacro degli
ebrei) una donna virtuosa vale più delle pietre preziose e il titolo in
lingua originale ‘A price above the rubies’, letteral
|
|
mente
‘Un prezzo al di sopra dei rubini’, sintetizza perfettamente la trama di
questo film, è denso di significato, perché quella pietra, nella vita della
protagonista, ha un altissimo valore. Il film sembra ‘incastonato’ tra due
momenti: nel primo, un bambino regala un rubino ad una bambina, ma la pietra
è falsa. Nel secondo, un uomo regala un rubino ad una donna. Il gioiello è
vero, è bellissimo, ma è troppo tardi. Al centro del film, la valutazione di
una spilla che è bella, di splendida fattura, ma è falsa, come falsa è la
vita di Sonia. Non di una falsità immediata, evidente, ma sottile, difficile
da notare per un occhio non esperto, come per un profano scoprire che una
spilla di ottima fattura è in realtà un falso. La vita di Sonia Horowitz
rispecchia ciò che i suoi genitori volevano da lei: si è sposata con Mendel,
un giovane professore erudito e fermamente credente, ha dato alla luce un
figlio maschio, vive in un quartiere popolato da ebrei ortodossi come lei. La
vita dovrebbe scorrere senza problemi ma, per Sonia, la casa, la famiglia, la
vita matrimoniale, i rapporti intimi con il marito, non sono soddisfacenti
perché deve costantemente combattere con le sue passioni latenti che
diventano, con il passare del tempo, più impetuose e incontenibili. Sonia
intreccia una relazione adulterina e angosciante con il cognato Sender, con
il quale ha dei rapporti sessuali freddi e ostili. Questa esperienza fa
riflettere la protagonista e la spinge a capire se stessa, le sue vere
esigenze di persona e di donna e ad intraprendere una carriera nel commercio
dei gioielli. Il lavoro permetterà a Sonia di avere contatti con il mondo
esterno alla comunità dove scoprirà un mondo diverso da quello in cui è
cresciuta, lotterà con il marito, con la sua famiglia, nonché con se stessa
per affrancarsi dai tabù e conquistare quella libertà che tanto anelava. Per
vivere libera ed essere se stessa, Sonia dovrà pagare un prezzo altissimo,
ben più alto di tutti i gioielli e dei rubini che vende.
|
|
La
storia è raccontata dal punto di vista della protagonista che, contrariamente
agli insegnamenti ricevuti, mette al primo posto le sue esigenze individuali
e personali davanti a quelle del gruppo in cui vive: Sonia non è disposta a
sacrificare se stessa in cambio di una stabilità familiare e del benestare
della comunità in cui vive. Il film apre la porta quindi all’antica
questione (ricordiamo la figura di Antigone) e sempre attuale: i bisogni e le
credenze del singolo sono più importanti della stabilità della comunità in
cui si vive, delle leggi? È giusto sacrificare una stabilità familiare ed
emotiva, una rispettabilità, per ricercare la propria libertà? Sono più
importanti le leggi dettate dalla comunità che garantiscono, nel bene e nel
male, la stabilità della comunità stessa, o le aspirazioni e convinzioni
individualistiche e personali? E quale prezzo è giusto pagare per aver
infranto determinate regole? La protagonista del film è come Antigone,
risponde alla domanda con una scelta individualistica e ne paga il carissimo
prezzo: la perdita del suo bambino, degli affetti familiari, della sicurezza
economica. Sonia diventa un’eroina a tutti i livelli perché ha il coraggio
di guardarsi dentro e di accettare le conseguenze della sua lucidità.
|
|
Il film è privo di retorica, non sembra esserci, da
parte del regista, la volontà di emettere un giudizio sul modo di vita della
comunità ebraico-ortodossa : se si appartiene per cultura, per educazione, o
per convinzione e credo personale ad una certa comunità e non si sente il
bisogno di cambiare, nessuno ha il diritto di giudicare se questa
appartenenza sia giusta o sbagliata, ma se si ci si sente diversi è
sbagliato continuare a percorrere tale strada. Se una convinzione è profonda
e vera va sempre rispettata: il marito di Sonia che è un uomo buono e
profondamente credente, non infierisce sulla moglie, alla fine comprende la
sua diversità e l’accetta. L’aspetto più rilevante di questa pellicola è
quello di voler delineare una sorta di laicismo emancipato di cui Sonia è
l’elemento caratterizzante. La donna, infatti si schiera contro le ipocrisie
della comunità in cui vive, ma solo perché lo zelo religioso è quello che la
priva della sua femminilità e del suo essere donna nel senso più pieno. Il
gioco dei rubini è un film sul laicismo necessario all’emancipazione di
una donna da regole ed obblighi che non capisce. Il Dio nominato da tutti è,
nella mente della protagonista, solo un vecchio maschio bisbetico che non ha
alcuna pietà per gli esseri di sesso femminile. Ed è per questo, forse, che
la statuetta della ‘Madonna consolatrice delle donne’ che sta sul tavolo del
giovane artista ispanico, scrutata da Sonia con tanta curiosità, è la
concretizzazione (un po’ semplicistica) di quella richiesta di affetto e
comprensione da parte di un universo femminile spesso inascoltato da un Dio
che sembra rivolgersi soprattutto ai fedeli maschi.
|
|
Appartiene
a quel gruppo di giovani registi indipendenti che affrontano le diversità
culturali che convivono in un territorio così multicolore, come gli Stati
Uniti. Yakin nasce in Israele e da bambino si trasferisce con la famiglia a
New York, per poi arrivare ad Hollywood alla ricerca della fama e del
successo. Scrive la sceneggiatura di The Rookie (1990) diretto da
Clint Eastwood con Martin Sheen, un dramma sulla corruzione della polizia. Un
film mediocre, che lo spinge a interessarsi solo di società multiculturali,
con l’eterna lotta dell’individuo alla ricerca di se stesso. Quattro anni
più tardi esce Fresh (1994), storia di un afro-americano che cerca di
scappare dal violento e opprimente ghetto, dove ha sempre vissuto e dove le
uniche leggi sono costituite dalla corruzione, dalla droga e dalla violenza.
Nel 1998 torna alla regia con Il gioco dei rubini, nel 2000 ha diretto
Remember the titans con Denzel Washington.
|
|
Titolo originale: Dayereh Regia: Jafar
Panahi Personaggi e Interpreti Fereshtel: Sadr
Orafai Nargess: Parvin Almani Mojgan: Faramarzi
Coproduzione: Mikado e
Lumière Distribuzione: Mikado Durata: 90’ Leone
d’Oro Venezia 2000
|
|
*a cura
di Marisa Rotiroti
|
|
Il Film
Ambientato nell’Iran integralista e teocratico, il “Cerchio” è insieme la
narrazione simbolica di un “girotondo di dolore” e un “inno alla libertà”,
urlato dalle donne oppresse dal fondamentalismo islamico.
|
|
Nel film
non ci sono protagonisti assoluti, ma vengono narrate le microstorie di otto
donne alla ricerca della propria libertà; storie incomplete, che rappresentano
la condizione femminile iraniana in un ritratto collettivo: la tremenda e
costante ansia in cui vivono le donne nel timore di sbagliare, di essere
colpevolizzate, di venire rimproverate e punite. Tengono, infatti, gli occhi
sempre bassi, camminano a passo veloce rasente i muri e si coprono quanto più
è possibile.
|
|
Le donne
che il regista prende a campione vivono situazioni estreme: di loro non si sa
nulla, tranne il fatto che abbiano scontato una pena detentiva e che
condividano una condizione di precarietà e di costante pericolo; “escono
tutte da una piccola prigione (dove sono state rinchiuse per
il solo fatto di essere donne) ed entrano in una prigione più grande,
quella della società; per tutto il tempo del film, quindi, si trovano
rinchiuse in un recinto, in un cerchio” (da un’intervista al
regista Panahi). I loro nomi sono tutti poetici ed evocativi di libertà:
|
|
Pari -farfalla
– pur essendo nubile, aspetta un figlio da un compagno che è morto, per
questo è scappata dal carcere. Cerca di abortire, ma non è possibile senza
il consenso di un marito o di un padre. Arezù – speranza – è uscita di
prigione con un permesso temporaneo. È molto nervosa, infastidita dal comportamento
degli uomini per strada e non può neanche fumare in pubblico, ma nel suo
doloroso peregrinare è molto fiera. Il suo unico obiettivo è quello di aiutare
la sua amica Nargess a ritornare nel suo villaggio di origine, che nel sogno
assomiglia al Paradiso. Nargess – fiore – innocente e tenera, ama la
vita, tende a smarrirsi nel mondo che la circonda, ma vuole fortemente
tornare a casa.
|
|
Elam è l’unica
che, uscita dal carcere, grazie al matrimonio con un medico, si è ben
inserita nel mondo del lavoro e nella società. Il costo di questa “normalità”
è, però, l’annullamento del suo passato e quindi della sua identità. Monir
tornata a casa dalla prigione deve accettare la seconda moglie del marito
alla quale persino la figlia si è affezionata più che a lei. Nayereh, madre
nubile, tenta di abbandonare la propria figlia, pur amandola disperatamente,
perché spera che in una famiglia vera si troverà meglio. Mojgan è una
donna orgogliosa: non mente e non nasconde di essere una prostituta. È
l’unica che riuscirà a fumare la...tanto agognata sigaretta!... Solmaz
Gholami ha partorito una femmina e non un maschio come sembrava
dall’ecografia. La madre è terrorizzata perché teme il divorzio per la
figlia, di contro sono sereni e gioiosi i volti delle donne che le sono state
vicine durante il parto e sembrano invitare all’accettazione della bambina.
E’ l’unica che nel film non si vede mai, ma è importante perché rappresenta
la saldatura del cerchio!…
|
|
Il suo
futuro, però, non è roseo nonostante il significato del suo nome: fiore
eterno. Speriamo che non sia femmina....Due episodi significativi
stimolano il regista Jafar Panahi a girare il film: la nascita della propria
figlia nel giorno della sua laurea e la lettura di un trafiletto di giornale “donna
si toglie la vita dopo aver ucciso le sue due figlie”...nulla più...
Essere donna è difficile dovunque (promozioni mancate nel lavoro, aumenti
salariali non concessi, mobbing nell’ambito lavorativo e familiare…), ma lo è
molto di più nel mondo islamico. Il toccante film di Panahi è molto eloquente
nella sua forza espressiva e ci mostra con stile rigoroso ed asciutto la
difficoltà di essere donna in Iran; infatti il primo vagito di una neonata
è già un grido che, soffocato, sommesso, accompagnerà per sempre la sua
condizione di donna.
|
|
Per
descrivere l’atmosfera di un paese dove alle donne sono negate le libertà più
elementari il regista sceglie una narrazione circolare efficacemente metaforica,
che si evidenzia nettamente nell’analogia creata tra la prima inquadratura e
l’ultima, nelle immagini di feritoie che aprono o chiudono il varco allo
sguardo, nella chiusura di porte (simbolo di negazione di libertà),
nell’annullamento della corporeità di tutte le donne occultata da informi soprabiti
grigi e chador neri, nella sensazione che ogni donna possa essere sostituita
da un’altra in un cerchio di emarginazione che annulla le differenze.
Lo stesso cerchio si allarga e racchiude le donne del mondo
occidentale imponendo una riflessione: pur avendo il boom economico e il
movimento femminista degli anni ’70 spazzato via quei divieti, dovuti più
alle consuetudini sociali che alle leggi, anch’esse sono prigioniere di
qualcosa: dell’emancipazione, della loro bellezza ad ogni costo, dei centri
commerciali per lo shopping, dell’omologazione al modello maschile, che
annulla le differenze e nega il diritto di esistere per sé. Gli otto
brevi ritratti di questo bel film corale, denso e toccante, ci parlano con la
loro ricchezza umana e i loro drammi leggibili sui forti volti ripresi in
intensi primi piani, ci rendono partecipi del loro cammino in cui ogni donna “si
vede” nell’altra e le passa il testimone della propria esperienza.
|
|
Nel film di Panahi motivi storici e culturali
racchiudono anche gli uomini in un cerchio di arretratezza e di isolamento:
non si nota mai alcun tipo di maltrattamento o di collera maschile verso le
donne. Elle, però, hanno paura della polizia che, vista in campo lungo, ha
un aspetto minaccioso per cui si nascondono e fuggono; in campo medio invece
il poliziotto ha un aspetto gentile e quando alla fine si trovano a bordo del
cellulare sono finalmente immerse in un’atmosfera di umanità. Per Panahi il
“giocoliere” che tiene le donne nelle sue mani è lo Stato mai nominato,
ma sempre presente; lo Stato come potere e organizzazione sociale, come
religione, ideologia, tradizione e costume.
|
|
Nato nel
1960 a Mianeh (Iran), Jafar Panahi ha studiato regia alla scuola di Cinema e
Televisione di Teheran. Dopo aver girato diversi cortometraggi per la
televisione iraniana, ha lavorato come aiuto regista di Abbas Kiarostami al
film “Sotto gli ulivi” (1994). Nel 1995 realizza il suo primo
lungometraggio, “Il Palloncino bianco”, alla cui sceneggiatura
collabora Kiarostami. Il film ottiene la Camera d’or per la Miglior
Opera Prima ed il Premio Fipresci della Critica Internazionale al
Festival di Cannes del 1995. “Lo Specchio” suo secondo film, ha
ricevuto il Pardo d’Oro al Festival di Locarno nel 1997, confermando
le sue doti di regista sensibile e innovativo. “Il Cerchio”, terzo
lungometraggio del regista ha conquistato il Leone d’Oro a Venezia nel
2000.
|
|
Regia: Norman Jewison Personaggi
e Interpreti Martha Livingston: Jane Fonda Madre Superiora:
Anne Bancroft Agnese: Meg Tilly Fotografie: Sven
Nykvist Colore -1985 Drammatico -Durata: 95
minuti Nominatin Oscar 1985: migliore attrice: Anne Bancroft migliore
attrice non protagonista: Meg Tilly migliore colonna sonora:
Georges Delerue
|
|
*a cura di Maria Grazia Riveruzzi
|
|
In un’atmosfera
surreale, riscaldata dai colori cupo-rossastri di un cielo al tramonto, si
staglia su un colle solitario il convento di clausura de “Les petites
soeurs”. L’obiettivo si sposta all’interno del luogo e indugia nel simbolismo
scenografico di lunghe file di “capinere” in preghiera e di quadri di sante
in estasi; le scene sono accompagnate da musiche e canti religiosi che
concorrono a creare nello spettatore suggestioni remote e infantili. Ma...un
grido acuto squarcia il silenzio della notte e riporta bruscamente lo spettatore
ad una cruda realtà, dominata da sangue e da sgomento: una giovane suora,
Agnese, partorisce nella propria cella e strangola il proprio neonato.
Miracolo o profanazione? Questo dilemma sovvertirà l’ordine dei pensieri e
delle emozioni della dott.ssa Martha Livingston (Jane Fonda), psichiatra,
nominata dalla Corte e incaricata dalla Magistratura di scoprire la verità.
Siamo negli anni settanta del XX secolo e la storia si svolge in una Montreal
dinamica e moderna; eppure nei suoi dintorni vive un mondo a parte, chiuso da
mura secolari e rinchiuso in un reticolato di abitudini e di vite lontane,
dove, ancora una volta, si ripropone l’incontro-scontro tra ragione e fede.
Agnese (Meg Tilly), la giovane e angelica novizia, sostiene di non avere
nessun ricordo né della nascita né del concepimento, parla di unione con Dio,
evoca visioni mistiche e apparizioni della “Signora“, che chiama “mammina”.
La Madre Superiora (Anne Bancroft) crede nella sua storia, crede nei miracoli
(sanguinamenti, concepimento per opera di Dio) e crede in Agnese quale sposa
di Dio.
|
|
Martha non crede nei miracoli, ma resta colpita
dall’ingenuità infantile di Agnese e dalla sua sincera devozione. Vuole
capire e spiegare l’intricato e delittuoso mistero con la forza della
ragione e della verità. Con la complicità di un luogo, lontano dal tempo e
dallo spazio e dalle pastoie di morali laiche o religiose che siano,
s’intrecciano, tra queste donne così diverse, rapporti affettivi, confidenze
e trasgressioni maliziose (sigarette), storie di vissuti dolorosi e di
desideri di amore e di riscatto. Si sciolgono, alla luce dei ricordi, le
reciproche diffidenze e per pochi momenti vacillano le certezze della
ragione (Martha) e le certezze della fede (Madre Superiora).
|
|
Entrambe
sono mosse da un unico desiderio: quello di salvare Agnese a tutti costi, di
sottrarla allo spietato e “troppo umano “giudizio delle autorità patriarcali,
ricorrendo l’una ai metodi dell’analisi psicanalitica e l’altra alle menzogne
di una fede filistea. Il volto candido e puro, il canto angelico e l’anima
innocente fanno di Agnese una creatura celestiale e tale appare a Martha; il
suo scetticismo vacilla di fronte a tanta ingenua e assoluta devozione in
Dio e nell’umanità. Crede in Agnese, che, seppur contaminata nel corpo, non
lo è di certo nello spirito e, pertanto, vuole dimostrare la sua innocenza.
La verità verrà svelata e con essa emergerà il dramma psicologico della
giovane Agnese, che si trasforma in una battaglia tra il rapporto con la vita
e con la sua stessa anima. L’anamnesi dell’infanzia di Agnese porta alla luce
un misterioso intrigo di legami familiari e di alienazione ed evoca anche
nella psichiatra tristi ricordi d’infanzia: il conflitto con la propria
madre, la frustrazione quotidiana di non esse-re da lei accettata, la ricerca
di luoghi segreti dove vivere la propria solitudine e sfuggire alle amarezze
della vita. La trama del film si snoda disegnando magistralmente il
parallelismo tra le scelte esistenziali e radicali delle tre donne: la
Chiesa, Dio, il lavoro-carriera ...e sembra suggerire allo spettatore a non
concepire le proprie scelte (teologiche, ideologiche e quant’altro) come
qualcosa di definitivo e di estremo. Non è da escludere che il regista
JEWISON, incline ad un’esegesi laica della materia religiosa, si sia ispirato
alla tradizione mistica del Cattolicesimo per rappresentare l’esperienza
mistico-carnale di Agnese come frutto di alienazione e d’isterismo, ma anche
come una via di evasione e di liberazione, come un’aspirazione alla
perfezione ed alla felicità. Isterismo mistico e devozione assoluta, quindi,
potrebbero essere la chiave di lettura dell’intricata vicenda; ciò non toglie
che la fede svolga un ruolo importante e faccia di Agnese “un caso
speciale”..., “una creatura di Dio” destinata a restituire fiducia nella
vita alla Madre Superiora e ad infondere amore nell’animo ormai inaridito
della psichiatra. Significative risuonano le parole di speranza con cui Marta
dà voce al suo cuore e che accompagnano “fuori scena” le ultime sequenze del
film: “Volli pensare che fosse toccata dalla Grazia”.
|
|
Non
bisogna dimenticare che il matrimonio mistico è un topos del Cristianesimo
dalla storia lunga e complessa che risale al Medioevo, comprendente
l’esegesi biblica, la liturgia, cerimonie pubbliche (scena dell’investitura
della novizia), misticismo e vita monastica. Già a partire dal IV secolo
d.C., i teologi cristiani consigliavano alle religiose di pensare alla loro
vita come ad un matrimonio con Cristo. Con lo sviluppo della vita claustrale
nel Medioevo, le monache ebbero sempre presente come modello la Vergine
Maria, sposa di Dio, in un’unione mistica. Un testo anonimo tedesco di questo
secolo, il St. Trudperter Hohelied,dà un’interpretazione mariologica del
Cantico dei Cantici proponendo un paragone continuo tra la Vergine Maria e le
monache, spose di Dio. L’idea del matrimonio mistico nel XII secolo, oggetto
di predicazione maschile e clericale rivolta alle monache, entrò nei secoli
successivi nella tradizione delle religiose, rendendola parte integrante per
la comprensione di se stesse. Basti ricordare due sante del XIII secolo,
Chiara d’Assisi e Gertrude di Helfta; quest’ultima, nell’organizzare la vita
monastica in 7 gradi, introdusse nell’exercitium divini amoris, al 5° grado,
il desiderio della “unio mistica” come parte della devozione quotidiana della
monaca. In effetti, la propria autorappresentazione come sposa di Dio diventò
una componente essenziale della spiritualità femminile fino alle soglie
dell’età moderna. Rudolph M. Bell ha preso in esame quasi duecento storie di
religiose, beate o sante, e vissute tra il XIII e il XVI secolo per essere
state famose per i loro poteri spirituali in imitatio Christi e in unione
Christi. In tutti questi secoli e in tutti i cambiamenti sociali e etici ,il
matrimonio mistico ha mantenuto un potenziale liberatorio perché sia nella
sua forma comunitaria che in quell’intima personale, esso implicava sempre un
legame con Dio, ovvero l’unione mistica che il Cristianesimo interpretava
come il potere massimo.
|
|
Regia: Luc
Besson Interpreti: Milla Jovovich, John Malkovich, Faye
Dunaway, Dustin Hoffmann Tchecky Karyo, Vincent Cassel. Musica:
Eric Serra Costumi: Catherine Leterrier Colore -1999
Durata: 152 minuti Produzione: Francia, 1999 Durata:
161’ Sceneggiatura: Luc Besson -Andrew Birkin
|
|
Fotografia: Thierry
Arbogast Scenografia: Hagues Tissandier Montaggio: Sylvie
Landra Musiche: Eric Serra * a cura
di Mara Gaudioso Costumi: Catherine Laterrier
|
|
Giovanna D’Arco giovane contadina
francese, analfabeta, viene incaricata da Dio, di liberare la Francia dagli
inglesi. Diventata scomoda al potere costituito per le sue inspiegabili
capacità divinatorie e anche perché donna, dopo le sue innumerevoli vittorie,
verrà fatta cadere nelle mani degli inglesi. Processata per eresia verrà
condannata al rogo nella piazza di Rouen il 31 maggio 1431. Il regista del
film, Luc Besson, da buon francese ha realizzato un’opera intensa, vivendo
con trasporto e partecipazione questa drammatica storia e anche per la
straordinaria interpretazione degli attori, tutti di indiscutibile bravura.
Il film ha inizio con Giovanna bambina, che vive in un villaggio di campagna.
La sua vita scorre tranquilla fino a quando non assiste, impotente, alla
distruzione della sua casa e allo sterminio della sua famiglia per opera
degli inglesi. Da quel momento in poi è ossessionata dall’idea di cacciare
gli invasori dalla sua terra, così dopo diversi tentativi falliti si reca dal
re e lo convince ad affidarle un esercito per liberare la Francia dagli
inglesi, lui accetta, così Giovanna, guidata da Dio, porta inspiegabilmente
le truppe francesi alla vittoria. Sebbene tutti all’inizio la guardano con
sospetto, la deridano e la denigrino con insulti ed umiliazioni gratuite
perché non accettano che una donna, da sola, possa compiere un simile
prodigio, alla fine cominciano a rispettarla e ad avere fiducia in lei :
tutto ciò che lei presagisce, si avvera sempre. Così come aveva previsto, il
re verrà incoronato sovrano di una Francia non ancora del tutto libera, ma
incredibilmente Giovanna viene privata dell’esercito, mentre è pronta a
liberare Parigi. È chiaro quindi che Giovanna da eroina instancabile e
guerriera, è diventata scomoda per il potere costituito che la vede
|
|
come
una minaccia per la propria tranquillità politica e come una possibile fomentatrice
di popolo; così i francesi che lei aveva aiutato vigliaccamente la consegnano
nelle mani degli inglesi che avevano tutto l’interesse di eliminare quella fanciulla
che era riuscita da sola ad infliggere loro una sconfitta clamorosa. Durante
la prigionia Giovanna “incontra” la sua coscienza, interpretata dallo
straordinario Dustin Hoffmann, che farà nascere in lei il dubbio che i suoi
idea-li non erano opera di Dio, ma erano mossi da un suo personale spirito di
vendetta contro gli inglesi che si erano macchiati dell’assassinio della sua
famiglia. L’ultima confessione, prima del rogo, negata più volte da una
chiesa ipocrita, invischiata nei più squallidi giochi di potere, avverrà con
la propria coscienza. La pace dello spirito non si ottiene con una fede
razionale e meccanica schiava dei dogmi, ma con un’autocritica attenta e
severa del proprio comportamento, con un’analisi sincera dei propri errori.
Giovanna alla fine si rende conto che tutte le sue azioni sono stata una sua
libera scelta non un’imposizione venuta dall’al di là. Da qualsiasi punto di
vista si consideri Giovanna, una santa o una donna piena di coraggio che
vuole farsi giustizia da sola, in entrambi i casi è più che evidente che
questa donna faceva paura al potere, un potere maschilista che prima si era
servito di questa indomita guerriera e poi ottenuto ciò che voleva,
l’abbandona a se stessa e la vende nel modo più bieco al nemico. È questo quello
che mi fa maggiormente indignare, il tradimento più abietto, l’azione più
bassa che un uomo possa fare. E questo straordinario film è una ventata di
verità sugli anni bui della nostra storia. Giovanna d’Arco è senza dubbio un
ottimo film, con grandi interpreti, con una ricostruzione storica
apprezzabile, con degli splendidi costumi, con delle sequenze di battaglie
veramente realistiche. In definitiva un bel film, concreto, non scontato, che
dà un punto di vista intelligente ad un personaggio straordinario ed
enigmatico che trascinò un popolo oppresso alla propria liberazione. Detta la
Pulzella (dal francese antico pulcele, “fanciulla non sposata”) d’Orleans,
eroina francese, nata a Domremy nel 1412 e morta a Rouen nel 1431. La storia
di questa fanciulla sembra leggendaria , in realtà le vicende della sua breve
vita sono tutte vere, storicamente comprovate. Esse hanno come sfondo la
Francia nella guerra dei Cent’anni: verso il 1425 il suolo francese era
occupato per tre quarti dagli inglesi di Enrico VI e dagli uomini del duca
di Borgogna ( i “Borgognoni”); sull’altro quarto regnava un sovrano debole,
Carlo VII. Parigi era nelle mani degli inglesi e il re si era ridotto a vivere
a Bourges. In questa situazione tutte le città passavano al nemico : la dinastia
dei Valois sembrava avere vita breve, solo un miracolo avrebbe potuto salvare
la Francia. E il miracolo venne da un oscuro paese della valle della Mosa,
dove una ragazza di 13 anni diceva di avere delle visioni e di sentire delle
voci che la incitavano a combattere per la salvezza della patria. Si convinse
quindi di avere una missione da compiere : liberare la Francia dagli inglesi
e restituirla al suo re, Carlo VII.
|
|
Nel gennaio del 1429, Giovanna riuscì a farsi
ricevere da Carlo VII e gli disse di aver ricevuto da Dio il compito di farlo
incoronare re di Francia a Reims, che era allora in mano agli inglesi.
Rincuorato dalle parole della fanciulla, il sovrano le assegnò un esercito di
8000 soldati. Prima di prendere le armi Giovanna scrisse al re inglese
intimandogli di abbandonare il suolo francese, ma poiché non ottenne risposta
si ritenne libera di attaccare. Si recò prima ad Orleans dove costrinse gli
inglesi alla resa, fu questo il suo primo successo visto dai francesi come un
prodigio. A giugno del 1429 avvenne lo scontro decisivo a Patay, vicino ad
Orleans, qui gli ingle-si furono duramente sconfitti: caddero in battaglia
2000 inglesi e solo 3 francesi. La strada per Reims era aperta; il 17 luglio
Carlo VII veniva incoronato re e la Francia era salva. Giovanna terminata la
sua missione intendeva rientrare a casa , ma la convinsero a restare perché
bisognava conquistare Parigi. Ferita durante la battaglia, Giovanna tornò a
combattere e durante una ricognizione fu catturata dai Borgognoni che la
vendettero agli inglesi per 10000 scudi d’oro, nel novembre del 1430. La
ragazza fu imprigionata a Rouen e sottoposta a processo. Il suo principale
accusatore fu il vescovo di Beauvais, Pierre Cauchon, che incriminò Giovanna
per eresia e stregoneria. Si voleva dare in questo modo, una parvenza di
legalità alla condanna, ma lo scopo era quello di eliminare il simbolo della
resistenza francese, di vendicarsi delle umiliazioni subite da una fanciulla.
Fu arsa sul rogo, il 30 maggio 1431, nella piazza del mercato vecchio di
Rouen. Con la morte della pulzella gli inglesi si illusero di soffocare lo
spirito patriottico dei francesi. Ma così non fu: 20 anni più tardi la
Francia era liberata quasi per intero. Carlo VII, riconquistata Rouen, fece
rifare il processo a Giovanna d’Arco e la sentenza fu di piena assoluzione e
riabilitazione. Dall’esame dei verbali del processo sembra che lei sia stata
profondamente convinta di dover assolvere ad una missione soprannaturale.
Giovanna è stata dichiarata patrona della Francia.
|
|
Luc
Besson nasce a Parigi l’11 luglio 1936. A soli 24 anni gira la storia di fantascienza:
”Le dernier combat” (L’ultimo combattimento). Il secondo prodotto: ”Subway”
viene accolto male a Cannes, ma ottiene un grande successo al botteghino. Ma
la grande vetrina di Luc Besson è rappresentata sicuramente da “Nikita” e
balza in vetta agli incassi. È poi la volta de “Il quinto elemento” infine
“Giovanna D’Arco.
|
|
Regista: Amoi Gitai Genere:
Drammatico Sceneggiatura: Amos Gitai, Eliette Abecassis Fotografia:
Renato Berta Scenografia: Miguel Markin Musica: Philippe
Eidel Durata: 110’ Colore Israele: 1999 Personaggi
e Interpreti Rivka: Yael Abecassis Meir: Yoram Hattab Malka:
Meital Barda
|
|
* a cura
di Teresa Ciaccio
|
|
Nella
comunità ultraortodossa di Mea Shearim, quartiere di Gerusalemme ostile ad
ogni progresso e segnale di modernità, vivono due sorelle, Rivka e Malka.
Rivka ama ed è riamata dal religiosissimo marito Meir, ma nonostante siano
sposati da dieci anni ancora non hanno figli. Il rabbino capo, preoccupato,
ordina che Meir ripudi la moglie, ritenuta sterile. La sorella minore Malka è
innamorata del cantante Yaakov, in fuga dalla comunità costretta a sposare il
braccio destro del rabbino, un uomo rozzo che non la ama. Mentre Rivka si
chiude nel suo dolore in preda a una lancinante solitudine, Malka decide di
ribellarsi e tenta la fuga. “Benedetto il Signore per non avermi fatto
nascere donna”, con questo versetto delle preghiere mattutine si apre Kadosh
ed è subito…inquietudine...sgomento. Il filo conduttore di Kadosh, presentato
al festival di Cannes nel 1999, sono le donne, la loro non vita, la negazione
del desiderio, l’irrinunciabile manifestarsi dei sensi, i dolorosi silenzi…e
allora...l’inquietudine...agita …brucia. Rivka, la moglie amata e ripudiata è
commovente per l’intensità di gesti e silenzi, dentro un corpo imprigionato
nel desiderio e in una passione trattenuta, spinta al suicidio per un estremo
tentativo di liberazione. Malka, ribelle e trasgressiva, inorridità per la
fine della sorella, alla fine fugge da un matrimonio imposto, fuori degli
spazi claustrofibici della comunità. Con Kadosh, si entra in una caverna
”smaltata” di simboli, comandamenti e rituali religiosi severissimi che
schiacciano la vita… schiacciano le donne. Una trama di sottile sofferenza
annunciata e prescritta da una religione, dura, bigotta e cattiva che
scandisce implacabile i ritmi, le decisioni, le speranze e la vita delle
donne, sottolineata da un collettivo che amplifica come “un coro” assurdi e
lenti rituali sacrificando sentimenti e teneri affetti. Kadosh è
drammaticamente intenso; fotografa in maniera ossessiva e spietata l’amarezza
e la violenza di un sesso consumato in maniera fredda e atroce; la
|
|
disperazione dell’amore femminile; il rumore dei
silenzi; la bellezza di corpi seducenti erotici e prigionieri; le passioni
represse: Kadosh è straordinariamente commovente quando fa parlare i
sentimenti e si concentra sulla dolorosa storia d’amore matrimoniale fra
Rivha e Meir. Inquadrature scarne, spoglie e silenziose, scene fatte solo di
pudichi baci, malinconici sguardi, strazianti abbracci. Una pagina d’amore
straordinaria. La legge di un Dio vendicativo e crudele chiuderà la vita di
Rivha in un tragico silenzio. La sorella..sopravvissuta..si allontana dalla
comunità e nella dissolvenza fra il giorno e la notte, respirerà “libera”
sotto un cielo cupo di dolore. Kadosh è una spietata denuncia contro ogni
forma di estremismo, una prova della crudeltà e dell’assurdo di cui è capace
la fedeltà religiosa quando è condotta a sacrifici psicologici e
sentimentali inaccettabili. Kadosh è un film di riflessione e di profonda
inquietudine, perché ci costringe a riflettere sulla condizione della donna,
sulla libertà continuamente “violata” sul tentativo vecchio ma sempre nuovo
di “schiacciarla”.
|
|
Nato a
Haifa-Israele 1950 Gitai è uno dei registi israeliani più noti fuori di
Istraele, si è occupato di rappresentare la convivenza fra culture
differenti, raccontanto i nostri integralismi e quelli della sua società.
Società “giovane”, perché appena cinquantenne, eppure per certi versi simile
a una qualche arcaica dittatura del chador. Per Gitai, da sempre in polemica
con lo stato d’Istraele, l’aspra requisitoria di Kadosh chiude una trilogia
della riconciliazione. Devarim (le cose) parlava della moderna Tel Aviv e
della generazione dei quarantenni, i sabra, figli dei pionieri nati in
Palestina; mente YomYom, giorno per giorno, di spostava a Haifa, nella
mescolanza tuttora arroventata di arabi e istraeliani, divisi dalla ragione
di stato, ma spesso uniti da legami affettivi o familiari. Erano storie della
modernità contraddittoria e affannata di un paese anomalo come Istraele, ma
non colpivano ancora al cuore la questione dell’identità ebraica come fa
lucidamente Kadosh. Unica via d’uscita è la fuga, l’autoesilio da una
comunità fagocitante.. Gitai è egli stesso un autoesiliato: apolide per
scelta, tra Parigi e l’Italia.
|
|
FILMOGRAFIA
|
|
Ester
|
1985
|
|
Berlin-Jerusalem
|
1989
|
|
Golem
|
1991
|
|
Devarim
|
1995
|
|
Milim
|
1996
|
|
Giorno per
giorno
|
1998
|
|
Kadosh
|
1999
|
|
Kippur
|
1999
|
|
Eden
|
2001
|
* 92 *
|

|
Soggetto: tratto da un racconto di
Isaac Singer Regia: Barbra Streisand Sceneggiatura: Jack
Rosenthal e Barbra Streisand Musica: Michael Legrand Fotografia:
David Watkin Personaggi e Interpreti Yentl: Barbra Streisand
Avigdor: Mandy Patinkin Padre di Yentl: Amy Irving, Nehemiah
Persoff Steven Hill, Allan Corduner, Ruth Goring, Lynda Barron, Jack Lynn Prodotto
da: Barbra Streisand USA: 1983, 133’
|
|
* a cura
di Marisa Rotiroti
|
|
Tratto
dal racconto Yentl, lo studente della Yeshiva di Isaac Bashevis
Singer, premio Nobel per la letteratura.
|
|
In un
insediamento rurale tra Russia e Polonia vive una piccola comunità ebraica:
gli uomini lavorano e studiano la Bibbia, i giovani più dotati frequentano le
Yeshivà, le scuole dove si studia e commenta la Bibbia. Le donne si
occupano della casa, della famiglia e non possono studiare i testi sacri. La
figlia di un rabbino, che in segreto ha studiato le Scritture, dopo la morte
del padre decide di frequentare la Yeshivà in abiti maschili, assumendo il
nome del fratello morto prematuramente. Frequentando la scuola, per soli
uomini, s’innamora di un compagno: Avigdor, bello e protettivo. Prigioniera
della sua finzione, finirà con lo sposare la fidanzata di lui e dovrà fuggire
dal paese per por fine alle ambiguità ed essere finalmente libera di studiare
e vivere da donna.
|
|
Il film,
che si ispira alla rock opera, è organizzato attorno a un nucleo
narrativo preciso e ad un corpo di canzoni che costituiscono una scaletta di
concerto. Tratto liberamente dal racconto di Isaac Singer fa rivivere in modo
brioso e leggero una realtà [la donna moglie e madre, servizievole e
ossequiosa nei confronti degli uomini] che, almeno nel mondo occidentale,
oggi non esiste più. “Yentl” segna una pietra miliare nella storia del
cinema, perché per la prima volta, dopo Ida Lupino, una donna, Barbra
Streisand, ha prodotto, diretto, sceneggiato e interpretato tutto un
film.
|
|
Barbra
dedica questo film a suo padre e racconta la storia di un rapporto privilegiato
tra un padre rabbino e una figlia che non dovrebbe studiare, ma che egli non
ha il coraggio di allontanare dai libri. Ogni volta che le spiega le
Scritture però, il padre chiude le finestre per timore dei vicini, non per
esorcizzare la proibizione divina sancita dal Talmùd. Nella rievocazione
affettuosa del mondo scomparso sono evidenziati, senza nostalgia, i
pregiudizi e l’immobilità sociale della piccola comunità ebraica: il
venditore ambulante di libri tenta di convincere Yentl a comprare un romanzetto
rosa e le vende il trattato di teologia solo quando lei dice che è per suo
padre... Alla morte del rabbino la ragazza, messa di fronte al suo futuro di
pentole e padelle, decide di tentare la sorte assumendo un’identità maschile
col nome del fratello prematuramente scomparso. La seconda parte del film si
sviluppa con garbo ed ironia sul gioco degli equivoci: Avidgor, lo
studente di cui la ragazza s’innamora dopo essere stata ammessa nella scuola
talmudica, dubita, ad un certo punto, di essersi forse troppo affezionato
all’amico; in realtà… la sua attrazione segue le inclinazioni naturali...
Yentl, per aiutare Avigdor, accetta addirittura di sposare la sua fidanzata
Haddass quando egli rischia di perderla perché rifiutato dalla famiglia di
lei. Molto ben riuscite sono le scene di vita domestica della strana coppia;
il problema delle notti coniugali è brillantemente risolto perché Yentl non
inizierà Haddass ai misteri del sesso, ma fornirà a lei una diversa fonte di
piacere e di appagamento: la conoscenza, la cultura. Significativa
anche la scena in cui Yentl riflette in uno specchio rotto la sua immagine,
simbolo di un’identità divisa, scissa tra l’essere e gli obblighi delle
convenzioni religiose – sociali. Barbra Streisand, anche se non giovanissima,
veste bene i panni di un imberbe studentello del primo Novecento, con il
berretto, gli occhialini e la gestualità un po’ impacciata da primo della
classe che nasconde sempre il naso nei libri. La tematica, ispirata alla
libertà di scelta delle donne, si stempera nella commedia impostata sul
triangolo eccentrico: oltre alle scene in cui il travestimento provoca tutta
una serie di comici imbarazzi (piccola agonia di Yentl durante il matrimonio
religioso e la successiva festa da ballo in cui tutto per lei gira e si
confonde fino allo stordimento) sono interessanti le ricostruzioni della vita
bohèmienne degli studenti, i luoghi dove i giovani si riuniscono a
studiare, il gioco a dadi nella taverna, i bagni nudi nel fiume, gli amori,
ma anche le interminabili e accesissime diatribe sulla Legge con le
citazioni a raffica e le presenze paterne dei saggi rabbini dell’Europa
Orientale ad arbitrare. Il film è di semplice lettura, vuole divertire lo
spettatore/trice raccontando una favola, e le favole hanno tutte una loro
morale. Quella di Barbra Streisand propone garbatamente una piccola variante
dell’episodio biblico della mela nel giardino dell’Eden: sarà direttamente
Eva, la donna, ad assaggiare la mela della conoscenza.
|
|
“Che cosa c’era da aspettarsi da un film non solo
interpretato ma anche prodotto e diretto e scritto da una superstar che non
può mettere in gioco la propria sudatissima popolarità? Proprio quello che
Barbra Streisand ci ha dato: uno spettacolo facile e gradevole ad ogni
latitudine del globo, tranquillamente inserito ne genere romantico con
pieghe impertinenti, allietato da belle canzoni, simpaticamente femminista,
argutamente imparentato con Victor, Victoria e con Tootsie in
qualche riflessione sull’androginia e la moda dei travestiti, spiritosamente
punteggiato di situazioni azzardose, traboccante colore locale, e così deciso
a esaltare la forza di volontà da indurci a identificare la sua ostinata
protagonista, che preferisce le dispute teologiche alle chiacchiere delle
donne, con la sua caparbia interprete” (Giovanni Grazzini, “Corriere
della sera” 31/3/1984)
|
|
La
regista: Barbra Streisand
|
|
Nata a
New York nel 1942, inizia la sua carriera di attrice nel 1968 interpretando Funny
Girl. Lavora con i più famosi registi hollywoodiani da William Wyler a
Gene Kelly, a Vincente Minnelli. Nel 1973 gira Come eravamo per la
regia di Sidney Pollack. Nel 1983 debutta nella regia con Yentl, di
cui è anche sceneggiatrice e produttrice. Interpreta il difficile ruolo
della protagonista nel film Pazza di Martin Ritt. Il principe delle
maree del 1991 è la sua seconda prova come regista.
|
|
Regia: Norman
Jewison Musiche: Andrè Previn Sceneggiatura: Melvyn
Bragg
|
|
Gesù: Ted
Neely Giuda: Carl Anderson Maddalena: Yvonne
Elliman Colore Durata: 104 minuti Nomination all’Oscar
come migliore colonna sonora
|
|
Un
musical rock del 1973 adattato dalla commedia musicale di Tim Rice e Andrew
Lloyd Webber con una superba colonna sonora affidata all’esecuzione di Andrè
Previn per la quale ci fu una nomination all’Oscar come migliore ”colonna
sonora adattata per il cinema”. La sceneggiatura è di Melvyn Bragg che aveva
già lavorato ai film di tema epico diretti dal grande Cecil B.De Mille. Il
film, per il quale sono stati stanziati 3,6 milioni di dollari, abbandona gli
effetti strabilianti e la scenografia del musical già andato in scena a
Broadway. Straordinaria la voce e l’interpretazione di Ted Neely nei panni di
Gesù; strepitoso il lavoro di Carl Anderson già interprete di Giuda nel tour
d’esordio del musical di Broadway; intensa l’immagine della Maddalena
rappresentata molto efficacemente da Yvonne Elliman.
|
|
Il nudo
paesaggio introduce in chiave moderna la storia di un popolo e del suo
Messia; una chitarra elettrica ritmando musica cult passa in rassegna i
luoghi; una corriera colorata giunge poco dopo alzando un polverone....La
scena, in quel deserto della Palestina, in breve si popola per l’arrivo di un
gruppo di figli dei fiori che circonda Lui, il Gesù conteso, che assume
immediatamente nuove vesti. Tutto sembra dirci che lo Spirito soffia dove e
come vuole, che Dio può far nascere i suoi figli anche dalle pietre e l’uomo
ha proprio bisogno di un pezzo di deserto in cui rifugiarsi per ritrovare se
stesso, non per rimanerci ma per scoprire il senso della vita.
|
|
Gli
hippies scandiscono il tempo storico, sono parte di quella generazione di
giovani anni ’70 che, economicamente liberi, cominciano a distinguersi anche
sul piano dei valori e intrecciano con le ragazze i fili del cambiamento con
tutta l’energia e la fiduciosa illusione della loro età. Una delle prime
inquadrature si sofferma sulle impalcature su cui i sacerdoti (neri corvi)
salgono mentre tutte/i assieme invadono gli spazi intendendo forse che ”tra i
pionieri della protesta si sono ormai arruolate le ragazze” e c’è una
comunità di donne e uomini liberi pronta a rompere con il mondo tradizionale
e gettare le basi di un nuovo ordine sociale. Tra le insegne del potere gli
hippies hanno anche una grande croce. Non ci hanno detto forse che la croce
non è un caso, un incidente sul lavoro? Cristo muore liberamente, non è
sorpreso dalla violenza del potere, la sua non è la morte legata alla
fragilità umana ma quella che tocca a quanti credono in Dio. Se però il
Natale è, in qualche modo, senso e valore comune, Pasqua è scandalo e follia.
Natale è un uomo che nasce: e che c’è di più consueto? Pasqua è un uomo che
risorge: e che c’è di più inconsueto, di inaccettabile? Il mondo tollerante
perché scettico, può accogliere anche un presepe in un giorno d’inverno ma
c’è una domenica di primavera in cui chi si ostina a credere che davvero la
morte è stata sconfitta ritorna ad essere un” ciarlatano ”come fu Paolo per
gli intellettuali pagani di Atene. Non la nascita ma la morte di Dio è un
evento che divide la storia dell’umanità. La parola di Dio nel film non è
cambiata, il paradosso è sempre il medesimo: il Messia era atteso da secoli e
quando si presenta non solo non viene accolto,ma gli specialisti in religione
lo condannano. Invano Lui ha cercato la fede dove avrebbe dovuto trovarla nei
sacerdoti, nei farisei, nei teologi, l’ha trovata, invece, nei pescatori,
nei peccatori, nelle prostitute. Esiste una sola storia, contemporaneamente
sacra e profana e l’incontro con Dio si realizza sempre e per tutti
attraverso lo spessore fragile del visibile umano. La mirra che Maria
Maddalena offre a Gesù allude simbolicamente solo a una parte della sua
triplice essenza, quella di uomo mortale. Osserviamo da vicino i personaggi
fondamentali per lo svolgimento degli even-ti: ecco Maria Maddalena ”la donna
peccatrice, peccatrice della carne che aveva espresso la sua cifra misogina”.
Nel lavoro di Norman Jewison ha una visibilità forte, importante, perché
riunisce in sé i molteplici aspetti della specificità femminile, capace di
vivere sentimenti assoluti, turbamenti profondi, di rassicurare l’altro, di
farsi anche da parte, disegnando la sua vita in relazione a Lui, semplicemente
un uomo, molto difficile però da amare, smuovere, interpretare. La scena che
la vede in una notte buia, sotto la tenda, assieme al Cristo, è molto
intensa; struggente il suo canto in quanto la consapevolezza le appartiene,
l’esperienza non le manca eppure sa che il suo futuro non può deciderlo da
sola. Ai piedi della Croce la Maddalena,coperta da un manto rosso, con il
capo chino, prende il posto di Maria, la Madre di Gesù; nella sublimazione
della passione d’amore partecipa della Passione di Cristo, si specchia nella
sua sofferenza, diventa una figura speculare e riconosce in Lui la propria
immagine: ognuno dei due fa sua la forza salvifica dell’altro.
|
|
Non
più la Madonna-madre, simbolo di un culto interamente costruito dal maschile,
non la donna distaccata e soprattutto muta ma una Maddalena vitale, frutto di
un’emancipazione laica, accompagna Cristo quasi a indicare che è necessario
fare ordine simbolico situando la donna sessuata accanto all’uomo nel posto
che le compete. È un Cristo giovane e bello quello che si manifesta nel film,
ricco di fascino, umano sino al miracolo, gioioso e amante della vita, che
non ebbe paura di sporcarsi, si sedette accanto alla donna perduta e si
lasciò toccare e baciare anche da lei. Giuda con il suo livore, il suo volto
buio, riporta invece in primo piano la questione della leadership che
all’epoca divide gli hippies con priorità anche sui contenuti, ci fa
intendere che l’ideologia prevale sulle idee e parla di giustizia in maniera
esasperata quasi a giustificare il suo tradimento e le tragiche conseguenze
generate dalla spinta radicale di giustizia predicata dal Cristianesimo. La
scena in cui corre nel deserto inseguito dai carri e dagli aerei da guerra
cantando ”Damned for all time” parla di un sogno mai concluso (Mettete dei
fiori nei vostri cannoni). Giuda è, in realtà, la voce del dissenso, degli
scettici, non si unisce al coro dei seguaci, guarda sempre da lontano e
dall’alto, cercando di ricordare a Cristo i suoi doveri: riscattare un popolo
oppresso, non perdere tempo con una come lei. ”Per eliminarci loro hanno
bisogno di un pretesto” incalza Giuda ma la risposta di Cristo è chiara: -Chi
sei tu per criticarla ?-. Quelli che fanno di Dio un giudice, hanno di Lui un
pagano e un pubblicano! Cristo è stato veramente un uomo ”mondano”, la sua
regalità non si svolge nella sfera del sacro ma nell’ambito dell’esistenza e
della storia profana, qui ha esercitato il suo magistero capovolgendo però le
regole del gioco. Chi dicesse che la religione ha unificato i popoli,
commetterebbe un errore storico, infatti i libri di storia sono pieni di
scomuniche reciproche e di trattati in tal senso. La sua non è stata la
religione della famiglia, della nazione, della maggioranza per cui il grido
di Giuda, che dall’aldilà ricorda a Cristo che forse il suo sacrificio è
stato inutile, perché Israele nel IV sec. non aveva mass media, mentre ora
avrebbe potuto raggiungere una nazione, sembra provocatorio, perché Egli si
presenta come ”impotenza di forza e onnipotenza d’amore”. Perché Giuda lo
denuncia ai sacerdoti del tempio? Seguiamo le parole del brano musicale che
dà il titolo al film “ Jesus Christ who are you? what have you sacrifice?
Jesus Christ Superstar, do you thinh you’ re what they say you are? (Gesù
Cristo, chi sei? Cos’hai sacrificato? Gesù Cristo Superstar, tu pensi di
essere quello che loro dicono tu sia?). Giuda insinua il dubbio che Gesù si
sia lasciato prendere la mano, non abbia saputo scindere il mito dall’uomo, abbia
cominciato a credere a quello che gli altri dicevano di lui, divenendo più
importante delle sue stesse parole, gli contesta il disinteresse per un
popolo occupato. Anche la folla gli chiede: -Gesù Cristo, ti batteresti per
me? e Simone: -Aggiungi un briciolo di odio per Roma e noi guadagneremo la
gloria e tu il potere Ma Cristo replica:-Non capite cos’è il potere, cos’è
la gloria-E a coloro che gli chiedono la guarigione dice: -Io son troppo
poco... non statemi addosso, lasciatemi in pace
|
|
Tutti
sembrano volerlo scuotere dal suo ostinato pacifismo e non è facile capire
che l’Uomo pacifico del Vangelo non misura il silenzio e le parole secondo
criteri di opportunità istituzionale e che si è dichiarato re solo quando
questa parola non correva il rischio di equivocità: ormai prigioniero,
abbandonato, davanti a Pilato, condannato al legno. Sul Golgota Cristo è solo
-il Singolo -proteso in un gesto di intatta fedeltà. Tutto intorno
l’abbandono, il silenzio anche di Dio. Il tema dell’abbandono di Cristo da
parte di Dio appare in molti passi del Nuovo Testamento. San Paolo dice: ”Dio
inviò il proprio figlio, nato da donna, nato sotto la legge, allo scopo di
riscattare quanti sono soggetti alla legge, allo scopo di conferirci
l’adozione filiale”. Nella costituzione della famiglia antica, per adottare
non si dovevano avere figli propri o, qualora ce ne fossero, bisognava
espellerli, abdicando alla patria potestas su di loro. Dunque,
probabilmente, Paolo pensa a questo. Dio in modo misterioso scaccia il figlio
per poter adottare gli estranei ! Nel film, in verità, non si dà valore ai
particolari narrativi ma all’analisi critica e realista dei fatti, anzi gli
elementi mistici della storia passano tutti in secondo piano, secondo una
rivisitazione alternativa e, forse all’epoca, piuttosto blasfema del
Vangelo, infatti lui il Cristo è visto solo come l’uomo che deve riscattare
il popolo palestinese da Roma e invece per megalomania si è lasciato influenzare
da tutta quella gente che lo credeva il Messia. L’attenzione si concentra sui
personaggi e sulle loro doti espressive e canore perché gli sfondi scenici
sono del tutto naturali e molto semplici anche i costumi degli attori che
indossano comuni camicie e jeans a zampa d’elefante come i tanti hippies del
tempo che vedono in Gesù il loro antesignano. Quello che ci viene presentato
è un evento che si radica nel tempo e nello spazio, cioè nella morte e in
una tomba, e che perciò ammette una verificabilità storica, ma esso fiorisce
nell’eterno e nel divino, ed è per questo che esige un’analisi nella fede e
nella teologia. Il film si conclude con la partenza degli hippies, sullo
sfondo resta la croce, simbolo di Colui che è stato un uomo ”storico” più
che un uomo ”religioso”. Nel suo Regno chi vince perde, il primo è chi arriva
l’ultimo, il successo è nel fallimento. È follia? Il film ci dice di sì ma
la storia è lì ad insegnarci che esiste tanta sapienza in quella follia e
che in Cristo Dio si è rivelato totaliter Alius da come lo pensa l’umana
ragione. Uno dei miti più grandi e potenti dell’Occidente, la Crocifissione
di Gesù, è divenuta una pellicola rock di grande successo che continua a far
discutere atei, agnostici
|
|
o
cristiani per l’audacia con cui l’immagine del Figlio di Dio viene accostata
a quella di una star, idealizzata e poi rinnegata, secondo i temi della
moderna favola pop. ” uperstar ” è la parola emblematica che stigmatizza la
storia degli ultimi giorni di Gesù, dall’entrata in Gerusalemme alla
crocifissione, vista attraverso gli occhi di Giuda, l’apostolo che tradì Gesù
e fu portatore del punto di vista dell’uomo, avido di potere solo terreno,
ostile al ruolo significativo assunto da Maria Maddalena.
|
|
Regia: Màrta Mészàros Interpreti
|
|
Maia
Morgenstern, Adriana Asti Elide Melli, Jan Nowicki Coproduzione: Italia
-Ungheria -Francia -Polonia
|
|
1995; Durata:
110 minuti; colore
|
|
Il Film “La
settima stanza” è l’ultimo film di Marta Meszaros, presentato a
Venezia nel 1995 fra le diverse iniziative organizzate in occasione della
Conferenza mondiale delle donne di Pechino.
|
|
Qui
comincia la storia raccontata dal film della Meszaros. Di questo film erano
state preparate 15 sceneggiature, ma la regista ha deciso di darne una
personale interpretazione limitandosi a rappresentare gli anni più difficili
della sua esistenza, evidenziando quegli aspetti della protagonista che
l’’hanno maggiormente colpita: la sua capacità di lottare contro ogni forma
di potere, in particolare contro quello nazista, le sue capacità di ricercare
dentro di sé in piena libertà interiore, le ragioni e le finalità del proprio
esistere. Nel film Edith spiega a una sua consorella che, la sera prima del
giorno dei voti, le chiede aiuto nella paura e confusione della grande
scelta, quale sia il percorso ideale dell’anima di cui parla Santa Teresa
d’Avila: “Il cammino che ci porta al centro di noi stessi passa per sette
dimore o sette stanze”. La giovane donna che non sarà mai suora intravede,
attraverso il racconto di Edith, la strada chiara che vuole seguire: il
desiderio di maternità troverà legittimazione da parte di Edith. Edith così
racconta: Nella I stanza l’anima è muta e sorda, ancora prigioniera
del mondo esteriore (qui comincia il suo percorso); nella II stanza l’anima
lotta contro le attrattive del mondo esteriore; nella III stanza l’anima
si purifica attraverso la meditazione, nella IV stanza domina
l’immaginazione: la conoscenza, l’intelligenza e la memoria pesano
sull’anima; nella V stanza il mondo profano non ha più influenza
sull’anima che è libera da ogni costrizione; la VI stanza è la camera
della sofferenza dove l’anima ha lasciato tutte le tentazioni del mondo e
aspetta...quello che si trova nella VII stanza che lei ancora non
conosce…”
|
|
Le tappe di tale percorso sono evidenziate nel film,
simboleggiate da passaggi, da “soglie” che continuamente si chiudono dietro
le spalle della protagonista nei vari periodi della sua vita. I diversi
momenti del film sono collegati dal personaggio di Franz Heller, un uomo che
ha abbandonato la scienza per servire il potere, perfettamente integrato nel
sistema nazista. In lui convivono odio, stupore, incomprensione per tutto ciò
che non riesce ad afferrare di Edith, ma che lo turba. Il rapporto madre –
figlia percorre tutto il film, amore materno e amore filiale che non riescono
a trovare l’incontro. Le annotazioni che la regista ci offre sulla madre e
sulle sorelle ci rendono partecipi di un continuo riferimento alla
genealogia femminile. La sorella Rosa infatti ripercorrerà le stesse scelte
di Edith, diventerà portinaia nel convento di Colonia e morirà con lei nel
campo di concentramento. La Meszaros nel film non sottolinea soltanto i
rapporti contrastati di Edith con Heller, la madre, la famiglia e
simbolicamente anche col popolo ebraico, ma sottolinea anche il conflitto con
se stessa e con la vita all’interno del convento, luogo di relazioni tra
donne che devono confrontarsi con la quotidianità. Il cammino interiore di
Edith, il cammino della Croce, viene accentuato dal volto particolarmente
intenso della protagonista (l’attrice rumena Maia Morgenster), viene messo in
evidenza attraverso varie scelte espressive della regista. Per esempio:
l’eliminazione al massimo dello spazio che circonda i personaggi; spesso la
macchina da presa indugia su porte, cancelli, finestre e ostacoli di diverso
tipo che si frappongono tra il mondo interiore di Edith con la sua ansia di
ricerca e il mondo esterno.
|
|
I colori
dominanti giallo e nero sembrano sottolineare i momenti dello spirito di
Edith (nero era l’abito degli ebrei e giallo la stella di David). La scelta
delle luci e delle ombre isola i personaggi per cui ogni episodio diventa
simbolico. Alcune immagini si ripetono e ci ricordano che stiamo assistendo a
un’ascesa spirituale. Penso alle diverse occasioni in cui Edith è allungata
per terra, con le braccia a forma di croce, a simboleggiare la partecipazione
alla passione di Cristo o all’immagine dell’entrata nella “settima stanza”
tutta bianca di luce, prima della visione finale di Edith stretta alla madre
in posizione fetale nella camera a gas in un ultimo grande abbraccio materno
-filiale, un abbraccio d’amore ed anche un abbraccio simbolico di
riconciliazione col popolo ebraico.
|
|
La
scrittrice: Edith Stein
|
|
Edith
Stein nasce a Breslavia il 13 ottobre 1891. Ebrea, orfana di padre, ultima di
sette tra sorelle e fratelli, riceve dalla madre una rigida educazione
ebraica. Edith è curata dalle sorelle più grandi e, d’intelligenza vivace,
fin da piccola si dimostra molto chiusa; non si confida con nessuno, nemmeno
con la madre che la predilige su tutti i figli\e perché è la più piccola e
perché è nata nel giorno del Kippur (festa dell’Espiazione).
|
|
All’Università di Gottinga, unica donna, studiò
filosofia con Husserl. Si laureò con la lode in filosofia nel 1916 a Friburgo
e a 25 anni diviene l’assistente di Husserl. È una donna curiosa e affamata
di verità. Leggendo il filosofo cattolico Max Scheler entra in contatto con
il Cristianesimo. Con la lettura della “Vita “ di Santa Teresa d’Avila
approda alla conversione, al cattolicesimo. Attraverso l’esperienza mistica
della santa intuisce che Dio è Amore. Nel 1922 ricevette il battesimo con il
nome di Teresa Edvige. Questo è per Edith un periodo di grande serenità
oscurato solo dal dolore di sua madre che non accetta la sua conversione.
Tutta la famiglia vive la sua scelta come un tradimento, un distacco dal
popolo ebreo. Da questa data fino al 1931 si ritira nel convento delle
domenicane a Speyer, dove insegna filosofia al liceo del convento. È molto
conosciuta nell’ambiente colto di quegli anni per i suoi scritti filosofici
e morali e viene spesso invitata per conferenze a Colonia, Monaco, Praga e
Vienna. Nel 1932 le viene offerta una cattedra universitaria a Munster e lei
comincia ad avvertire che qualcosa di terribile sta per accadere alla
Germania. Nel 1933 a causa delle leggi razziali è obbligata a lasciare
l’insegnamento all’Università. Nonostante le venga offerta una cattedra
universitaria nell’America Latina, Edith sceglie di entrare in un Carmelo,
convinta che la salvezza non stia nell’attività umana, ma nel portare la
croce assieme a Cristo. Nel 1934 si fa suora di clausura nel Carmelo di
Colonia.
|
|
La
regista: Marta Meszaros
|
|
Nata a
Budapest nel 1928, è figlia dello scultore Laszlo Meszaros fuggito in Russia
nel 1936 per sottrarsi al regime fascista e scomparso in seguito alle purghe
di Stalin. Marta torna in Ungheria nel 1946 giusto in tempo per sperimentare
di persona il socialismo dal volto umano e la crudele repressione durante la
rivolta del 1956. Certamente le sue esperienze personali, molto ben descritte
nei lungometraggi ”Diari” (Diario per i miei figli, Diario per mio padre e
mia madre, Diario per i miei amori), hanno creato un legame psicologico tra
la regista e la donna Edith Stein. La regista ha dichiarato di essere stata
colpita dalla figura di Edith Stein, morta a circa 50 anni nel campo di
Auschwitz, (prima di sapere che era stata beatificata da Papa Paolo Giovanni
II), dopo aver scoperto su un giornale di Cracovia la sua vicenda terrena. A
tale proposito la Meszaros dichiara, in un’intervista, di aver avuto
l’impressione che Edith abbia posseduto una forza tale da non farsi scrupolo
di lottare contro i mali della società e che quindi sia stata “uno spirito
libero che ha attraversato il suo tempo usando la forza per cercare una
verità interiore e non la conquista del potere”. La realizzazione di questo
film che la Meszaros ritiene il suo miglior film è stata lunga e difficile.
Affascinata dal profilo umano della Stein, dalle sue vicende umane ricche di
forza e di coerenza ha atteso 7 anni fino a quando ha trovato un produttore,
Francesco Panphili, e una casa di produzione, la Morgan film, che hanno
accettato la sua impostazione e la sua scelta. Non si può, però, comprendere
l’importanza di Edith Stein, una delle donne più significative del nostro
secolo, se non si conoscono le vicende della sua vita vissuta all’insegna di
una tensione altissima e di una ricerca costante del proprio Sé.
|
|
INDICE
|
|
|
Chi
siamo
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
. .
|
. .
|
pag.
|
3
|
|
Prefazione
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
. .
|
.
|
pag.
|
4
|
|
La donna
nel cinema e nella letteratura
|
|
|
|
Ragioneesentimento
|
-diAng Lee
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
.
|
pag.
|
9
|
|
MrsDalloway
|
-diMarleen Gorris
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
. .
|
.
|
“
|
15
|
|
|
MariannaUcrìa-diRoberto
Faenza
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
.
|
“
|
19
|
|
|
Lacasadeglispiriti-diBille
August
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
.
|
“
|
23
|
|
|
D’amoreeombra
|
-diBetty Kaplan
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
. .
|
“
|
28
|
|
|
Ilcoloreviola
|
-diSteven Spielberg
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
.
|
“
|
31
|
|
|
Donne e
relazioni fra donne
|
|
|
|
Piccoledonne-diGillian
Arm Strong
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
.
|
pag. 39
|
|
|
Camilla-diDeepa
Mehta
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
. .
|
. .
|
“
|
42
|
|
|
Gliannideiricordi
|
-diJocelyn Moorhouse
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
“
|
45
|
|
|
Annidipiombo-
|
diMargarethVonTrotta
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
“
|
47
|
|
|
L’alberodiAntonia
|
-diMarleen Gorris
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
“
|
50
|
|
|
Relazionipericolose
|
-diStephen Friars
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
“
|
53
|
|
|
Donne
nel cinema e nella storia
|
|
|
|
Shakespeareinlove
|
-diJohn Madden
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
pag. 59
|
|
|
Storiadiunacapinera
|
-diFranco Zeffirelli
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
“
|
63
|
|
|
Comeeravamo
|
-diSydney Pollack
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
.
|
“
|
67
|
|
|
LasceltadiSophie-diAlan
J. Pakula
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
.
|
“
|
70
|
|
|
Elisabeth-diShekhar
Kapur
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
. .
|
.
|
“
|
72
|
|
|
Donne e
religioni
|
|
|
|
Ilgiocodeirubini-diBoaz
Yakin
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
. .
|
pag. 79
|
|
|
Ilcerchio-diJafar
Panahi
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
. .
|
. .
|
“
|
82
|
|
|
AgnesediDio-diNorman
Jewison
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
.
|
“
|
85
|
|
|
Giovannad’Arco-diLuc
Besson
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
. .
|
“
|
88
|
|
|
Kadosh-diAmoi
Gitai
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
“
|
91
|
|
|
Yentl-diBarbra
Streisand
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
. .
|
. .
|
“
|
93
|
|
|
JesusChristSuperstar-diNorman
Jewison
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
“
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lasettimastanza-diMarta
Meszaros
|
.
|
.
|
. .
|
. .
|
.
|
.
|
“
|
100
|
* 103 *
|

|
Finito di
stampare del mese di giugno 2002presso la Litografia SudGrafica88060 Marina
di Davoli (Cz)Tel. 199 440 470
|
|
|





